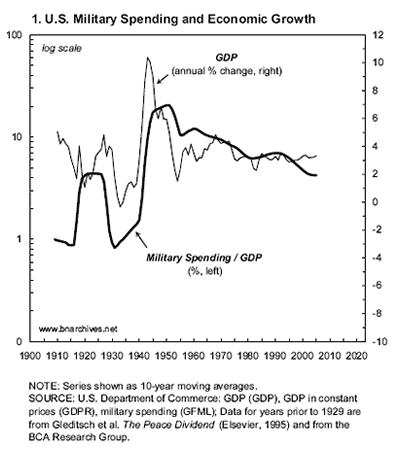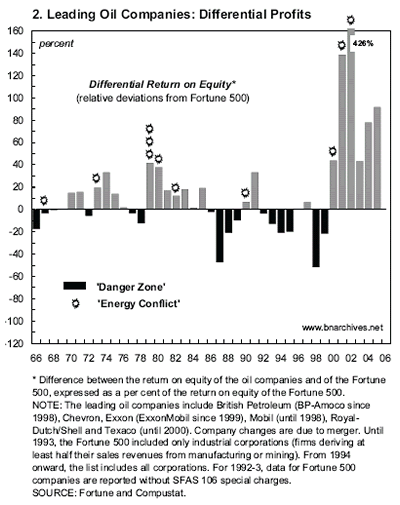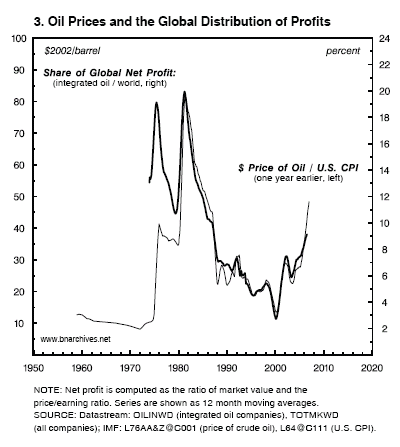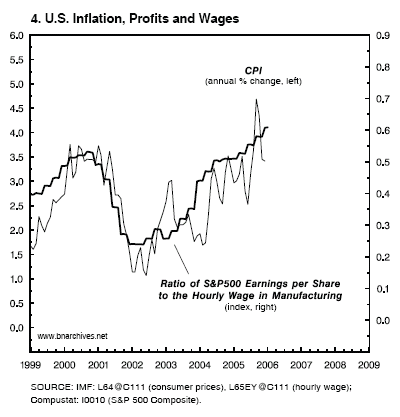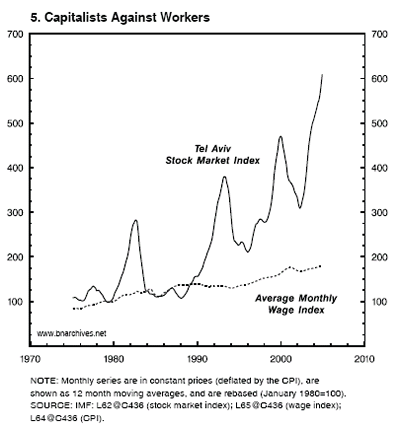Capitalismo e Guerra
dei professori Jonathan Nitzan e Shimshon Bichler
(Traduzione di Curzio Bettio di Soccorso Popolare di Padova)
Jonathan Nitzan insegna economia politica alla York University a Toronto (Canada).
Shimshon Bichler insegna economia politica in Istituti Superiori ed Università in Israele.
Molte delle loro pubblicazioni sono disponibili liberamente a The Bichler & Nitzan Archives.
Global Research, 16 Novembre 2006
Nota
editoriale
Portiamo all’attenzione dei lettori di Global
Research questa analisi accuratamente formulata, che sicuramente
provocherà riflessioni sulle politiche economiche di sostegno alle guerre nel
Medio Oriente. Comunque, il punto di vista espresso in questo articolo
rispecchia solo quello degli autori e non necessariamente quello del Centre for Research on
Globalization.
Le recenti tempeste di guerra – dall’Afghanistan e Iraq, a Gaza e il Libano – hanno ravvivato il discorso sull’imperialismo, sul Keynesianismo militarista e sul complesso militar-industriale.
Il capitalismo, molti “radicals” già da tempo hanno argomentato su questo, ha bisogno della guerra. Ha bisogno di espandere la sua sfera geografica; ha bisogno di aperture di nuovi mercati; ha bisogno di acquisire a basso prezzo le materie prime; e ha bisogno di placare le opposizioni interne e di pacificare le popolazioni che gli si rivoltano contro all’esterno.1
La percezione comune è che la guerra serve ad alimentare l’economia.
Conformemente a queste argomentazioni, i conflitti armati – e le elevate spese militari in vista di tali conflitti – producono una crescita globale e aiutano a ridurre la disoccupazione. Questa caratteristica della spesa militare si traduce in un efficace strumento finanziario. In anni di economia ristagnante, i governi possono imbarcarsi in un Keynesianismo militarista, in aumenti delle spese per armamenti, portando così l’economia fuori dalla recessione.
Cosa più difficile da far capire è che le spese militari indeboliscono le prospettive di pace e di civiltà dei regimi liberali. Le spese militari incrementano gli interessi di mercato delle grandi compagnie degli armamenti, rafforzano le prospettive degli apparati di sicurezza ed incoraggiano gli alti gradi dell’esercito. Nel contempo, questi gruppi si associano sempre più, a costruire un invisibile, ma potente, complesso militar-industriale – un complesso che con gradualità tende a dominare la politica e a spingere la società verso aggressioni esterne e verso avventurismo militarista.
La crescita e la caduta del Keynesianismo militarista
Le teorie sul sistema economico Keynesianismo militarista in associazione con il complesso militar-industriale sono divenute popolari dopo la Seconda Guerra Mondiale, e probabilmente per una buona ragione. L’eventualità della smobilitazione degli eserciti, in particolar modo negli Stati Uniti, apparve densa di allarmi. La dirigenza degli USA ricordava vivamente come la crescita vertiginosa della spesa militare aveva fatto uscire il mondo dalla Grande Depressione, e quindi temeva che la diminuzione dei bilanci per le spese militari avrebbe invertito questo processo. Se questo fosse avvenuto, le aspettative erano che il mercato sarebbe crollato, la disoccupazione avrebbe spiccato il volo, e sarebbe stata chiamata in causa perfino la legittimità del capitalismo a libero mercato.
Cercando di allontanare questa prospettiva, nel 1950 il Consiglio per la Sicurezza Nazionale degli USA stendeva un documento top-secret, NSC-68. Il documento, che veniva declassificato solo nel 1977, in modo esplicito raccomandava al governo di dare l’avvio a spese militari più alte, come modo di prevenire un tale esito.2 NSC-68 segnava la nascita del Keynesianismo.
Appare evidente dal grafico sottostante che le spese militari hanno avuto nei decenni successivi lo stesso andamento raccomandato dal documento.
Il processo fondamentale viene illustrato in Figura 1.
Il grafico mostra la relazione fra la crescita dell’economia degli USA e la spesa militare Statunitense. La linea sottile indica l’andamento della percentuale annuale del PIL di crescita economica, secondo la scala lineare di destra. La linea più scura mostra l’andamento della spesa militare, espresso in percentuale di PIL (Prodotto Interno Lordo: GDP – Gross Domestic Product ) e riferito alla scala logaritmica di sinistra.3 Entrambi gli andamenti vengono riportati come medie di dieci anni in dieci anni per mettere in rilievo le loro tendenze a lungo periodo.
[Figure 1. U.S. Military Spending and Economic Growth -
Spesa Militare USA e Crescita Economica]
I dati mostrano l’andamento parallelo dei due parametri, in modo particolare a partire dagli anni Trenta. L’aumento vertiginoso delle spese militari in vista della Seconda Guerra Mondiale coincide con un’imponente fase di espansione economica. La spesa militare raggiunge il 43% del PIL (GDP) nel 1944 e una media del 20% durante tutti gli anni Quaranta.
Questa crescita si accompagna ad un rapido sviluppo economico, con percentuali annuali che raggiungono il picco del 18% nel 1942 e un valore medio del 6% nel corso di tutti gli anni Quaranta.
Dopo la guerra, la spesa militare inizia ad avere una tendenza verso il basso, pur rimanendo a livelli molto alti per le due decadi successive. L’adozione del Keynesianismo militarista, durante le guerre in Corea ed in Vietnam, ha aiutato a conservare le spese militari al 12% del PIL durante gli anni Cinquanta e al 10% durante gli anni Sessanta. La crescita economica durante questo periodo raggiunge una media superiore al 4% – più bassa che nella Seconda Guerra Mondiale, ma rapida abbastanza per sostenere la capacità di recupero del capitalismo Americano e la fiducia dei suoi capitalisti.
Sia i grandi affari, che il lavoro organizzato hanno sostenuto questo andamento.
I grandi gruppi societari e finanziari hanno considerato la spese militari come una forma accettabile e perfino desiderabile di intervento governativo. Al livello aggregato, queste spese hanno contribuito a contrastare la minaccia di recessione domestica e a controbilanciare la perdita dei mercati civili procurata dai competitori dell’Europa e del Giappone – eppure senza indebolire la santità della proprietà privata e della libera impresa. Al livello disaggregato, molte imprese importanti hanno ricevuto contratti lucrativi dal Pentagono, sussidi governativi che anche i più incrollabili sostenitori del libero mercato si sono ben guardati dal rifiutare.
I grossi sindacati hanno appoggiato il Keynesianismo militare per varie ragioni. Hanno convenuto di starsene fuori dalle politiche interne e dalle relazioni internazionali, di accettare le grandi spese militari, e di minimizzare gli scioperi in modo da consentire e conservare la pace sociale. In compenso, hanno ricevuto lavoro sicuro, salari alti e la promessa di standard di qualità della vita sempre crescenti.
A proposito, il consenso veniva così riassunto nel 1971 dal Presidente Nixon, che dichiarava: “Ora, noi siamo tutti Keynesiani!"
Ma questo costituiva la punta massima del processo. Dai primi anni Settanta, la Coalizione Keynesiana fra grandi affari e lavoro organizzato comincia a dissolversi, il Keynesianismo militare inizia ad inaridirsi e la commistione stato sociale - stato di guerra, (welfare-warfare state), inizia il suo lungo declino.
La Globalizzazione del Possesso
Alla base della crescita e del successivo declino del Keynesianismo militare stava un capovolgimento epocale della natura delle economie specifiche della proprietà – un’inversione totale, da una graduale de-globalizzazione nella prima metà del XX secolo ad una massiccia globalizzazione nella seconda metà.
Fino a tutti gli anni Cinquanta, la proprietà capitalistica, negli Stati Uniti e altrove, si era ritirata all’interno dei propri bozzoli nazionali. Le sottolineature statistiche di questo processo sono evidenti. Nel 1900, la percentuale degli scambi con l’estero rispetto al PIL mondiale raggiungeva un picco del 19%. Ma il successivo sconvolgimento dovuto a due guerre mondiali, la depressione, la istituzione dei dazi doganali e il controllo sul movimento dei capitali avevano imposto un pesante tributo. Le connessioni con le proprietà all’estero venivano spezzate o congelate, e la percentuale degli scambi con l’estero rispetto al PIL mondiale diminuiva di continuo, arrivando ad un mero 6% nel 1960. Al punto minimo del processo, l’accumulazione di capitali veniva largamente esercitata all’interno dei confini nazionali.
Questo declino terminava all’inizio degli anni Settanta.
Ancora una volta, il Capitale rompeva il suo inviluppo nazionale, il neoliberismo e la deregolamentazione prendevano abbrivio e le proprietà e gli scambi con l’estero cominciarono ad aumentare. La percentuale degli scambi con l’estero rispetto al PIL mondiale vedeva una crescita esponenziale, raddoppiando ogni decennio: raggiungeva il 25 % nel 1980, prendeva quota al 50 % nel 1990, e si innalzava oltre il 90 % nel 2000.4
Gli effetti sul profitto di questa inversione di tendenza sono stati teatrali. Adesso, le imprese con sede centrale in America ricevevano grosso modo un terzo dei loro introiti dalle loro filiali all’estero, dal 5 % degli anni Cinquanta passavano ad una crescita percentualmente più alta di sei volte.
Questa inversione nel modello globale di proprietà alterava dalle fondamenta le strutture di potere e le istituzioni del capitalismo. Con l’acquisizione di capitali, la vendita su scala mondiale e l’aumento dei profitti realizzati all’estero, l’accumulazione capitalistica faceva sempre meno affidamento sui ricavi dalle vendite interne. Con una minore accentuazione sulle attività locali, le politiche Keynesiane non furono più di moda.
E con il Keynesianismo in declino, gli accordi fra imprese e sindacati cominciarono a liquefarsi.
Lo stato sociale, visto in precedenza come un baluardo contro il comunismo, divenne un fardello. Il sindacato non era più in grado di contrapporsi – in modo particolare quando i posti di lavoro venivano trasferiti verso i “mercati emergenti”, e con la partecipazione sindacale in declino.
Per di più, i capitalisti non avevano più timori per la recessione. Al contrario, spesso la incoraggiavano come mezzo per tenere sotto controllo i lavoratori, riducendo i salari e ribaltando le conquiste sociali ottenute con lotte dure dalla classe lavoratrice.
Quindi lo stato delle spese militari veniva messo sotto pressione. Il punto di svolta coincideva con il collasso del Blocco Sovietico. Con un’unica superpotenza rimasta sullo scacchiere, bilanci militari consistenti trovavano ora difficoltà ad essere giustificati. Negli anni Novanta, le spese militari nel mondo erano scese in picchiata, crollando per più di un terzo del limite massimo di sempre, raggiunto nei precedenti anni Ottanta.
Come mostra la Figura 1, le spese per armamenti negli Stati Uniti, con la spesa più alta fra tutti nel mondo, da un valore percentuale del 7% negli anni Ottanta diminuiscono, fino a raggiungere un valore medio del 4,5 % del PIL alla prima metà degli anni Duemila (N. d. tr.: da considerare la scala logaritmica a sinistra).
Le nuove Guerre
Il crollo del sistema Keynesianismo militare associato allo stato sociale apriva le porte alla nuova retorica del neo-liberismo.
I fautori del libero mercato salutavano il nuovo regime per le sue tendenze pacificatrici.
I detrattori erano d’accordo – ma solo parzialmente. Da un lato, concordavano che il neoliberismo, con la sua richiesta di liberi commerci in sicurezza e di flussi aperti dei capitali, tentava di consolidare la stabilità politica e la pace internazionale. D’altro canto, biasimavano il neoliberismo per la sua invisibile violenza, imposta attraverso l’iper-sfruttamento, la povertà di massa, l’aumento delle disuguaglianze, l’incertezza economica e l’insicurezza per gli uomini.
Comunque, sia i fautori che i critici venivano colti di sorpresa dalla repentina bellicosità dei primi anni del XXI secolo. Le vecchie teorie dell’imperialismo e del militarismo venivano improvvisamente rispolverate ed appoggiate al neoliberismo. Al posto dei miracoli della produttività e del “No Logo”, gli analisti cominciavano a parlare di "nuovo imperialismo" e "di guerre neoliberiste." Di fatto, per una gran parte, queste teorie ibride sono ingannevoli.
I nuovi conflitti del XXI secolo – le "guerre infinite," gli "scontri di civiltà," le "nuove crociate" – sono fondamentalmente differenti dalle "guerre di massa" e dai conflitti militari fra stati che hanno caratterizzato il capitalismo, dal XIX secolo fino alla fine della Guerra Fredda.
La principale differenza non sta così tanto nella natura militare dei conflitti, piuttosto nel ruolo più ampio che la guerra gioca con il capitalismo.
Per cominciare, in un mondo senza barriere agli affari, non esiste la necessità di conquistare fisicamente nuovi territori – ma materie prime e mercati addizionali ( notare che la produzione di petrolio Iracheno è quasi cessata dalla conquista dell’Iraq nel 2003, mentre il suo mercato di importazione dall’estero, trascurabile fino allora, vedeva contrattazioni.)
Lo stesso funziona per la spesa militare: visto l’aumento della percentuale di profitti provenienti dall’estero, non sussiste più di tanto l’imperativo affaristico per maggiori spese militari. Infatti i bilanci militari USA hanno visto una crescita marginale sull’onda delle nuove guerre – dal 3,9 % del PIL alla fine della Presidenza Clinton, all’attuale 4,7 % - questo è un aumento i cui effetti sulla domanda aggregata è insignificante secondo gli standard storici.
Anche le aggressioni degli anni Duemila condotte dagli USA hanno scarso senso militare. Paesi con potenzialità nucleari dimostrate, come il Pakistan e la Corea del Nord, non sono stati presi di mira, mentre altri che non presentavano un effettivo pericolo – nello specifico Afghanistan ed Iraq – venivano invasi, occupati ed attualmente limitati molto dalla presenza sul loro territorio dell’esercito USA, e non si vede fine a questa occupazione.
Per ultimo, l’appoggio televisivo alla guerra e le costanti esternazioni contro il terrorismo possono aver spaventato le popolazioni Occidentali. Ma, a differenza del consenso ricevuto dalle ideologie liberal-nazionaliste durante le due Guerre Mondiali e la Guerra Fredda che ne era seguita, la nuova retorica della “guerra infinita” non ha prodotto l’innamoramento delle masse per il capitalismo neoliberista.
Le guerre degli anni Duemila sono davvero nuove. E sono nuove, almeno in parte, perché il capitalismo stesso è cambiato.
Il Nuovo Ordine del Capitale
La mutazione centrale riguarda la natura che sta alla radice del capitale, una trasformazione che ha avuto inizio nello scorso XIX secolo, ma che è diventata evidente solo di recente.
Teorie esistenti, ancorate alla realtà del primo XIX secolo, continuano ad esaminare il capitale secondo una prospettiva “materialista” del consumo e della produzione. Gli economisti neoclassici vincolano le loro analisi ai servizi di utilità pubblica, mentre i Marxisti classici al tempo di lavoro.
In contrasto con questi approcci, noi pensiamo che, nelle condizioni attuali, il capitale non possa più a lungo essere considerato come un’entità “materiale”.
Come abbiamo visto, il capitale non rappresenta neoclassicamente i servizi pubblici e nemmeno il lavoro secondo la teoria Marxista, ma piuttosto il potere – il potere dei padroni nel modellare globalmente il processo di riproduzione sociale.
Sulla base delle nostre conoscenze del potere capitalistico, noi vogliamo dimostrare, primo, che l’analisi del capitalismo deve focalizzarsi non sul capitale "in generale" e sui molti capitali "in competizione", ma specificamente sui gruppi a capitale dominante al centro della politica economica. In secondo luogo, noi affermiamo che l’accumulazione non deve essere intesa in modo assoluto, ma differenziale – vale a dire, in relazione alla capacità del capitale dominante di “battere quello ordinario” ed aumentare così il suo relativo potere.5
Le implicazioni delle prospettive di questo potere sono ben lontane dall’essere raggiunte.
Per il nostro presente obiettivo, queste suggeriscono:
1. che le fusioni di imprese commerciali ed industriali, piuttosto che la crescita economica, sono diventate in modo straordinario, il motore principale dell’accumulazione differenziale (allargamento);
2. che, sotto determinate circostanze, il capitale dominante può avere grandi vantaggi dall’inflazione e dalla stagflazione, ( profondità).
[N.d.tr.: la stagflazione è una commistione di stagnazione ed inflazione, quando l’economia attraversa una fase simultaneamente di stagnazione (diminuzione della produzione) e di inflazione (aumento del livello generale dei prezzi). Tradizionalmente, i periodi di stagnazione dell’attività economica sono stati caratterizzati da caduta o deflazione dei prezzi. La spiegazione del fenomeno veniva ricondotta alla contrazione della domanda rispetto all’offerta di merci e di lavoro. In tempi più recenti altri meccanismi, come l’introduzione generalizzata nei paesi industriali di accordi di indicizzazione, nonché l’affermarsi di oligopoli a livello internazionale per il controllo delle materie prime, hanno concorso a fare dell’inflazione un fenomeno sempre più indipendente dal ciclo delle attività economiche e dell’occupazione. Gli stessi aumenti dei prezzi petroliferi possono essere indicati come altrettante cause di stagflazione.]
Nella nostra ricerca, noi abbiamo trovato che invece, per tutto il secolo scorso, l’accumulazione globale è oscillata tra questi due regimi, di fusioni e stagflazione. La fase più recente, che è durata per molti degli anni Ottanta e Novanta, chiaramente era una fase di allargamento.
In questo periodo, il capitale dominante ha tratto benefici dall’apertura orientata alla presa del controllo delle imprese della ex Unione Sovietica e di altri “mercati emergenti”, come pure dal collasso dello stato sociale e dalle massicce privatizzazioni dei servizi governativi di pubblica utilità.
Questa fase di allargamento, con la sua enfasi sul neoliberismo, sulla deregulation, su solidi sistemi finanziari e sulla disinflazione, è arrivata alla fine del suo ciclo con l’arrivo del nuovo millennio. La crisi finanziaria, che ha avuto il suo inizio in Asia ed in seguito si è estesa al nocciolo dei mercati, lo sgretolamento della "nuova economia" e le sue scandalose pratiche bancarie, il blaterare discorsi sul terrorismo globale e sulla guerra infinita per sconfiggerlo, tutto questo ha fatto in modo che i movimenti di capitali apparissero meno allettanti e le fusioni d’impresa ben lontane dall’essere promettenti.
Inoltre, due decenni di neoliberismo hanno indebolito il potere della politica dei prezzi, sollevando lo spettro della deflazione dei prezzi e del debito, e questo per la prima volta dalla Grande Depressione.
A fronte di queste situazioni, i capitalisti in genere, e i capitalisti dominanti in particolare, hanno cominciato a desiderare ardentemente piccole dosi di “sana” inflazione, sia per allontanare la deflazione del debito che per dare avvio all’accumulazione differenziale.
Da come sono andate le cose, la soluzione per la loro difficile situazione – in modo deliberato o altro – stava in un nuovo “conflitto per l’energia” nel Medio Oriente (cioè, un conflitto che riguardava direttamente o indirettamente il petrolio). Negli ultimi trentacinque anni, questi conflitti sono stati i principali animatori dei prezzi petroliferi, e i prezzi del petrolio hanno fornito la scintilla per l’inflazione su larga scala. Si trattava di un meccanismo chiavi in mano per scatenare l’inflazione, ed era pronto all’uso.
In questo senso, i conflitti militari sono arrivati indirettamente ad assumere un nuovo ruolo nel processo di accumulazione.
Fino agli anni Cinquanta e Sessanta, l’impatto principale dei conflitti armati agiva attraverso bilanci militari imponenti, che in modo diretto incrementavano la domanda aggregata, e nell’insieme i profitti, come pure le rendite dei principali appaltatori di forniture militari. Con la ri-globalizzazione della proprietà, ed in presenza di scenari di distensione, i bilanci per le spese militari hanno cominciato a contrarsi. All’inizio hanno subito un decremento relativo, una frazione del PIL, ma dagli ultimi anni Ottanta, hanno visto sicuramente una netta caduta, in termini di costanza del dollaro. Sebbene queste spese abbiano continuato ancora a nutrire le tasche degli appaltatori militari, il loro effetto diretto sull’accumulazione capitalista è diminuito in modo significativo.
Comunque, i conflitti armati come tali non hanno perso il loro fascino; producono ancora un grande impatto sull’accumulazione. La cosa nuova è che ora la loro influenza agisce per lo più indirettamente, attraverso l’inflazione, i prezzi relativi e la ridistribuzione.
Conflitti per l’Energia e Profitti Differenziali
I beneficiari importanti di questo nuovo, indiretto collegamento sono le grandi compagnie petrolifere. Il centro geografico di questo processo è il Medio Oriente.
Dopo la Guerra del Vietnam, il Medio Oriente è diventato il punto caldo del conflitto globale, con gli ovvi corollari per il prezzo del petrolio. Comunque, è stata posta una trascurabile, se non nulla, attenzione sulla relazione fra questi conflitti e i profitti differenziali delle compagnie petrolifere. [Per profitto differenziale si deve intendere la differenza fra il reddito di un fattore produttivo e il suo costo].
La ragione di questa trascuratezza non è difficile da capire. Molte analisi sui conflitti in Medio Oriente e il petrolio sono state collocate all’intersezione delle discipline riguardanti “le relazioni internazionali” e le “scienze economie internazionali”. Il loro ragionamento di base si può condensare su una lotta fra stati per le materie prime.
Da un lato troviamo i paesi industrializzati che necessitano di petrolio a basso prezzo per sostenere il loro sviluppo e la loro riproduzione estensiva. Sull’altro fronte vi sono i paesi del Medio Oriente, organizzati nell’OPEC, [Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio], intenzionati a ricavare dal processo quanto più denaro possibile. Questo largo divario viene complicato da diversi fattori: rivalità fra stati – per esempio, fra Stati Uniti e Unione Sovietica (nel passato), e fra Europa ed Asia (al presente); antagonismi religiosi ed etnici nel Medio Oriente stesso; o i differenti interessi dei vari settori e frazioni del capitale nei paesi industrializzati.
In questa disputa di alta politica e di economia delle risorse, pochi si sono interessati di andare oltre la complessiva facciata, ancora meno hanno fatto un lavoro sperimentale, e quasi nessuno ha trattato la questione di quanta accumulazione da parte delle compagnie petrolifere esattamente corrisponde al quadro delineato.
La Figura 2 fa luce su ciò che è stato trascurato dalla storia. Il grafico mostra l’andamento dell’accumulazione differenziale da parte del “Cuore Petrolifero” delle più importanti compagnie petrolifere – nello specifico, BP (BP-Amoco dal 1998), Chevron, Exxon (ExxonMobil dal 1999), Mobil (fino al 1998), Royal-Dutch/Shell e Texaco (fino al 2000).6 I cambiamenti nelle Compagnie sono dovuti alle fusioni.
[Figure 2. Leading Oil Companies: Differential Profits –
Compagnie Petrolifere Dominanti: Profitti differenziali]
Nel grafico, ogni barra misura la differenza tra il tasso di redditività del capitale proprio di queste compagnie e il tasso medio di redditività del capitale del parametro di riferimento “Fortune 500”, con il risultato espresso come percentuale del valore medio di Fortune 500.
(Fino al 1993, “Fortune 500” includeva solo corporations industriali, imprese che derivavano almeno metà delle entrate da vendite di manufatti o da attività minerarie. Dal 1994 in seguito, la lista include tutte le corporations. Per il 1992-3, i dati per le imprese Fortune 500 sono riportati senza gli oneri speciali SFAS 106.)
Le barre grigie mostrano gli anni di accumulazione differenziale; cioè, anni in cui le principali compagnie petrolifere vanno oltre la media con un più alto tasso di redditività. Le barre nere indicano periodi di decumulazione differenziale; cioè, anni in cui le principali compagnie petrolifere rincorrono la media. Per ragioni che in un momento diverranno evidenti, questi ultimi periodi segnalano “pericolo in Medio Oriente”. Per ultimo, i segnali di esplosione indicano “conflitti per l’energia” – vale a dire, conflitti che sono in relazione diretta o indiretta con il petrolio.7
Il grafico mette in mostra tre configurazioni correlate, tutte ragguardevoli per la loro persistenza.
La prima, ogni conflitto per l’energia in Medio Oriente viene preceduto da una zona “pericolo”, in cui le compagnie petrolifere stanno soffrendo una decumulazione differenziale.
La seconda, ogni conflitto per l’energia viene seguito da un periodo durante il quale le compagnie petrolifere vanno oltre la media.
La terza, con la sola eccezione del 1996-1997, le compagnie petrolifere mai riescono a superare la media senza che prima avvenga un “conflitto per l’energia”.8
Inoltre, questo diagramma si adatta ai più vasti processi di allargamento e profondità.
Il grafico indica tre distinti periodi, ognuno caratterizzato da un regime differente di accumulazione differenziale, ed ognuno condizionato da fazioni diverse all’interno del capitalismo dominante.
Durante l’epoca della profondità, anni Settanta e primi Ottanta, l’accumulazione differenziale veniva alimentata dalla stagflazione ed era favorita dai conflitti. La fazione principale all’interno del capitalismo dominante era la Coalizione “Dollari dalle Armi” – “Petrodollari”, fra industria degli armamenti e compagnie petrolifere. In questo contesto, le compagnie petrolifere riuscivano a superare la media comodamente, con battute d’arresto solo occasionali che venivano immediatamente corrette attraverso conflitti in Medio Oriente.
Durante il periodo dell’allargamento, ultimi anni Ottanta e anni Novanta, le fusioni si sono sostituite all’inflazione come strumento importante di accumulazione differenziale.
Le compagnie petrolifere e le industrie per gli armamenti perdevano la loro supremazia a fronte di una coalizione di "new economy" costituita da compagnie civili high-tech, ad alta tecnologia. La retorica neoliberista rimpiazzava il linguaggio tipico del sistema economico di Keynesianismo militare associato allo stato sociale, nel frattempo conflitti in Medio Oriente scoppiavano raramente, e le compagnie petrolifere comunemente inseguivano la media.
Gli
eventi dalla fine degli anni Novanta in poi indicano che il secondo periodo era arrivato alla conclusione,
con il declino della fase di espansione delle fusioni ed il ritorno alla supremazia
da parte della coalizione “Dollari dalle Armi” – “Petrodollari”. Quest’ultima
coalizione, le cui fortune erano scemate dal tempo del filone d’oro dovuto alla
stagflazione degli anni Settanta e dei primi anni Ottanta, ritornava a
prendersi la rivincita. Avendo concorso al reinsediamento alla Casa Bianca
della famiglia Bush, la coalizione cominciava a guardarsi attorno alla ricerca
di nuovi nemici ed era stata fin troppo felice di poter cogliere l’opportunità
offerta dalla “nuova Pearl Harbor” dell’11
settembre.9
Le proposizioni e le configurazioni statistiche presentate ora sono state
dapprima articolate alla fine degli anni Ottanta, quindi sviluppate alla metà
degli anni Novanta, e più di recente attualizzate nel 2006.10
Certamente, le considerazioni sull’ultimissimo periodo, che si possono derivare dalla Figura 2, sono nuove ed indicano uno scostamento sostanziale dai modelli del passato.
Fino alla fine degli anni Novanta, il rendimento differenziale delle compagnie petrolifere oscillava intorno al 50%, sopra o sotto il parametro di riferimento “Fortune 500”. Negli anni recenti, la scala è variata. Durante il periodo 2000-2005, le quattro compagnie petrolifere più importanti nel mondo realizzavano un profitto netto di 338 miliardi di dollari$ - un terzo di bilione – che rappresenta un tasso medio di redditività del 20%, quasi due volte quello delle “Fortune 500”.
La Supremazia dei Prezzi
La connessione che collega i conflitti in Medio Oriente e la redditività differenziale sta nel prezzo del petrolio.
Questa connessione viene illustrata in Figura 3.
La linea più scura nel grafico mostra il rapporto percentuale di profitto relativo a tutte le compagnie petrolifere elencate rispetto al profitto globale delle imprese (a destra).
La linea sottile mostra l’andamento del prezzo “relativo” del greggio (a sinistra), calcolato dividendo il prezzo in dollari per barile per l’indice dei prezzi al consumo CPI negli USA, con il ritardo di un anno (i redditi delle compagnie riportati rappresentano la somma dei movimenti degli ultimi quattro quadrimestri, quindi l’effetto globale sul profitto di una variazione nel prezzo del petrolio si sente solo dopo un anno).
[Figure 3. Oil Prices and the Global Distribution of Profits
I Prezzi del Petrolio e la Distribuzione Globale dei Profitti]
La correlazione fra le due serie di dati è assolutamente stretta.11 Questa realtà statistica mette in risalto l’immensa importanza che i prezzi hanno avuto nella direzione del processo di accumulazione.
In questo grafico particolare, la stretta correlazione trae vantaggio dalla discussione sui media e si serve delle analisi sul campo delle operazioni petrolifere.
Per conoscere la redditività differenziale delle compagnie petrolifere da un certo anno fino ad ora, non è necessario fare congetture sulla produzione massima di greggio, sulla domanda di petrolio sempre in aumento dalla Cina, o sulle ondate di calore che stanno investendo l’Europa. Questo tipo di congetture, sebbene interessanti per altri motivi, adesso non ci servono.
La sola cosa che ci serve per capire è il prezzo corrente del petrolio.
Ora , facciamo un passo indietro ed andiamo ad esaminare la storia secondo la Figura 3.
I dati mostrano che, durante le crisi petrolifere degli anni Settanta e dei primi anni Ottanta, il costo del greggio andava alle stelle. Nel 1979, un barile di petrolio superava i 90 $, ai prezzi odierni. Durante questi tempi allegri di stagflazione, le compagnie petrolifere si mettevano in tasca quasi il 20% di tutti i profitti globali. Ma, appena l’accumulazione differenziale si allargava e riprendevano le fusioni, crollava l’inflazione e i prezzi del petrolio si abbattevano anche più velocemente. La percentuale del profitto globale delle compagnie petrolifere collassava, raggiungendo un mero 3% alla fine della presidenza Clinton.
Il rovesciamento della situazione avveniva con il nuovo Millennio e con la presidenza Bush. Con l’invasione dell’Afghanistan nel 2001, il Medio Oriente entrava in un periodo protratto di guerra, i prezzi del petrolio balzavano a 65-75$, e la percentuale di profitto globale in favore delle compagnie petrolifere – pur non raggiungendo i massimi storici – si muoveva sempre più verso l’alto.
A quanto ammontano i profitti delle compagnie petrolifere? Durante il quinquennio, dall’agosto 2001 al luglio 2006, il profitto netto medio dell’intero settore petrolifero raggiungeva per anno i 108 miliardi di dollari$. Questa cifra si confronta con un profitto annuale di soli 34 miliardi di dollari$ nell’anno che va dall’agosto 1999 al luglio 2000 – un differenziale positivo di 74 miliardi di dollari$. E cosa è costato per generare questo differenziale verso profitti più alti?
Per amore della discussione, presumiamo che a partire dal 2000 l’aumento complessivo del prezzo del petrolio – e quindi l’aumento complessivo dei profitti derivati dal petrolio – sia dovuto ai nuovi “conflitti per l’energia” nel Medio Oriente. Inoltre assumiamo che sin qui il governo degli USA abbia speso nelle sue operazioni in Afghanistan - Iraq l’equivalente annuale dell’1% del suo PIL – all’incirca 100 miliardi di dollari$ all’anno.
Questi assunti, sebbene semplicistici ed imprecisi, corrispondono alle grandezze complessive implicate: la guerra costa all’anno 100 miliardi di dollari$ e produce un extra pari a 75 miliardi di dollari$ di profitti annuali dal petrolio. In altre parole, per ogni dollaro che il governo USA spende per le guerre, il capitale delle compagnie petrolifere guadagna in profitto netto un’addizionale di 75 cents.
Chiaramente, questi fenomenali rapporti costi-benefici possono essere generati solo indirettamente. E questo è forse una delle più importanti caratteristiche delle nuove guerre: una crescita abbastanza modesta nelle spese militari determina massicce variazioni nei prezzi e nella distribuzione – variazioni che vanno al di là delle immediate operazioni del conflitto, e la cui entità può pareggiare ed anche superare lo stesso bilancio militare.
La dolce Inflazione
Come sottolineato in precedenza, le nuove guerre sono arrivate quando la lunga fase di allargamento dell’accumulazione differenziale si stava allentando. I diretti beneficiari sono stati gli appaltatori degli armamenti e le compagnie petrolifere della coalizione “Dollari dalle Armi –Petrodollari”. Ma con gradualità, quando l’accumulazione differenziale globale si è trasferita dalla fase di allargamento a quella di profondità, i profitti si sono estesi al capitale dominante nel suo complesso.
La Figura 4 illustra in modo efficace questo processo per gli Stati Uniti.
La linea sottile nel grafico indica la percentuale di inflazione, misurata come percentuale annuale di variazione dell’indice dei prezzi al consumo, CPI. La linea più scura indica un rapporto fra profitti e salari. Viene misurato il rapporto fra gli introiti azionari di S&P 500 (le più grandi compagnie pubblicamente negoziate registrate negli Stati Uniti, che possono essere prese come procura per il capitale dominante) e il saggio salariale orario nell’industria manifatturiera, di trasformazione.
[Figure 4. U.S. Inflation, Profits and Wages
Inflazione negli Stati Uniti, Profitti e Salari]
I movimenti in quest’ultimo rapporto indicano la ridistribuzione: quando l’indice sale, significa che i profitti del capitale dominante aumentano più velocemente, (o si abbassano più lentamente), del saggio salariale. Quando l’indice decade, si innesca il processo opposto – vale a dire che i profitti del capitale dominante decadono più velocemente, (o aumentano più lentamente), dei salari. Come mostrato dal grafico, alla fine del 2000, l’inflazione iniziava a diminuire, e nel 2002 raggiungeva l’1% – un minimo postbellico. L’abbassamento si accompagnava ad una caduta del rapporto dei profitti rispetto ai salari, dal 55 % relativo al suo picco del 2000 (indice a destra pari a circa 0,5).
Sull’onda di questi sviluppi, il Presidente del Consiglio della Federal Reserve, Alan Greenspan, metteva in guardia per questa “sgradita e importante caduta dell’inflazione” e riceveva l’appoggio dei principali operatori finanziari ad “andare verso una inflazione più alta”. 12
Questi allarmi deflattivi venivano nell’aprile 2003, dopo che gli USA avevano già invaso l’Iraq. Allora, il nostro punto di vista era piuttosto differente. Nel gennaio 2003, proprio prima dell’invasione, abbiamo scritto:
". . . se i prezzi del petrolio continuano a salire, con tutta probabilità l’inflazione si conformerà, verrà rimosso lo spettro della deflazione e le grandi compagnie potranno tirare un grosso sospiro di sollievo. Per queste compagnie ci potrebbe essere anche una ciliegina sulla torta. Di solito, l’inflazione opera nel ridistribuire reddito dal lavoro al capitale e dalle piccole imprese a quelle più grandi. Dunque, le grandi compagnie guadagneranno abbastanza di più, se non proprio completamente.” 13
E comunque, Greenspan non ha dovuto lavorare troppo duramente. Al posto suo, sono state le nuove guerre a fare il lavoro. I neo-conservatori hanno inviato il loro esercito nel Medio Oriente, il prezzo del greggio è volato alle stelle, e l’inflazione – sebbene con una certa esitazione all’inizio – alla fine ha cominciato a prendere la stessa direzione.
Gli effetti distributivi non si sono sprecati per gli investitori e i lavoratori. Mentre i salari rimanevano piatti, i profitti – in particolare quelli introitati dal capitale dominante – montavano. Come risultato, il rapporto dei profitti rispetto ai salari saliva rapidamente – raggiungendo il 250 per cento dal 2001 e lanciando il rapporto complessivo del profitto rispetto al PIL al suo più alto livello a partire dalla data in cui si è cominciato a raccoglierne i valori nel 1929.
L’enorme impatto distribuzionale di una piccola crescita nell’inflazione è sintomatico del nuovo ordine. Durante il sistema economico Keynesianismo militare associato allo stato sociale (welfare-warfare state), l’inflazione di solito implicava una spirale salari-prezzi che operava nel limitare le crescite differenziali dei profitti. Ad esempio, un aumento percentuale del 4% dei prezzi aveva la caratteristica di accompagnarsi ad una crescita dei salari, diciamo del 3%. Come risultato, il rapporto di margine dei profitti dalle vendite rispetto ai salari vedrebbe una crescita dell’1%, producendo una crescita relativamente modesta nei profitti. Attualmente, la situazione si presenta veramente diversa.
I lavoratori degli Stati Uniti sono costretti in una competizione globale con i lavoratori Cinesi, dell’India e di altri “mercati emergenti”, e questo significa che i salari non aumentano – anzi qualche volta diminuiscono – durante la fase di inflazione dei prezzi. In questo contesto, una percentuale di inflazione del 4% si tramuta in una percentuale di crescita del 4% del margine di profitto, e quindi in una ben più larga crescita dei profitti.
In conclusione, le nuove guerre sono per questo certamente convenienti. A costi minimi, provocano inflazione e generano grande crescita nei profitti.
Ma le guerre economicamente convenienti presentano un altro aspetto. Sono dure da vincere!
Guerre economicamente convenienti
L’idea di un esercito di massa, “di volontari”, era scaturita dalla Rivoluzione Francese. I nuovi soldati risultavano essere più convenienti e più leali dei mercenari, ed inoltre combattevano bene. Comunque, le masse necessitavano di essere educate, in modo tale che potessero leggere i giornali e conformarsi alla propaganda – ecco la nascita di una scolarizzazione “elementare” obbligata. Più tardi, i proletari cominciarono ad esigere vantaggi addizionali. Volevano cultura, assicurazioni, previdenze e pensioni, indennità per i combattenti. Nei primi due decenni del XX secolo, le élites li ingannarono. Mandarono le masse a farsi macellare a milioni nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, per abbandonare poi al loro destino i veterani al ritorno. Questa esperienza ha alzato la posta in gioco. All’inizio degli anni Quaranta, ai soldati-cittadini veniva offerta una completa protezione sociale, in modo che fossero ben disposti ad andare a farsi massacrare, ancora, nella Seconda Guerra Mondiale. Quelli che all’inizio apparivano come “soldati gratis” si rivelarono essere un tipo piuttosto costoso di combattenti di guerra.
L’ultima guerra costosa è stata quella del Vietnam.
Con la globalizzazione neoliberista, che ha sostituito il sistema economico Keynesianismo militare associato allo stato sociale, non esiste più la necessità di eserciti di massa con alte spese generali. Invece, i capitalisti hanno cominciato ad investire in “armi intelligenti”, che possono essere manovrate da personale che si è ritirato dalle scuole superiori e che producono il massimo della devastazione. L’esercito di leva è stato abbandonato in favore di eserciti meramente professionali – in parte governativi e in parte privati.
Un processo del tutto simile ha preso piede anche in Israele.
Nel corso degli anni Settanta, durante il periodo Israeliano del sistema economico di Keynesianismo militare associato allo stato sociale, le spese militari ammontavano al 25% del PIL, la leva prevedeva il ricorso ai cittadini Ebrei, (con l’esclusione degli ultra-ortodossi), e il governo spendeva pesantemente anche per i servizi sociali. Ma in regime di allargamento degli ultimi anni Ottanta e degli anni Novanta, i capitalisti Israeliani sempre meno divenivano dipendenti dall’economia di guerra. Israele dava inizio a movimenti di riconciliazione con gli stati Arabi confinanti, e l’esercito veniva ridotto e trasformato. Le spese militari crollavano al 6% del PIL, e molte attività militari venivano privatizzate. La durata del servizio militare veniva raccorciata, e ancor meno erano gli uomini che venivano arruolati. Contemporaneamente, i servizi e le tutele sociali venivano progressivamente smantellati, con consistenti erosioni nei campi della pubblica istruzione e del servizio sanitario. Centinaia di migliaia di lavoratori stranieri venivano introdotti e i sindacati dei lavoratori venivano considerati come istituzioni puramente simboliche.
Le conseguenze di questo processo sono illustrate in Figura 5.
Il grafico mette in rapporto l’andamento medio mensile dei salari con l’indice del mercato azionario di Tel Aviv, entrambi espressi in prezzi costanti e riferiti, in funzione del confronto, al gennaio 1980, fatto=100).
[Figure 5. Capitalists Against Workers
Capitalisti contro Lavoratori]
La figura mostra che, fino ai primi anni Novanta, la fortune dei lavoratori e dei capitalisti si sono mosse, più o meno, in tandem. Ma con l’avanzata del regime di allargamento, le loro strade si sono dipartite. Durante gli anni Novanta e nei primi anni Duemila, i salari vedevano una crescita stentata, mentre i profitti del capitale raggiungevano quote stratosferiche.
I riservisti Israeliani, che ora stanno per essere chiamati a combattere una guerra che sta per esplodere, probabilmente non hanno visto questo grafico, ma la realtà che sta dietro a questo, a loro è sicuramente famigliare. Loro sanno del deteriorarsi dei servizi sociali, conoscono la precarietà del lavoro, sanno del costo eccessivo per la casa, si rendono conto della perdita di spazi aperti e del verde. Loro sanno che rimanere feriti in guerra è un brutto affare che rende magre indennità. E cosa più importante, loro sanno che l’élite che li manda a combattere, in realtà, di loro non gliene importa niente.
Questi sentimenti sono assolutamente espliciti e si manifestano con regolarità nella stampa.
Quello che segue è un tipico documento delle difficoltà che devono affrontare i riservisti:
“Il Ministro della Difesa Amir Peretz si è rifiutato di adottare una legge che consenta ai riservisti dell’Esercito (IDF-Forze per la Difesa di Israele), richiamati recentemente in servizio, di usufruire di esenzioni sulle ammende e sugli interessi collegati a forme debitorie in cui possono incorrere durante il loro periodo di richiamo.
I riservisti sono furiosi dopo aver scoperto che saranno sicuramente tenuti a pagare le more e gli interessi anche se capitasse di non essere in grado di emettere i pagamenti per assenza dovuta al loro richiamo. Alex Minkovsky, uno dei leaders delle organizzazioni dei riservisti, ha dichiarato: I riservisti sono dimenticati, ogni volta ci dimenticano. Noi pretendiamo che il Ministro della Difesa Amir Peretz si occupi della nostra condizione sociale, che si dia una mossa e che faccia qualcosa. Noi siamo sommersi da richieste di informazioni da parte di riservisti che stanno soffrendo situazioni di crisi giorno dopo giorno.” 14
Il capitale dominante non ha di queste rimostranze.
Quando questo documento è stato pubblicato, il giorno prima il Ministro della Difesa Peretz si era rifiutato di dare ascolto all’appello dei riservisti, il suo governo aveva privatizzato le raffinerie di petrolio nazionali per 800 milioni di dollari$.
In un’intervista, l’offerente vincitore della licitazione, Tzadik Bino, aveva l’aria quasi imbarazzata:
"Lo stato non avrebbe dovuto privatizzare le raffinerie, e nemmeno avrebbe dovuto privatizzare El-Al [le aviolinee nazionali], Bezeq [la compagnia nazionale telefonica] e Magen David Adom [il servizio medico di pronto soccorso]. . . . Il prossimo passaggio potrebbe essere la privatizzazione di IDF. . . . Noi stiamo ancora lottando per la nostra esistenza, e non possiamo pagare per il trasferimento delle strutture strategiche nelle mani dei privati.” 15
Il vecchio sistema economico di Keynesianismo militare associato allo stato sociale era dominato da capi, figure carismatiche, da "leaders" come Churchill, de Gaulle e Ben Gurion che sembravano avulsi da qualsiasi interesse “particolare”.
Di contro, lo stato neoliberista tende ad essere popolato da conservatori – alcuni di questi, corrotti e criminali – come Bush, Chirac, Berlusconi, Sharon, Netanyahu ed Olmert, che non cercano nemmeno di nascondere i loro veri interessi e collegamenti stretti e fedeli. L’élite capitalista, che riceve servizi da costoro e sostiene questi politicanti, mal sopporta un deciso attaccamento alla nazione.
Molte delle grandi imprese Israeliane sono possedute da investitori esteri e da compagnie multinazionali. Allo stesso modo, i grandi capitalisti Israeliani – da Recannatis, a Fishman a Khan – sono diventati investitori globali. Per loro, Israele è solamente uno dei posti dove svolgere attività finanziarie in un portfolio diversificato mondiale. A differenza di quello che succedeva durante gli anni Settanta, quando questi capitalisti avevano tutte le loro uova nello stesso paniere di Israele, ora non hanno più necessità di preoccuparsi troppo di quello che avviene nel loro paese. Le loro partecipazioni locali rappresentano solo una frazione dei loro investimenti, e possono sicuramente essere messe in vendita.
Una recente citazione dalla sezione finanziaria del quotidiano Ha’aretz, riportata nel mezzo del conflitto in Libano e a Gaza, dimostra che l’espansione verso una tale diversificazione di attività finanziarie all’estero è stata accettata come naturale dagli investitori “ordinari”:
“ Oltre ai ‘normali’ rischi dei mercati emergenti come la Cina, il Brasile o la Russia, Israele ha il rischio continuo della sicurezza…Questo rischio non può essere ignorato anche in tempo di pace. Per questo, la diversificazione globale degli investimenti non è uno sfizio. È una necessità…Questo significa che, nell’interesse di una riduzione del rischio, gli investitori Israeliani hanno da allocare in permanenza una quota fissa delle loro attività finanziarie su investimenti esteri. Ma quanto questa quota è ‘bastante’? Fino a poco tempo fa, si conveniva su una quota del 25%, ma probabilmente la percentuale delle attività finanziarie con l’estero dovrebbe salire al 50%. I nostri corpi devono rimanere qui. Ma per quale motivo dovrebbero anche i nostri risparmi soffrire la stessa sorte?” 16
Sotto queste circostanze, c’è poco da meravigliarsi che la “macchina da guerra” di Israele abbia perso molta della sua incisività militarista. L’incentivazione a combattere per “il proprio paese”, quando questo paese è tanto frantumato dal punto di vista sociale, si riduce di molto – specialmente quando si devono affrontare organizzazioni combattenti, innervate fortemente con le loro società ed altamente motivate da spirito religioso.
E così le guerre economiche perdurano, aumentano le morti e le distruzioni, e i profitti continuano ad accumularsi.
Note
1. Non tutti gli analisti “radical” condividono questo punto di vista. Al contrario, alcuni arguiscono che la guerra e la militarizzazione, sebbene innervate e spesso provocate dalla realtà capitalista, recano danno al capitalismo e indeboliscono la sua vitalità.
2.
Consiglio per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, NSC 68:
United States Objectives and Programs for National Security. A Report to the President Pursuant to the
President’s Directive ofJanuary 31, 1950. Top Secret. ( NSC 68: Obiettivi e Programmi per la Sicurezza Nazionale
degli Stati Uniti. Un documento per il Presidente conforme alle direttive
Presidenziali del 31 gennaio 1950. Top Secret.). Washington DC, 1950.
3. Una scala logaritmica ha l’effetto di amplificare sul grafico le dimensioni dei valori di più piccola entità e di comprimere quelle dei valori più alti. Questa trasformazione risulta utile quando si verificano scarti veramente alti nei dati – come quelli durante gli anni Quaranta – scarti che d’altro canto si verificherebbero troppo deboli da essere valutati sul grafico per variazioni relative ai più piccoli valori.
4. I dati sulla percentuale degli scambi con l’estero rispetto al PIL mondiale sono derivati da Maurice Obstfeld e Alan M. Taylor, Global Capital Markets: Integration, Crisis and Growth – Mercati globali dei capitali: integrazione, crisi e sviluppo (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), pp. 52-53, Tavola 2-1.
5. Queste problematiche vengono articolate da Jonathan Nitzan e Shimshon Bichler, "Dominant Capital and the New Wars, - Il capitale dominante e le nuove guerre" Journal of World Systems Research – Bollettino sulla ricerca dei sistemi nel mondo, 2004, Vol. 10, No. 2, pp. 255-327.
6. Dovuti alle fusioni, i dati in Figura 2 riguardano la British Petroleum fino al 1997 e la BP-Amoco dal1998; la Chevron e la Texaco fino al 1999 e la Chevron-Texaco dal 2000; la Exxon e Mobil fino al 1998 e la ExxonMobil dal 1999; e la Royal-Dutch/Shell per tutta la durata.
7. Questi conflitti comprendono la guerra Arabo-Israeliana del 1967; la guerra Arabo-Israeliana del 1973 ; l’invasione del Libano da parte di Israele del 1979; la Rivoluzione Iraniana del 1979; l’invasione Sovietica dell’Afghanistan del 1979; l’inizio della guerra Iran-Iraq del 1980; la prima Guerra del Golfo del 1990/1; l’inizio della seconda Intifada del 2000; l’invasione dell’Afghanistan da parte della Coalizione nel 2001; e l’invasione dell’Iraq da parte della Coalizione nel 2003 (la cui preparazione era stata pubblicizzata già nel 2002).
8. Sebbene nel 1996-7 non vi sia stato un conflitto “ufficiale”, si è verificata violenza più che sufficiente, che ha visto un’invasione da parte dell’Iraq di zone Curde e attacchi USA con uso di missili da crociera.
9. Nel 2003, quando si è scatenata la guerra Irachena, abbiamo scritto il testo seguente:
"Noi pensiamo che i conflitti in Medio Oriente siano parte integrante dei processi di potere dell’accumulazione globale…In questi processi, la Coalizione “Dollari dagli armamenti-Petrodollari” è entrata in commistione in modo sempre più stretto da un lato con i governi suoi “affini”, e d’altro canto con i suoi paesi “ospiti” OPEC, dando luogo ad una simbiosi “capitale-stato” sempre montante. Che questo sia stato frutto o no di un “complotto”, e quale sia stata la precisa natura di un simile “complotto”, rimane una questione aperta. Sfortunatamente, questo tipo di argomenti non costituiscono gli ingredienti principali dei programmi televisivi di prima serata. Occasionalmente, comunque, la verità viene alla luce, sebbene con qualche ritardo…Forse, a tempo debito, qualcuno pubblicherà i segreti “Incartamenti Exxon” o il declassificato “NSC Report on Energy and War in the Middle East – Documento NSC sull’Energia e Guerra in Medio Oriente”, e si aprirà una finestra sul retroscena di queste storie sui Conflitti per l’Energia in quell’area.” ("Dominant Capital and the New Wars, Il capitale dominante e le nuove guerre" Journal of World Systems Research – Bollettino sulla ricerca dei sistemi nel mondo", 2004, Vol. 10, No. 2, p. 313).
Come è avvenuto, i documenti specifici sono emersi piuttosto rapidamente. Meno di un anno dopo la pubblicazione del nostro documento, Greg Palast ha scoperto l’esistenza di due piani segreti – e piuttosto differenti – per il futuro del petrolio Iracheno. Palast argomentava che l’invasione dell’Iraq del 2003 rispecchiava le strategie contrastanti delle due opposte fazioni.
La prima, la più vociante, guidata dai neo-cons e dal Pentagono, progettava di privatizzare il greggio Iracheno, inondare i mercati e scalzare l’OPEC.
L’altra fazione, con alla testa le grandi compagnie petrolifere ed elementi all’interno del Dipartimento di Stato, non condivideva nessuna di queste fantasie. “Si lascino pure i neo-cons terminare il lavoro di conquista dell’Iraq, e poi mandiamo i nostri rappresentanti ad assumere il controllo della produzione di petrolio del paese.”
In conclusione, non sono avvenute privatizzazioni, nessuna inondazione dei mercati e nessun indebolimento dell’OPEC – un’organizzazione di cui gli Stati Uniti, come governanti dell’Iraq, ora sono divenuti membri de-facto.
Vedi Greg Palast, "Secret US Plans for Iraq’s Oil – I piani segreti USA per il petrolio Iracheno" BBC News, 17 marzo 2005; Greg Palast, Armed Madhouse – Manicomio armato (New York: Dutton, 2006).
10. Jonathan Nitzan e Shimshon Bichler, "New Imperialism or New Capitalism?" Review, 2006, Vol. XXIX, No. 1, pp. 1-86.
11. Il coefficiente di correlazione tra due serie mensili misura 0.80 per il periodo dal gennaio 1974, e 0.92 per il periodo dal gennaio 1979.
12. Alan Greenspan, "Testimony of Chairman Alan Greenspan Before the Joint Economic Committee, - Dichiarazione testimoniale del Presidente Alan Greenspan davanti alla Commissione Congiunta per l’Economia" Congresso USA, 6 maggio 2003; Bill Dudley e Paul McCulley, "Greenspan Must Go For Higher Inflation, - Greenspan deve agire per un’inflazione più alta" Financial Times, 23 aprile 2003, pp. 17.
13. Jonathan Nitzan e Shimshon Bichler, "It's All About Oil, Tutto ruota attorno al petrolio" News From Within, Vol. XIX, No.1, gennaio 2003, p. 11.
14. Tani Goldstein, "Reservists Want Peretz to Okay Perks, - I riservisti chiedono a Peretz di dare il via a benefici accessori" Ynet, 1 agosto 2006.
15. Tani Goldstein, "Bino to Ynet: 'There Was No Need to Privatize the Refineries.'– Bino a Ynet: non era necessario privatizzare le raffinerie." Hebrew, Ynet, 1 agosto 2006.
16. Ami Ginsburg, "What Did We Learn From the First Two Weeks of the Second Lebanon War? – Cosa abbiamo imparato dalle due prime settimane della Seconda Guerra del Libano" Hebrew, Ha'aretz, 28 luglio 2006.
***************************************************************************
L’indirizzo url di questo articolo a : www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=%20NI20061116&articleId=3890