Cristina Carpinelli: Donne e povertà nella Russia di El’cin. L’era della transizione liberale.
Prefazione di Marina Piazza. Milano, Franco
Angeli, 2004, pp. 251, Euro 20,5.
In Russia, gli uomini e le donne hanno nominalmente gli stessi diritti
garantiti dalla nuova Costituzione del 1993. Ma, di fatto, le cose non stanno
così. Anzi, le discriminazioni sono in forte aumento. Il divario retributivo
tra i sessi, l’alto tasso di disoccupazione femminile, la totale assenza delle
donne dai posti di potere, l’aumento della violenza in ambito domestico, la non
corresponsione degli assegni di mantenimento in caso di divorzio e la mancanza
di risorse e programmi per tutelare le donne incinte e i bambini, tutto ciò può
essere considerato una vera violazione dei diritti delle donne russe. Una
situazione che lo scioglimento dell’Unione sovietica, la trasformazione
politica, ma soprattutto la transizione verso un’economia di mercato hanno
contribuito ad esasperare.
Si era sempre pensato che gli ex paesi dell’Urss avessero rispettato tre dei
principi basilari sui quali si fonda ogni vera democrazia: parità di diritti
tra i sessi, partecipazione femminile alla forza lavoro e realizzazione di una
rete di servizi tale da consentire alle donne di conciliare maternità e lavoro.
Ma non sempre questi principi hanno trovato riscontro nella realtà. In più, le
ex Repubbliche sovietiche segnano gravemente il passo per quanto riguarda lo
sviluppo di movimenti autonomi delle donne. Solo nella Federazione russa, sono
nate e cominciano ad avere un loro peso le Organizzazioni non governative (Ong)
femminili. Gravi ritardi si sono registrati anche nel campo della ricerca. Fino
allora nessuna di quelle ex Repubbliche aveva affrontato, studiato seriamente
le tematiche femminili: poiché gli indicatori d’istruzione e d’occupazione
delle donne erano molto più alti che in altri paesi, era comune credenza che le
questioni di genere non meritassero particolare attenzione.
Il clima che si è creato nella Russia indipendente non solo è il risultato di
un’economia claudicante, poiché anche la situazione legale ha giocato la sua
parte. Non serve, infatti, inserire nella legislazione norme che proibiscono la
discriminazione, senza istituire organi e meccanismi che ne curino la reale
applicazione. Occorre un sistema legale tale da permettere di portare le
violazioni davanti ad un tribunale. Sotto la pressione delle organizzazioni
femminili è stato adottato un nuovo codice di famiglia, sono stati varati
provvedimenti per tutelare la salute e la maternità. Sono state elaborate
proposte di legge, a livello centrale e locale, contro la violenza domestica e
gli stupri. È stato fatto anche un tentativo per aggiornare le leggi sul
lavoro, con lo scopo di tutelare meglio l’impiego femminile. Ma le buone
intenzioni manifestate dai provvedimenti non sono state quasi mai messe in
pratica o sono risultate controproducenti nella nuova realtà del mercato del
lavoro. Ad esempio, esistono prove documentate che i datori di lavoro delle
nuove imprese private sono reticenti ad accordare i congedi di maternità e che
oltre i due terzi delle donne, con diplomi d’istruzione superiore, sono tornate
al lavoro prima di aver concluso il loro periodo obbligatorio.
Resta del tutto trascurabile il numero di uomini che si avvale del congedo
parentale. Un tema da affrontare e risolvere al più presto era quello relativo
al divieto del lavoro notturno, introdotto con il codice del lavoro del 1996,
per quelle donne con figli di età inferiore a sei anni. Da tempo, le
Organizzazioni non governative femminili avevano denunciato la pressione che la
progressiva alterazione del mondo del lavoro esercitava sulle donne: i processi
di privatizzazione e di ristrutturazione in atto spingevano in direzione di
un’industria monostrutturata e verso un’organizzazione del lavoro che si basava
su tre rigidi turni, di cui uno notturno. L’impossibilità di combinare tempi di
lavoro e tempi di famiglia, ma soprattutto il divieto di svolgere il lavoro
notturno, costringevano la donna a scegliere l’unica soluzione possibile: il
licenziamento. Il veto sul lavoro notturno, stabilito dal governo per agevolare
e migliorare le condizioni delle lavoratrici, non era stato da quest’ultime favorevolmente
accolto, poiché le escludeva automaticamente da una grande fetta del mercato
del lavoro (circa il 70% della manodopera turnista era costituito da donne),
una posizione che esse difendevano con forza per necessità familiari. Il nuovo
codice del lavoro introdotto in Russia nel febbraio 2002 se, da un lato,
reintroduce il diritto al lavoro notturno per quelle donne con figli di età
inferiore ai sei anni, dall’altro, estende tale diritto anche alle donne
incinte e legalizza il lavoro minorile.
La riforma economica ha comportato negli anni novanta una grave recessione,
producendo molti cambiamenti nelle condizioni e nello stile di vita delle donne
russe. Le donne sole con figli, insieme con le anziane sole, sono quelle che
hanno sofferto di più. L’aumento della povertà femminile è ormai una piaga
sociale con cui si deve confrontare il paese. Stando ad un’indagine condotta
nel 1992, per i nuclei familiari delle aree urbane con donne capofamiglia (si
tratta per la maggior parte di famiglie monogenitore), l’unica possibilità di
“far quadrare” il bilancio familiare era risparmiare su tutto. Per la sociologa
Olga Zdravomyslova, la situazione nel paese ha fatto riemergere modelli
tradizionali di comportamento degli uomini russi, come quello di vivere fuori
casa pur mantenendo un predominio sulla moglie e sui figli, anche se la maggior
parte di questi non da in casa nulla di quanto guadagna. La divaricazione
sociale tra i pochi ricchi ed una maggioranza molto povera, i forti cambiamenti
di valori e ruoli, l’improvvisa scomparsa dello stato paterno ed onnipresente,
questi ed altri fattori hanno contribuito ad acutizzare i numerosi conflitti
già presenti all’interno delle famiglie russe. Il numero elevato delle
separazioni, l’aumento dei casi di violenza familiare e un maggior abuso nel
consumo di alcol sono la diretta conseguenza della mancanza di lavoro, della
povertà e delle conseguenti frustrazioni.
In Russia, la grande maggioranza delle donne lavora ancora e l’idea di poter
conciliare impegni familiari e di lavoro non esiste. Basti pensare che il 14%
delle donne russe crede di aver completamente fallito la conciliazione tra
lavoro e famiglia, mentre in altri paesi questa percentuale oscilla tra lo 0,4
e il 14%. Il problema di conciliare lo scarto tra i tempi del lavoro e i tempi
della famiglia è da loro molto sentito poiché, nonostante l’elevato tasso di
disoccupazione femminile che ha colpito il paese con l’avvio del libero
mercato, la percentuale di donne occupate è ancora molto alta. Ciononostante,
sulle donne pesa interamente il lavoro domestico e di cura che, secondo un
rapporto dell’Unicef del 1999, ha raggiunto in Russia una media di 70 ore la
settimana.
Nella storia dei movimenti e dell’immaginario femminile di quel paese, la separazione
tra sfera pubblica e sfera privata era stata motivo di lotta, opposizione e resistenza
contro un sistema di tipo patriarcale che aveva storicamente assegnato alla
donna il ruolo della cura della famiglia e della casa all’interno della sfera
domestica, escludendola dall’ambito pubblico, luogo della politica e del
lavoro. Dopo la rivoluzione d’Ottobre questa storica separazione era stata
annullata, per ripresentarsi di nuovo con il passaggio dall’era sovietica a
quella russa. Il clima nel paese evidenzia, infatti, un forte riflusso
femminile di massa e l’avvento di un nuovo rinascimento patriarcale. In effetti,
a partire dall’era “el’ciniana” le donne sono ritornate ai valori della tradizione.
Questo fatto è solo apparentemente paradossale. Esso, infatti, fa parte del
grande movimento di rinascita della conservazione nel paese, insieme allo
spirito nazionale, al ritorno alle fedi religiose, alla volontà di rendere
ideale ed eroica l’età presocialista, il passato feudale. Ma quest’involuzione
non è certo da imputare solo alla riscoperta di antichi valori “presocialisti”,
quanto all’emergere di contraddizioni certamente più profonde ereditate dal
sistema sovietico.
Tuttavia, la necessità di tutelare e garantire i diritti delle donne, in un
momento in cui la loro condizione registra un sensibile peggioramento, è alla
base della nascita, a partire dal 1991, di diversi movimenti femminili con
finalità diverse, ma il cui unico denominatore comune è quello di portare più
equità ed equilibrio tra i sessi. La liberalizzazione politica ha favorito
l’istituzione di organizzazioni non governative, di movimenti sociali e di
gruppi di base. Nonostante una certa “allergia al femminismo”, retaggio
dell’esperienza sovietica, numerose sono ormai le organizzazioni femminili
attive impegnate a far applicare le convenzioni e i trattati internazionali sui
diritti delle donne sottoscritti e ratificati dalla Russia.
Scopo del libro della Carpinelli è quello di analizzare e riflettere su questi
argomenti che pongono tutti al loro centro il tema delle discriminazioni di
genere nella Russia di oggi. Infatti, uno dei contesti in cui più chiaramente è
emerso il problema dell’ineguaglianza sociale è quello relativo alla posizione
economica e sociale delle donne. Il panorama mostrato sulla loro posizione
svantaggiata nella società serve anche a preparare il terreno per lo studio
successivo affrontato nel libro relativo alla povertà femminile nel corso della
transizione liberale.
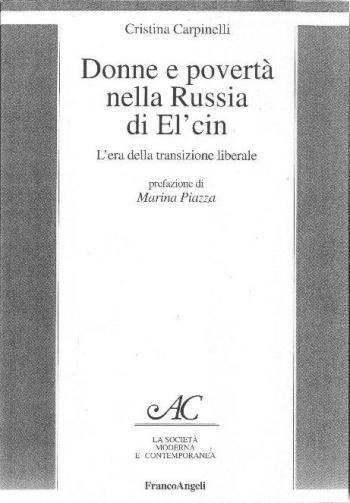
|
Franco Angeli Milano 2004 Pagine 251 Prezzo di copertina: 20.50 Euro |