Alexandra Kollontaj | Conférences sur la libération des femmes, Éditions "La Brèche", 1978
Traduzione per Resistenze.org a cura del Centro di Cultura e Documentazione Popolare
1921
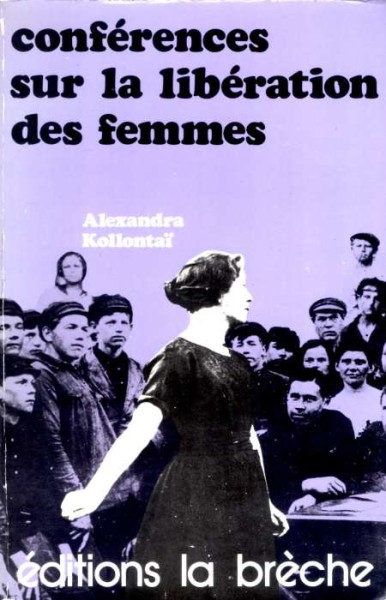
Prefazione
1a Conferenza - La situazione della donna nel comunismo primitivo
2a Conferenza - Il ruolo della donna nel sistema economico dello schiavismo
3a Conferenza - La condizione della donna nell'economia naturale dell'autosufficienza
4a Conferenza - Il lavoro femminile nella comunità agricola e nella produzione artigianale
5a Conferenza - La collocazione della donna durante l'epoca fiorente del capitale mercantile e della manifattura
6a Conferenza - Il lavoro femminile nel periodo di espansione della grande industria capitalistica
7a Conferenza - Le origini della "questione femminile"
8a Conferenza - Il movimento femminista e il ruolo della donna lavoratrice nella lotta di classe
9a Conferenza - Il lavoro delle donne durante la guerra
10a Conferenza - La dittatura del proletariato: l'organizzazione del lavoro
11a Conferenza - La dittatura del proletariato: condizioni di lavoro e disposizioni sulla protezione del lavoro
12a Conferenza - La dittatura del proletariato: il cambiamento rivoluzionario della vita quotidiana
13a Conferenza - La dittatura del proletariato: la rivoluzione dei costumi
14a Conferenza - Il lavoro delle donne oggi e domani
Prefazione
Le quattordici conferenze che ho tenuto nella primavera del 1921 (aprile-maggio-giugno) all'Università Sverdlov di Leningrado erano destinate a studentesse che si preparavano a lavorare nei settori femminili. Una parte delle conferenze era stata registrata in stenografia e io stessa ho ricostituito l'altra parte a partire dai miei appunti, nell'autunno del 1921.
Attraverso le mie conferenze ho voluto dare alle studentesse una visione d'insieme essenziale della posizione marxista sulla questione delle donne - a dire il vero in forma semplificata e abbordabile - e nelle ultime quattro, mostrare i cambiamenti rivoluzionari nella vita e nella nuova condizione della donna nello Stato operaio, intendo con il suo riconoscimento come componente a pieno titolo della società. La nuova condizione della donna non ha portato soltanto a una nuova e positiva valutazione dei suoi diritti politici e sociali, ma anche a una profonda trasformazione delle relazioni tra uomo e donna.
Ciò divenne chiaro nel 1921, quando la rivoluzione, dopo essere passata dal comunismo di guerra alla nuova economia politica (NEP), si trovò ad una svolta decisiva. Il livello di sviluppo del processo di liberazione dalle tradizioni borghesi divenne più visibile che in passato, grazie alle conseguenze della nuova economia politica nell'Unione sovietica. Durante i tre anni rivoluzionari, le fondamenta socio-economiche della società borghese sono state distrutte e si erano fatti tentativi decisivi per gettare le basi della Russia sovietica, ma non c'è alcun movimento indipendente delle operaie, il proletariato di entrambi i sessi è indissolubilmente unito nella società comunista. L'atmosfera che regnava allora ha poi reso obsolete le antiche tradizioni, a una velocità straordinaria. Al loro posto assistemmo all'esplosione di nuove forme di comunità umane. Il modello della famiglia borghese non era più inevitabile.
La donna, con il suo lavoro comunitario e obbligatorio per la società, si trovò di fronte a modalità di esistenza completamente nuove. Non era più disponibile esclusivamente per la sua famiglia, ma anche al collettivo di lavoro. E così cominciarono a nascere altre condizioni di vita, nuove forme di unione e i rapporti tra bambini e genitori si trasformarono. Nel 1921, anno decisivo, si manifestano con particolare rilevanza i segnali di un nuovo modo di pensare, di nuovi costumi, di una nuova morale e soprattutto, di un nuovo ruolo della donna e del suo significato per la collettività e lo Stato dei soviet. Sotto il rombo dei cannoni che difendevano le nostre innumerevoli frontiere della nostra Repubblica operaia rivoluzionaria, crollarono le tradizioni del mondo borghese mortalmente colpito.
Molte abitudini di vita, di pensiero e di leggi morali sono oggi completamente scomparse o sono in via di estinzione. La nuova economia politica non era in grado di rinviare i cambiamenti a livello di famiglia e di coppia, né è riuscita a indebolire la posizione della donna nell'economia sovietica. Ma, in quel momento, i nuovi modi di vita vissuti dalle lavoratrici del partito fino al 1921 non avevano un grande impatto sulla stragrande maggioranza delle donne. Le nuove condizioni sociali e di conseguenza la situazione della donna, sono strettamente legate alla struttura e all'organizzazione del sistema economico. Lo sviluppo di una produzione socialista comporta la disgregazione della famiglia tradizionale e permette quindi una crescente emancipazione e libertà delle donne nella società. Poiché non sembra possibile evitare certe deviazioni e ritardi nello sviluppo della nostra società comunista, ciò significa logicamente che l'ampio processo di emancipazione delle donne può trovarsi bloccato per un certo periodo di tempo.
La situazione e l'influenza politica delle donne lavoratrici non sono più paragonabili alle condizioni che regnavano nel 1921. In effetti, le nostre operaie e le nostre contadine, con il sostegno del Partito comunista, sono riuscite a difendere vittoriosamente le conquiste dei primi anni della rivoluzione e ad espandere e consolidare, anche se con un successo variabile, i diritti della donna lavoratrice. Non vi è dubbio che le forze sociali che sono riuscite a imporre l'obbligo del lavoro alle donne di tutte le categorie sociali, al fine di creare in tal modo le condizioni oggettive per la trasformazione della famiglia e delle abitudini di vita, sono oggi significativamente indebolite.
Questo è senza dubbio il risultato della nuova economia politica. I cambiamenti economici e politici non si realizzano più oggi sotto la pressione e la mobilitazione delle masse, ma a lungo termine sotto la guida consapevole del Partito comunista. [...]
Ho deciso di non correggere, né completare la nuova edizione delle mie conferenze. Un rimpasto in funzione delle condizioni attuali avrebbe tolto loro il modesto valore di testimonianza, rendendo conto dell'atmosfera di lavoro dell'epoca, dei fatti e delle conquiste della vita reale, consentendo di misurare l'ampiezza della rivoluzione e caratterizzando la situazione delle donne lavoratrici nella repubblica operaia.
Mi sembra chiaro che il mio libro apporta solo un contributo parziale alla soluzione della questione delle donne in una fase specifica della rivoluzione.
Tuttavia, ho deciso di pubblicare le conferenze nella loro forma originale. Sono fermamente convinta che lo studio e la comprensione del passato - in questo caso un'analisi storica della posizione della donna in relazione allo sviluppo economico - possa facilitare la comprensione del nostro compito attuale e contribuire a rafforzare la visione comunista del mondo. Essa può anche aiutare la classe operaia nella ricerca del percorso più breve che porta alla liberazione totale e senza restrizioni delle donne lavoratrici.
Alexandra Kollontaj, Oslo 1925
Prima conferenza - La situazione della donna nel comunismo primitivo
Cominceremo oggi una serie di conferenze che trattano le seguenti questioni: la situazione della donna in riferimento allo sviluppo delle diverse forme economiche della società; la situazione della donna nella società che determina la sua posizione nella famiglia. Troviamo questa relazione stretta e indissolubile in tutte le fasi intermedie dello sviluppo socio-economico. Poiché il vostro futuro lavoro consiste nel conquistare le donne operaie e contadine alla causa della nuova società in cui siamo chiamate a vivere, dovete comprendere questa relazione.
L'obiezione più frequente che incontrerete sarà la seguente: non è possibile cambiare nulla della situazione della donna e delle sue condizioni di vita. Queste sarebbero infatti determinate dalle peculiarità del suo sesso. Se avversate l'oppressione delle donne, se volete liberarle dal giogo della vita familiare, se richiedete una maggiore uguaglianza dei diritti tra i sessi, vi verranno servite argomentazioni trite e ritrite: "L'assenza dei diritti della donna e la sua diseguaglianza rispetto all'uomo si spiegano con la storia e non possono dunque essere eliminate. La dipendenza della donna, la sua posizione subordinata all'uomo esistono da sempre, non c'è dunque nulla da cambiare. I nostri antenati hanno vissuto così e accadrà lo stesso per i nostri figli e i nostri nipoti".
Risponderemo a tali argomentazioni con la storia stessa: la storia dello sviluppo della società umana, la conoscenza del passato e del modo in cui le relazioni si intrecciano. Appena avrete appreso le condizioni di vita, così come esistevano molte migliaia di anni fa, non tarderete a essere profondamente persuase che l'assenza di diritti della donna rispetto all'uomo, che la sua sottomissione di schiava, non è sempre esistita. Ci sono stati periodi dove l'uomo e la donna hanno avuto diritti assolutamente uguali. E ci sono stati anche periodi dove l'uomo, in una certa misura, attribuiva alla donna una posizione di comando.
Se esaminiamo più attentamente la situazione della donna nel corso delle varie fasi dello sviluppo sociale, riconoscerete facilmente che l'assenza attuale di diritti della donna, la sua mancanza di autonomia, le sue prerogative limitate all'ambito della famiglia e della società, non sono affatto qualità innate peculiari della "natura" femminile. Non è vero che le donne siano meno intelligenti degli uomini. No, la situazione dipendente della donna e la sua mancanza di emancipazione non sono spiegabili con alcuna qualità "naturale", ma col carattere del lavoro che le è stato assegnato in una data società.
Vi chiedo di leggere attentamente i primi capitoli del libro di Bebel: la Donna e il Socialismo (ndt1). Bebel dimostra la seguente tesi - di cui ci serviremo nel corso della nostra conferenza - secondo la quale esiste una corrispondenza particolarmente stretta ed organica tra la partecipazione della donna alla produzione e la sua posizione nella società. In breve, si tratta di un tipo di legge socio-economica che non dovrete perdere più di vista. Vi sarà così più facile comprendere i problemi della liberazione universale della donna e del suo rapporto con il lavoro.
Alcuni credono che la donna nelle antiche epoche quando l'umanità era ancora immersa nella barbarie, si trovasse in una situazione peggiore di quella attuale; che conducesse quasi una vita da schiava. Questo è falso. Sarebbe errato credere che la liberazione della donna dipenda dallo sviluppo della cultura e della scienza, che la libertà delle donne dipenda dalla civilizzazione di un popolo. Solo i rappresentanti della scienza borghese possono affermare cose del genere. Tuttavia, sappiamo che non è né la cultura, né la scienza che possono affrancare le donne, ma un sistema economico dove la donna svolga un lavoro utile e produttivo per la società. Il comunismo è un sistema economico di questo tipo.
La situazione della donna è sempre una conseguenza del tipo di lavoro che questa fornisce in un momento preciso dell'evoluzione di un particolare sistema economico. Al tempo del comunismo primitivo - già è stato discusso in altre conferenze che hanno trattato dell'evoluzione sociale ed economica della società in generale - in un periodo dunque così remoto che ci è difficile immaginarlo, dove la proprietà privata era sconosciuta e dove gli uomini erravano in piccoli gruppi, non c'era nessuna differenza tra la situazione dell'uomo e quella della donna. Gli uomini si nutrivano dei prodotti della caccia e della raccolta (ndt 2)
Durante questo periodo di sviluppo degli uomini primitivi, molte decine, cosa dico, molte centinaia di migliaia di anni fa, i doveri e i compiti dell'uomo e della donna erano sostanzialmente gli stessi. Le ricerche degli antropologi hanno provato che agli albori dello sviluppo dell'umanità, cioè nella fase della caccia e della raccolta, non c'erano grandi differenze tra le qualità fisiche dell'uomo e della donna. Entrambi possedevano una forza e un'elasticità quasi equivalenti, cosa che è comunque un fatto interessante e importante da rilevare. Molte caratteristiche delle donne, come i grandi seni, la vita stretta, le forme arrotondate del corpo e la debole muscolatura, si svilupparono soltanto molto più tardi, a partire dal momento in cui la donna dovette rivestire il ruolo "di ovaiola" e garantire, generazione dopo generazione, la riproduzione sessuale.
Fra i popoli primitivi odierni, la donna non si distingue dall'uomo in modo sensibile, i suoi seni restando poco sviluppati, il suo bacino è stretto e i suoi muscoli solidi e ben formati. Accadeva lo stesso all'epoca del comunismo primitivo, quando la donna somigliava fisicamente all'uomo e aveva una forza e una resistenza praticamente uguali.
La nascita dei bambini comportava soltanto una breve interruzione delle sue occupazioni abituali, cioè la caccia e la raccolta della frutta con gli altri membri di questa prima collettività, che era la tribù. La donna era costretta a respingere gli attacchi del nemico più temuto in quel momento, l'animale carnivoro, esattamente come gli altri membri della tribù, fratelli e sorelle, figli e genitori
Non esisteva dipendenza della donna rispetto all'uomo, né esistevano diversi diritti. Le condizioni perchè avvenisse questo non esistevano poiché, a quel tempo, la legge, il diritto e la divisione della proprietà erano ancora sconosciute. La donna non dipendeva unilateralmente dall'uomo, poiché egli stesso aveva totalmente bisogno della collettività, cioè della tribù. In effetti, la tribù prendeva tutte le decisioni. Chiunque rifiutava di piegarsi alla volontà della comunità periva, moriva di fame o era divorato dagli animali.
Fu solo attraverso una stretta solidarietà nell'ambito della collettività che l'uomo fu in grado di proteggersi dal nemico più potente e più terribile di quest'epoca. Più una tribù era fermamente salda e più gli individui si sottomettevano alla sua volontà. Potevano così opporre un fronte più unito al nemico comune, così il risultato della lotta era più sicuro e la tribù ne usciva rafforzata. L'uguaglianza e la solidarietà naturali, se garantivano la coesione della tribù, erano le migliori armi di autodifesa. È per questo che, in occasione di qualsiasi primo periodo dello sviluppo economico dell'umanità, era impossibile che un membro della tribù dipendesse da un altro o meglio, che dipendesse unilateralmente da quest'ultimo.
All'epoca del comunismo primitivo, la donna non conosceva né schiavitù, né dipendenza sociale, né oppressione. L'umanità ignorava tutto delle classi, dello sfruttamento del lavoro o della proprietà privata. E visse così per migliaia di anni, anche centinaia di migliaia di anni.
Il quadro si modificò nel corso delle fasi seguenti dello sviluppo dell'umanità. I primi accenni al lavoro produttivo e all'organizzazione economica furono il risultato di un lungo processo. Per ragioni climatiche e geografiche, a seconda che ci si trovasse in un'area boschiva o in una steppa, la tribù diventava sedentaria o praticava l'allevamento. Raggiunse così una fase più evoluta di quella della prima comunità, basata sulla caccia e la raccolta. Parallelamente a queste nuove forme di organizzazione economica, appaiono nuove forme di comunità sociale.
Esamineremo ora la situazione della donna in due tribù che, vivendo nella stessa epoca, conobbero tuttavia forme di organizzazione diverse. I membri della prima tribù si stabilirono in una regione boschiva intervallata da piccoli campi e diventarono agricoltori sedentari. Quanto ai secondi, vissero in un'area della steppa con le loro grandi mandrie di bufali, di cavalli e di capre e si convertirono all'allevamento. Queste due tribù rimasero tuttavia sempre all'interno di un comunismo primitivo, ignorando la proprietà privata. Ora, la situazione della donna nell'ambito di queste due tribù già si differenziava. Nella tribù che praticava l'agricoltura, la donna usufruiva non soltanto di una piena uguaglianza di diritti, ma occupava anche a volte una posizione dominante. Invece presso gli allevatori nomadi, la situazione subordinata, dipendente ed oppressa della donna si accentuava a vista d'occhio.
La ricerca che riguarda la storia economica fu a lungo dominata dal concetto che l'umanità abbia dovuto necessariamente passare attraverso tutte le tappe, tutte le fasi dello sviluppo economico: ogni tribù si sarebbe inizialmente dedicata alla caccia, quindi all'allevamento, infine all'agricoltura e solo alla fine all'artigianato e al commercio. Tuttavia, le più recenti ricerche sociologiche mostrano che le tribù passarono spesso direttamente dalla fase primitiva della caccia e della raccolta, all'agricoltura, omettendo così la fase dell'allevamento. Le condizioni geografiche e naturali sono state in realtà determinanti.
Chiaramente ciò significa che alla stessa epoca e in condizioni naturali diverse, si svilupparono due forme di organizzazione economica fondamentalmente dissimili, cioè l'agricoltura e l'allevamento. Le donne delle tribù che praticavano l'agricoltura usufruivano di uno stato sensibilmente più elevato. Alcune tribù agricole avevano anche un sistema matriarcale (matriarcato è una parola greca che designa la predominanza della donna - è la madre che perpetua la tribù). In compenso, il patriarcato, cioè il predominio dei diritti del padre - la posizione dominante dei più anziani della tribù -, si sviluppò nei popoli allevatori e nomadi. Perché questo e cosa ci dimostra? La ragione di questa differenza risiede ovviamente nel ruolo della donna nell'economia.
Nei popoli di agricoltori la donna era la principale produttrice. Esistono ampie prove che fu essa che, per prima, ebbe l'idea dell'agricoltura, che fosse anche "il primo lavoratore agricolo". L'opera di Marianne Weber, Das Mutterrecht ("I diritti della madre"), presenta una ricchezza di esempi interessanti che riguardano il ruolo della donna nell'ambito delle prime forme di organizzazione economica. L'autrice non è comunista. Il suo libro fornisce tuttavia molte informazioni. Sfortunatamente è accessibile soltanto in tedesco.
La donna concepì l'idea dell'agricoltura nel momento in cui, durante la caccia, le madri e i loro bambini furono lasciati indietro perché incapaci di seguire il ritmo degli altri membri della tribù, ostacolando così la ricerca della selvaggina.
Non era allora affatto facile procurarsi altri alimenti e la donna aspettava spesso a lungo. Si vide forzata a procurarsi cibo per sé e i suoi bambini. I ricercatori ne hanno tratto la conclusione che, molto probabilmente, fu la donna a iniziare a lavorare la terra. Quando le scorte si esaurirono nel luogo in cui attendeva il ritorno della tribù, si mise alla ricerca di vegetali contenenti semi commestibili. Mangiò questi semi e ne nutrì i suoi bambini. Ma mentre li schiacciava tra i suoi denti - le prime macine - una parte dei semi cadde al suolo. E quando la donna ritornò dopo un po' di tempo nello stesso posto, scoprì che i semi avevano germogliato. Ora sapeva che le sarebbe stato vantaggioso ritornare quando le erbe erano ricresciute e che la ricerca di più cibo le sarebbe costata meno sforzi. E' così che gli uomini hanno imparato che i semi che cadono a terra cominciano a crescere.
L'esperienza insegnò loro anche, che il raccolto era migliore quando prima avevano mescolato la terra. Tuttavia, questa esperienza cadde spesso nell'oblio, poiché la conoscenza individuale poteva diventare parte della tribù soltanto dal momento in cui veniva comunicata alla collettività. Occorreva che fosse trasmessa alle generazioni successive. Ma l'umanità ha dovuto fare un lavoro di riflessione inimmaginabile prima di riuscire ad afferrare e ad assimilare cose apparentemente così semplici. Questa conoscenza si ancorò nella coscienza della collettività soltanto quando si tradusse in pratica quotidiana.
La donna aveva interesse al fatto che il clan o la tribù ritornassero nella vecchia zona dove cresceva l'erba che aveva seminato. Ma non era in grado di convincere i suoi compagni della precisione del suo piano di organizzazione economica. Non poteva convincerli verbalmente. Così favorì alcune regole, abitudini e idee necessarie ai suoi progetti. Così apparve la seguente consuetudine, che ebbe presto forza di legge: se il clan avesse lasciato le madri e i bambini in un terreno vicino ad un ruscello durante la luna piena, gli dei avrebbero ordinato ai suoi membri di tornare in quello stesso luogo alcuni mesi più tardi. Chiunque non rispettasse questa legge era punito dagli spiriti. La tribù scoprì che i bambini morivano più rapidamente quando questa regola non era rispettata, cioè quando non si ritornava "al posto dove l'erba cresce" e cominciò a rispettare strettamente queste abitudini e a credere "alla saggezza" delle donne. Dato che la donna ricercava una produzione massima per un minimo lavoro, fece presto la seguente constatazione: più il suolo dove seminava era poroso, migliore era il raccolto. Accovacciata, incise per mezzo di rami, di punte e di pietre, i solchi nel primo campo. Tale scoperta si rivelò proficua, poiché offrì all'uomo una maggiore sicurezza in occasione delle sue peregrinazioni incessanti attraverso la foresta, dove si esponeva costantemente al pericolo di essere divorato dagli animali.
A causa della sua maternità, la donna occupò una posizione particolare fra i membri della tribù. È alla donna che l'umanità deve la scoperta dell'agricoltura, scoperta estremamente importante per la sua evoluzione economica. E fu questa scoperta che, per lungo tempo, determinò il ruolo della donna nella società e nell'economia, mettendola al vertice delle popolazioni che praticavano l'agricoltura. Numerosi ricercatori attribuiscono alla donna anche l'uso del fuoco come strumento economico.
Ogni volta che la tribù partiva a caccia o alla guerra, le madri e i loro bambini erano lasciati indietro e obbligati a proteggersi dagli animali carnivori. Le ragazze e le donne senza figli partivano con gli altri membri della tribù. È con la sua esperienza che l'uomo primitivo imparò che il fuoco offriva la migliore protezione contro i carnivori. Tagliando pietre per fabbricare armi o i primi attrezzi domestici, si era imparato a fare il fuoco. Per garantire la protezione dei bambini e delle loro madri, si accendeva dunque un fuoco prima della partenza della tribù per la caccia. Per le madri era un sacro dovere conservare questo fuoco destinato ad allontanare gli animali. Per gli uomini, il fuoco era una forza spaventosa, inafferrabile e sacra. Per le donne che se ne occupavano in modo permanente, le proprietà del fuoco diventarono familiari e furono in grado così di utilizzarlo per facilitare ed ottimizzare il loro lavoro. La donna apprese a cuocere i suoi recipienti in terracotta per renderli più resistenti e ad arrostire la carne che poteva così essere conservata meglio. La donna, legata al focolare con la sua maternità, dominò il fuoco e ne fece il suo servo. Ma le leggi dell'evoluzione economica modificarono successivamente questa relazione e la fiamma del primo focolare ridusse la donna in schiavitù, spogliandola di tutti i suoi diritti e legandola per lungo tempo ai suoi fornelli.
L'ipotesi che le prime capanne siano state costruite dalle donne per proteggersi con i loro figli dalle intemperie non è certamente ingiustificata. Ma non solo le donne costruivano capanne e coltivavano la terra da cui raccoglievano i cereali, ecc., esse furono anche le prime a praticare l'artigianato. La filatura, la tessitura e la ceramica furono scoperte femminili. E le linee che tracciavano sui vasi di terracotta furono i primi tentativi artistici dell'umanità, la fase preliminare dell'arte. Le donne raccoglievano erbe e impararono a conoscere le loro proprietà: le antenate delle nostre madri furono i primi medici. Questa storia, la nostra preistoria, è conservata nelle antiche leggende e nelle credenze popolari. Nella cultura greca, che era al suo apice duemila anni fa, non fu il dio Asclépio (Esculapio), ma sua madre, Coronide, che fu considerata come il primo medico. Soppiantò Ecate e Diana che erano state le prime dee dell'arte della guarigione. Tra i vecchi Vichinghi, c'era la dea Eir. Al giorno d'oggi incontriamo ancora spesso nei villaggi anziane donne che passano per essere particolarmente intelligenti e a cui si attribuiscono poteri magici.
La conoscenza acquisita dalle antenate delle nostre madri era estranea ai loro compagni, che partivano spesso alla caccia o alla guerra o si dedicavano ad altre attività che richiedevano particolare forza muscolare. Semplicemente non avevano il tempo di impegnarsi in riflessioni o in attente osservazioni. Non era loro dunque possibile raccogliere e trasmettere esperienze preziose sulla natura delle cose. Il termine "Vedunja", la maga, è formato sulla parola "Vedatj", conoscenza. La conoscenza è dunque stata da sempre una prerogativa della donna, che l'uomo temeva e rispettava. È per ciò che la donna nel periodo del comunismo primitivo - l'alba dell'umanità -, non era solo uguale all'uomo, ma, a causa di una serie di scoperte e di scoperte utili al genere umano e contribuendo alla sua evoluzione economica e sociale, lo ha addirittura superato. Dunque, in determinati periodi della storia dell'umanità, la donna svolse un ruolo molto più importante per lo sviluppo delle scienze e della cultura di quello che la scienza borghese, bardata di pregiudizi, le ha attribuito fino ad ora.
Gli antropologi, ad esempio, specialisti dello studio dell'origine dell'umanità, hanno ignorato il ruolo della femmina nel corso dell'evoluzione dei nostri antenati, dalle scimmie agli ominidi. Questo perché la posizione eretta, così caratteristica dell'essere umano è stata principalmente una conquista della donna. Nelle situazioni in cui si trovava la nostra antenata a quattro zampe, doveva difendersi contro gli attacchi nemici: imparò così a proteggersi con un solo braccio, mentre con l'altro teneva fermamente stretto a sé il proprio piccolo che si aggrappava al suo collo. Ha potuto tuttavia realizzare questa prodezza soltanto raddrizzandosi a metà, cosa che sviluppò anche la massa del suo cervello. Le donne pagarono cara questa evoluzione, poiché il corpo femminile non era fatto per la posizione eretta. Nei nostri cugini a quattro zampe, le scimmie, le doglie sono completamente sconosciute. La storia di Eva, che raccolse il frutto dell'albero della conoscenza e che, per questo motivo dovette partorire con dolore, possiede dunque un sfondo storico.
Ma noi analizzeremo principalmente il ruolo della donna nell'economia delle tribù agricole. All'origine i prodotti dell'agricoltura non erano sufficienti a nutrire la popolazione, è per questo che si continuò a praticare la caccia. Quest'evoluzione portò una divisione naturale del lavoro. La parte sedentaria della tribù, le donne dunque, organizzò l'agricoltura, mentre gli uomini continuarono a partire alla caccia o alla guerra in spedizioni di saccheggio contro le tribù vicine. Ma poiché l'agricoltura era nettamente più proficua e i membri della tribù preferivano i prodotti del raccolto a quelli così pericolosamente conquistati con la caccia o il saccheggio, divenne presto la base economica del clan. E chi era allora il produttore principale di quest'economia basata sull'agricoltura? La donna!
Era quindi naturale per il clan rispettare la donna e stimare molto il valore del suo lavoro. Attualmente esiste una tribù di agricoltori in Africa centrale, Balonda, dove la donna è il membro della comunità più "apprezzato". Il famoso esploratore inglese, David Livingstone riporta quanto segue: "Le donne sono rappresentate al Consiglio degli Anziani. I futuri mariti devono unirsi al villaggio delle loro future mogli e vivere presso di loro dopo aver consumato il matrimonio. L'uomo si impegna a mantenere la suocera fino alla sua morte. Solo la donna ha il diritto a chiedere la separazione, dopo di che tutti i suoi bambini rimangono con lei. Senza l'autorizzazione della moglie, l'uomo non deve contrarre alcun obbligo nei confronti di un terzo, per quanto insignificante sia". Gli uomini sposati non oppongono alcuna resistenza e sono rassegnati alla loro situazione. Le mogli danno ai loro uomini recalcitranti colpi o schiaffi o li privano del cibo.
Tutti i membri della comunità del villaggio sono obbligati ad obbedire a coloro che godono di stima generale. Livingstone pensa che tra i Balonda, siano le donne a esercitare il potere. Ma questa tribù non costituisce affatto un'eccezione. Altri ricercatori affermano che nelle tribù africane in cui le donne arano e seminano, costruiscono le capanne e conducono una vita attiva, queste non sono soltanto completamente indipendenti, ma intellettualmente superiori agli uomini. Gli uomini di queste tribù si lasciano mantenere dal lavoro delle loro mogli, diventano "femminili e morbidi". "Mungono le mucche e chiacchierano", secondo quanto riferito dai resoconti di numerosi ricercatori.
I tempi preistorici ci offrono molti esempi di dominazione da parte delle donne. In una parte delle tribù che praticano l'agricoltura, la filiazione non è realizzata dal padre, ma dalla madre. E là dove è comparsa la proprietà privata, sono le figlie che ereditano e non i figli. Ancora oggi incontriamo la sopravvivenza di questo sistema di diritti in alcuni popoli delle montagne del Caucaso.
L'autorità della donna presso le popolazioni agricole aumentava incessantemente. Era lei che conservava e proteggeva le tradizioni e le abitudini, il che significa che era lei soprattutto che dettava le leggi. Il rispetto di queste tradizioni e di queste abitudini era una necessità vitale assoluta. Senza essa sarebbe stato terribilmente difficile indurre i membri del clan ad obbedire alle regole che derivano dai compiti economici. Gli uomini di quel tempo non erano capaci di spiegare logicamente e scientificamente perché dovevano seminare e raccogliere in periodi determinati. Pertanto, era molto più semplici dire: "Da noi esiste questa usanza, stabilita dai nostri antenati, è per questo che dobbiamo fare così. Chi si oppone è un criminale". Il mantenimento di queste tradizioni e di questi costumi era garantito dalle anziane del villaggio, le donne e le madri, sagge ed esperte.
La divisione del lavoro nelle tribù che praticano allo stesso tempo la caccia e l'agricoltura ha portato i seguenti fatti: le donne, responsabili della produzione e dell'organizzazione delle abitazioni, hanno ulteriormente sviluppato le loro capacità di ragionamento e di osservazione, mentre gli uomini, a causa delle loro attività di caccia e di guerra, hanno piuttosto sviluppato la loro muscolatura, la loro indole fisica e la loro forza. In questa fase dell'evoluzione, la donna era intellettualmente superiore all'uomo. E nell'ambito della comunità, occupava, naturalmente, la posizione dominante, cioè quella del matriarcato.
Non dobbiamo dimenticare che in quest'epoca gli uomini erano incapaci di produrre delle riserve È per questo che le mani lavoratrici rappresentavano "la forza viva" del lavoro e la fonte della prosperità. La popolazione aumentava soltanto lentamente, il tasso di natalità era basso. La maternità era molto apprezzata e la donna-madre occupava un posto d'onore nelle tribù primitive. Il basso tasso di natalità è parzialmente spiegabile con l'incesto e coi matrimoni tra parenti stretti. Ed è provato che questi matrimoni fra consanguinei erano responsabili di aborti spontanei, rallentando così la normale evoluzione della famiglia.
Durante il periodo di caccia e di raccolta, l'importanza della riserva della forza del lavoro di una tribù non svolgeva alcun ruolo. Al contrario, appena la tribù acquistava maggiore ampiezza l'approvvigionamento diventava più difficile. Fino a quando l'umanità si è nutrita esclusivamente dei prodotti casuali della raccolta e della caccia, la maternità della donna non era particolarmente apprezzata.
I bambini e i vecchi erano un pesante fardello per la tribù. Ci si provava a sbarazzarsene in un modo o nell'altro e succedeva anche che venissero mangiati. Ma le tribù che garantivano le loro entrate grazie a un lavoro produttivo, cioè le tribù di agricoltori, avevano bisogno di lavoratori. Con questo la donna acquisì un nuovo significato, in questo caso quello di produrre nuova forza lavoro, i bambini. La maternità era venerata religiosamente. In molte religioni pagane, il dio principale è il sesso femminile, ad esempio la dea Iside in Egitto, Gaia in Grecia, cioè la Terra che, all'epoca primitiva, rappresentava la fonte di tutta la vita.
Bachofen, noto per le sue ricerche sul matriarcato, ha provato che il femminile, nelle religioni primitive, predominava sul maschile, cosa che la dice lunga sul significato della donna in questi popoli. La terra e la donna erano le fonti primarie ed essenziali di qualsiasi ricchezza. Le proprietà della terra e della donna si confusero. Terra e donna creavano e perpetuavano la vita. Chiunque feriva una donna, feriva anche la terra. E nessun crimine fu più mal visto di quello diretto contro una madre. I primi sacerdoti, cioè i primi servitori degli dei pagani, erano donne. Erano le madri a decidere per i loro figli e non i padri, come in altri sistemi di produzione. Troviamo sopravvivenza di questa sovranità delle donne nelle leggende e nelle abitudini dei popoli tanto dell'Oriente che dell'Occidente. Non era tuttavia il significato di madre che mise la donna in questa posizione dominante presso le tribù agricole, bensì piuttosto il suo ruolo di produttore principale nell'economia del villaggio. Fino a quando la divisione del lavoro indusse l'uomo ad occuparsi soltanto della caccia, considerata come attività secondaria, mentre la donna coltivava i campi - l'attività più importante di quest'epoca -, la sua sottomissione e la sua dipendenza nei confronti dell'uomo erano inconcepibili.
È dunque il ruolo della donna nell'economia che determina i suoi diritti nel matrimonio e nella società. Ciò appare ancora più chiaramente quando compariamo la situazione della donna di una tribù di agricoltori con la situazione della donna di una tribù di allevatori nomadi. Osserverete che uno stesso fenomeno, come la maternità, cioè una proprietà naturale della donna, può avere conseguenze radicalmente opposte in condizioni economiche diverse.
Tacito ci dà una descrizione della vita degli antichi Germani. Erano una tribù di agricoltori sana, vigorosa e combattiva. Tenevano in grande considerazione le loro mogli ed ascoltavano il loro consigli. Le donne Germane avevano tutta la responsabilità del lavoro dei campi. Le donne delle tribù Ceche che praticavano l'agricoltura, godevano della stessa stima. La leggenda che c'è stata trasmessa sulla saggezza della principessa Libuše racconta che una delle sorelle di Libuše si occupava dell'arte della guarigione, mentre l'altra costruiva nuove città. Quando Libuše salì al potere, scelse come consulenti due ragazze particolarmente versate nelle questioni di diritto. Questa principessa governava in modo democratico e consultava il suo popolo per tutte le decisioni importanti. Libuše fu in seguito detronizzata dai suoi fratelli. Questa leggenda testimonia abbastanza bene il modo in cui i popoli hanno conservato la memoria della sovranità della donna. Il matriarcato diventò nella leggenda popolare un'epoca particolarmente felice e benedetta poiché la tribù conduceva ancora una vita collettiva.
Quale era invece la situazione della donna in una tribù di pastori? La tribù dei cacciatori si trasformò in tribù di pastori quando le condizioni naturali furono favorevoli (ampie aree di steppa, erba abbondante, mandrie di bovini o di cavalli selvaggi) e quando dispose di un numero sufficiente di cacciatori forti, abili ed intrepidi, capaci non soltanto di uccidere la loro preda, ma anche di catturarla viva. Erano soprattutto gli uomini che possedevano queste qualità fisiche. Le donne potevano dedicarvici solo per breve tempo, quando non erano assorbite dai compiti materni. La maternità le relegava in una posizione particolare e fu l'origine di una divisione del lavoro basata su differenza sessuale. Quando l'uomo partiva per la caccia accompagnato dalle donne celibi, la donna-madre era lasciata indietro a sorvegliare la mandria catturata. Doveva anche garantire l'addomesticamento degli animali. Ma questo compito economico rivestiva soltanto un significato di secondo ordine, era subordinato. Riflettete. Chi, secondo un punto di vista strettamente economico, sarà il più favorito del clan, l'uomo che cattura la femmina bufalo o la donna che la munge? Naturalmente l'uomo! Poiché la ricchezza della tribù si basava sul numero di animali catturati, era logicamente quello che poteva aumentare numericamente la mandria che fu considerato il principale produttore e fonte di prosperità per la tribù.
Il ruolo economico delle donne nelle tribù di pastori era sempre secondario. Poiché la donna, da un punto di vista economico, aveva meno valore e il suo lavoro era meno produttivo, cioè non contribuiva allo stesso modo alla prosperità della tribù, comparve la concezione secondo la quale la donna non era uguale all'uomo. E' importante notare quanto segue: le donne di queste tribù non dovevano, in occasione dell'esecuzione del loro lavoro subordinato alla cura della mandria, soddisfare le stesse esigenze e le stesse necessità, cioè sviluppare sistemi di lavoro a cadenza regolare, come era il caso delle donne delle tribù di agricoltori. Il fatto che le donne non soffrissero mai per la mancanza di provviste quando rimanevano sole nelle abitazioni fu particolarmente determinante. Infatti, il bestiame che governavano poteva, in qualsiasi momento, essere macellato. Le donne delle tribù di pastori non erano dunque obbligate ad inventare altri metodi di sussistenza, come le donne delle tribù che praticano tanto la caccia che l'agricoltura. D'altra parte, la cura del bestiame richiedeva meno intelligenza del lavoro complicato della terra.
Le donne delle tribù di pastori non potevano misurarsi intellettualmente con gli uomini e da un punto di vista strettamente fisico, erano, per forza e flessibilità, completamente inferiori a loro. Ciò rafforzò naturalmente la rappresentazione della donna come una creatura inferiore. Con l'aumento del bestiame della tribù, si rafforzava la condizione di serva della donna - valeva meno degli animali - come si allargava il divario tra i sessi. I popoli nomadi e pastori si trasformarono del resto più facilmente in orde guerriere e depredatrici di popoli che ricavavano sussistenza dall'agricoltura. La ricchezza degli agricoltori si basava su un lavoro più pacifico di quello degli allevatori e dei nomadi, per i quali il saccheggio era un'ovvia fonte d'arricchimento. All'inizio rubavano solo bestie, poi saccheggiarono e gradualmente rovinarono le tribù vicine, bruciando le loro scorte e facendo fra loro prigionieri, che divennero i primi schiavi.
Matrimoni forzati e stupri di donne delle tribù vicine erano soprattutto praticati dalle tribù nomadi e guerriere. Il matrimonio forzato ha fortemente segnato la storia dell'umanità. Ha innegabilmente contribuito a rafforzare l'oppressione della donna. Dopo essere stata strappata contro la sua volontà alla sua tribù, la donna si sentiva particolarmente senza difese. Era completamente consegnata a quelli che l'avevano rapita o catturata. Con l'avvento della proprietà privata, il matrimonio forzato portò il coraggioso guerriero a rinunciare alla sua parte di bottino sotto forma di mucche, di cavalli o di pecore per esigere il possesso assoluto di una donna, cioè il diritto di disporre interamente della sua forza lavoro. "Non ho bisogno di mucche, di cavalli o di animali a pelo lungo, accordami soltanto il diritto di possedere la donna che ho catturato con le mie mani". È abbastanza ovvio che la cattura e il rapimento da parte di una tribù straniera significarono per la donna la soppressione di qualsiasi uguaglianza di diritti. Si trovò così in una posizione subordinata e privata dei diritti in relazione a tutto il clan, ma in particolare riguardo a colui che l'aveva catturata, cioè di suo marito. Ciò nonostante, i ricercatori che attribuiscono la non emancipazione della donna al matrimonio hanno torto: non era l'istituzione del matrimonio ma soprattutto il ruolo economico della donna che fu la causa della sua mancanza di libertà fra i popoli di pastori nomadi.
Il matrimonio forzato, se si incontrava in alcune tribù di contadini, non violava i diritti delle donne, fermamente radicati in queste tribù. La storia ci insegna che gli antichi Romani rapirono le donne dei Sabini. Ma i Romani erano un popolo agricolo. E finché questo sistema economico prevalse, i Romani rispettarono profondamente le loro mogli, anche se le avevano strappate con la forza alle tribù vicine. La lingua attuale, per tradurre la considerazione che viene attribuita alla donna da parte della sua famiglia e del suo ambiente, la paragona ad "una matrona romana", cosa che è ovviamente una sopravvivenza di questo stato di cose. Col tempo, tuttavia, anche la posizione della donna romana si deteriorò.
I popoli pastori non hanno alcun rispetto della donna. È l'uomo che regna e questa dominazione, il patriarcato, esiste ancora oggi. Basta esaminare più attentamente le tribù di pastori e di nomadi delle repubbliche federali dell'URSS: i Baschiri, i Kirghisi e i Calmucchi. La situazione della donna in queste tribù è particolarmente desolante. È di proprietà del marito che la tratta come bestiame. La compera come compererebbe una pecora. La trasforma in bestia da soma e una schiava obbligata a soddisfare tutti i suoi desideri. Inutile aggiungere che la donna calmucca o kirghisa non ha diritto all'amore. Il nomade beduino, prima di concludere l'affare, mette un ferro rovente sulla mano della sua futura moglie per misurarne la resistenza.
Se la donna che si è comprato si ammala, la caccia da lui, persuaso di aver fatto un cattivo affare. Nelle isole Figi, l'uomo aveva ancora, fino a poco tempo fa, il diritto di uccidere sua moglie. Nei Calmucchi, l'uomo poteva legalmente uccidere sua moglie se lei lo tradiva. Invece, se fosse stata lei ad uccidere il marito, gli sarebbero stati strappati il naso e le orecchie.
In molte tribù selvagge della preistoria, le donne erano considerate a tale punto come proprietà dai loro mariti che erano obbligate a seguirli nella morte. Le vedove dovevano montare sulla pira preparata per l'incenerimento ed esservi bruciate. Quest'abitudine barbara è stata a lungo praticata dagli indiani d'America e in India come pure nelle tribù africane, tra gli antichi norvegesi e i nomadi slavi dell'antica Russia. In tutta una serie di popoli africani e asiatici, ci sono prezzi fissati per l'acquisto delle donne, come per l'acquisto delle pecore, della lana o della frutta. Non è difficile immaginare la vita di queste donne.
Se un uomo è ricco, può comperarsi molte mogli. Queste gli forniscono gratuitamente la loro forza lavoro e gli garantiscono una varietà nei suoi svaghi sessuali. In oriente, mentre l'uomo povero doveva accontentarsi di una sola donna, i membri della classe dominante erano in competizione per il numero dei loro schiavi domestici. Il re della tribù primitiva degli Aschanti possedeva da solo trecento donne. I re indiani contavano molte centinaia di donne. Lo stesso dicasi in Turchia e in Persia, dove donne infelici passavano la loro vita intera chiuse dietro le pareti degli harem.
In oriente, questa situazione si è perpetuata fino ai nostri giorni. Il vecchio sistema economico è rimasto invariato e costringe le donne alla prigionia e alla schiavitù. Ma questa situazione non è da attribuirsi unicamente all'istituzione del matrimonio.
Qualunque sia la forma del matrimonio questo dipende ancora dal sistema economico e sociale e dal ruolo della donna all'interno di quest'ultimo. Ritorneremo su quest'argomento più approfonditamente in un'altra serie di conferenze. Frattanto lo riassumiamo così: tutti i diritti della donna, tanto matrimoniali che politici e sociali, sono determinati unicamente dal suo ruolo nel sistema economico (ndt 3).
Vi farò un esempio attuale. È penoso vedere quanto la donna sia sprovvista di diritti tra i Baschiri, i Kirghisi e i Tartari. Ma appena un Baschiri o un Tartaro si stabiliscono in città e sua moglie riesce a guadagnarsi da vivere, il potere dell'uomo su sua moglie si sente seriamente indebolito.
Per riassumere la conferenza di oggi: abbiamo visto che la situazione della donna, ai primissimi stadi dell'evoluzione umana, differiva secondo i vari tipi di organizzazione economica. Dove la donna era la principale produttrice del sistema economico, era onorata e aveva diritti importanti. Ma se il suo lavoro per il sistema economico rivestiva un'importanza e un significato inferiori, occupava presto una posizione dipendente e senza diritti, diventando serva e anche schiava dell'uomo.
Grazie all'aumento della produttività del lavoro umano e all'accumulo delle ricchezze, il sistema economico si complicò col tempo. Fu allora la fine del comunismo primitivo e della vita nelle tribù chiuse in loro stesse. Il comunismo primitivo fu sostituito da un sistema economico basato sulla proprietà privata e lo scambio crescente, cioè il commercio. La società si divise ora in classi.
La prossima volta parleremo della situazione della donna in questo sistema economico.
* * *
ndt:
1) Per approfondire: Bebel, La Donna e il Socialismo - Biblioteca digitale Mels - resistenze.org
2) Indispensabile leggere: "L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato", Friedrich Engels - A110 anni dalla scomparsa trascrizione e conversione in html a cura del CCDP
3) Per un'analisi critica leggere: "Il processo «bloccato» di emancipazione femminile nella pratica sovietica" di Cristina Carpinelli - su Resistenze.org cultura e memoria resistenti - urss e rivoluzione di ottobre
Seconda conferenza - Il ruolo della donna nel sistema economico dello schiavismo
Compagne, l'ultima volta ci siamo fermate alla fase dello sviluppo della società che è caratterizzata dal passaggio ad un sistema economico fondato sulla proprietà privata.
Il comunismo primitivo è esistito per millenni. Questo periodo è durato considerevolmente più a lungo del suo successivo, che vede comparire la proprietà privata. La donna fu rispettata e considerata per migliaia di anni grazie al ruolo che giocava nel sistema economico delle popolazioni pacifiche praticanti l'agricoltura.
Il matriarcato ha regnato per lunghi periodi. Le leggende e i vecchi racconti popolari testimoniano l'alta stima di cui godevano le donne a quel tempo, come risulta dai racconti che hanno per tema le imprese delle Amazzoni, di provenienza tra l'altro della Grecia, dei paesi Baltici, dell'Africa e della Boemia. Uno di questi resoconti parla di 20.000 cavallerizze, un altro allude a un esercito di Amazzoni che avrebbe costituito una minaccia permanente per il potente impero egiziano. Duemila anni fa, le donne di una tribù germanica di contadini guerrieri presero parte attivamente ai combattimenti in occasione di un attacco romano e dispersero il nemico. Ancora oggi, la guardia del corpo principesca di una certa tribù del Dahomey (ndt 4) è composta da donne armate. Presso i Curdi, popolo del Caucaso, le donne sono famose per il loro coraggio e sono parte attiva in tutti i combattimenti.
Tutto ciò prova senza ambiguità che, in occasione di alcune fasi dello sviluppo socio-economico, la donna poteva essere non soltanto produttrice, ma soldato. La mobilitazione di tutte le forze disponibili da parte di una comunità ancora debole, per garantire la propria difesa, era allora una necessità assoluta. Nell'ultima conferenza, abbiamo constatato che la donna di quell'epoca e nelle tribù di agricoltori, godeva del più alto prestigio che doveva alla sua qualità di produttore principale. Tuttavia, nella stessa epoca, la situazione della donna nelle tribù di pastori era molto diversa. Passeranno secoli prima che l'asservimento della donna si generalizzi e che il dominio della donna appartenga definitivamente alla leggenda.
La supremazia dell'uomo, cioè del patriarcato e del diritto patriarcale, non è nata da un giorno all'altro. I vecchi racconti popolari dimostrano una lotta fatta di secoli tra matriarcato e patriarcato. I miti pagani ne sono un buono esempio. Una leggenda greca, che racconta le avventure del semi-dio Ercole, descrive il suo viaggio in un paese dominato da una tribù di Amazzoni guerriere: il viaggiatore decide di sbarazzarsi della sovranità delle donne e liberare gli uomini. Un'altra leggenda racconta come gli dei di Atene privino le donne dei loro diritti, poiché avevano usato il loro diritto di voto per chiamare la loro città "Athena", in onore della dea, anziché battezzarla del nome del dio Poseidone.
Le leggende germaniche che conosciamo, ad esempio Il canto dei Nibelunghi, descrivono con precisi dettagli i combattimenti di prodi guerrieri contro belle donne non meno bellicose, prima che queste si sottomettano diventando loro mogli. La bella Brunilde fu conquistata dal suo pretendente con l'inganno. Tuttavia, durante la prima notte di nozze, non solo non si arrese, ma continuò a combattere e sconfisse il suo eroe che appese al tetto con una cintura, prima di andare a letto in pace. I canti popolari russi mostrano anche la libertà e l'uguaglianza di cui godevano le donne non soltanto nella vita economica, ma anche sul campo di battaglia. Citiamo, ad esempio, l'eroe Dobrynja Nikitic che scopre "un cavaliere errante, donna", rappresentante certamente di una tribù in cui dominava ancora il matriarcato. Dobrynja inizia a combattere con lei. Lei lo afferra per la sua capigliatura riccioluta, "lo mette in un sacco" e gli spiega che consentirà al matrimonio soltanto se lui "canta".
Questi canti e questi racconti sono una miniera d'oro e altrettanto lo sono le testimonianze della lotta secolare tra patriarcato e matriarcato, manifestandosi anche nelle trasformazioni delle concezioni religiose. L'uomo delle caverne venerava la Terra, madre originale molto potente e fonte di vita. Questa credenza si perpetuò fino al giorno in cui l'uomo, più esperto, capì che la fertilità della terra dipendeva anche dal cielo. La terra, da sola, non poteva produrre un buono raccolto, se il cielo non dispensava sole e pioggia in quantità sufficiente. Allo stesso modo la donna resta sterile senza il seme del maschio, la terra non può verdeggiare e portare frutti senza calore ed umidità. Così la venerazione della terra, come divinità unica, cedette il posto all'adorazione del Sole, di Osiride e Apollo e al dio russo Jarilo.
La supremazia della donna - il matriarcato - si perpetuò fino a quando la comunità restò legata da interessi comuni e la donna costituì il principale produttore dell'economia primitiva. Il patriarcato si impose con la comparsa della proprietà privata (ndt 5) e con i conflitti di interessi che generò tra i membri della tribù. Occorreva impedire lo scoppio della tribù, non solo a causa di una solidarietà istintiva, sorta attorno al focolare domestico dove regnava la madre comune, ma in ragione dell'autorità del più forte.
Quali conseguenze comportarono la comparsa della proprietà privata per lo status sociale della donna? Molti credono che la schiavitù (ndt 6) e la dipendenza della donna siano comparse contemporaneamente alla proprietà privata. È falso. È vero che la proprietà privata ha contribuito a far decadere la donna dai suoi diritti, ma soltanto là dove questa aveva già perso la sua importanza come elemento produttore, a causa della divisione del lavoro. La donna cessò di essere rispettata appena il sistema economico primitivo crollò alla pressione dell'accumulo dei beni e della crescente divisione del lavoro.
Accanto all'agricoltura, si svilupparono, in fasi precise dell'evoluzione, differenti mestieri, come il vasaio, il conciatore, il tessitore, il soldato, il sacerdote, ecc., cioè specializzazioni in vari campi. Con lo sviluppo e l'espansione dell'artigianato il lavoro del contadino perse poco a poco della sua funzione e non fu più il solo a garantire la sopravvivenza del clan. La comparsa dei mestieri comportò necessariamente con sè quella del commercio di scambio, in altre parole la ricerca del profitto. Il vasaio che fabbricava una brocca di terracotta, non voleva rinunciare al prodotto del suo lavoro e rischiare così di perderci nello scambio. Il contadino da parte sua cercava di acquistare il prodotto del vasaio con una spesa inferiore. Non era più possibile, come all'epoca del comunismo primitivo, soddisfare soltanto le necessità e la sussistenza del clan. La caccia al profitto diventò veramente il motore dell'economia.
In questo periodo, il lavoro del vasaio, del conciatore o del tessitore acquisì più valore che quello del contadino. Il lavoro di quest'ultimo si deprezzò gradualmente. E ciò non perché l'agricoltura non occupasse più un posto essenziale nell'economia, ma perché esigeva un più grande investimento di manodopera. Appena l'artigianato raggiungeva un livello di sviluppo elevato nell'ambito di una tribù, il lavoro della terra veniva affidato agli schiavi catturati in guerra.
Quale era la situazione della donna in un simile sistema economico? Continuava a godere degli stessi onori precedenti mentre il lavoro agricolo aveva perso considerevolmente del suo valore ed era diventato appena buono per gli schiavi? Ecco un esempio tratto dalla storia: l'Egitto, paese assolutamente ricco e potente, conservò a lungo la situazione della sovranità delle donne, del matriarcato. Mentre ovunque e altrove alla stessa epoca, in paesi culturalmente molto evoluti come la Grecia e la Roma antica, le donne erano dipendenti e private dei diritti, in Egitto esse vivevano relativamente libere e in modo uguale agli uomini.
Come si spiega? Sui bordi fertili del Nilo, l'agricoltura fioriva come da nessun altra parte. La tribù che si era stabilita in Egitto era un popolo di contadini. Sappiamo ora che in una fase arretrata dell'evoluzione storica, le donne delle tribù di agricoltori sono state i principali produttori. La donna egiziana conservò questo ruolo con gli attributi ed i privilegi che si formarono durante secoli, nonostante la comparsa della proprietà privata e del regime delle caste. Quando il commercio e l'artigianato conobbero uno sviluppo più importante, i commercianti e gli artigiani soppiantarono i contadini e crearono un nuovo stile di vita. Perché? I mestieri di commerciante e di artigiano erano più proficui, poiché riportavano un guadagno più importante che il lavoro del contadino. Appena la proprietà privata riesce ad imporsi, la caccia al profitto sostituisce il lavoro nell'interesse della comunità. Una conseguenza logica di questa nuova evoluzione fu che la donna, perdendo il suo posto come produttore principale del sistema economico, perse allo stesso tempo la sua posizione privilegiata. Le donne che appartenevano a tribù e a caste molto stimate, furono le sole a potere conservare i loro diritti. Ma le donne delle altre categorie sociali (ad esclusione certamente delle donne schiave) persero i loro diritti e furono oppresse come le donne degli altri paesi.
Ci siamo volontariamente attardate sull'Egitto e la sua cultura per illustrare quanto i diritti della donna dipendano dalla sua importanza economica. Possiamo concludere anche che la donna riesce a conservare i suoi diritti chiaramente più a lungo nei popoli dove aveva occupato precedentemente una posizione di produttore principale. Questo stato di fatto si perpetuò anche quando il comunismo primitivo fu sostituito da un sistema socioeconomico fondato sulla proprietà privata.
La proprietà privata non avrebbe condotto all'asservimento della donna se questa non avesse già perso la sua importanza come principale responsabile del mantenimento della tribù. Ma la proprietà privata e la divisione della società in classi, formarono e condussero l'evoluzione economica in modo che il ruolo della donna nella produzione fu praticamente ridotto a zero.
L'oppressione della donna si ricollega alla divisione del lavoro che si basa sulla differenza dei sessi e dove l'uomo si è accaparrato tutto il lavoro produttivo mentre la donna si incaricava dei compiti secondari.
Mentre questa divisione del lavoro si perfezionò, la dipendenza della donna si rafforzò fino a a gettarla definitivamente nella schiavitù.
Formalmente, l'introduzione della proprietà privata accelerò il processo durante il quale la donna fu tagliata fuori dal lavoro produttivo. Quest'evoluzione tuttavia era stata già iniziata all'epoca del comunismo primitivo (ad esempio dalle tribù di allevatori). Ma, anche se la proprietà privata non può essere ritenuta la sola responsabile di questa situazione di diseguaglianza tra i sessi, contribuì fortemente a consolidare questa con la dipendenza e l'oppressione della donna.
Una conseguenza importante dell'introduzione della proprietà privata fu che l'economia domestica si staccò presto dall'economia omogenea e comunitaria che era stata fino ad allora quella della tribù. L'esistenza di queste organizzazioni economiche autonome comportò un tipo di famiglia sempre più chiusa e ripiegata su sè stessa. All'interno di quest'economia familiare isolata ed individuale, si assistette inoltre al rafforzamento della divisione del lavoro. I lavori produttivi all'esterno furono riservati ai membri maschili della famiglia, mentre la donna fu relegata ai suoi fornelli.
La proprietà privata familiare dunque, che permise l'economia domestica, contribuì con il lavoro limitato e improduttivo a domicilio all'asservimento della donna. Da un punto di vista economico, il lavoro della donna perse della sua importanza ed ella non tardò a essere considerata come una creatura sprovvista di valore e completamente superflua rispetto al rappresentante dei valori nuovi, cioè l'uomo.
La pala e la macina, che erano state precedentemente scoperte della donna, le furono sottratte a profitto dell'uomo. I campi stessi cessarono di essere dominio della donna. La sua esistenza libera e senza ostacoli ebbe fine. Fu confinata per secoli tra le quattro pareti della sua casa e fu esclusa da ogni lavoro produttivo. Da quel momento in poi non avrebbe più vegliato il fuoco come figura materna collettiva e nell'interesse di tutto il clan, ma soltanto come sposa e serva di suo marito. Doveva filare e tessere, preparare abiti e preparare il cibo della famiglia. Benché la fabbricazione del lino e della canapa sia restata fino ai nostri giorni e nelle campagne un'attività femminile, la donna non occupò nell'organizzazione economica contadina che una posizione secondaria.
Spero che ricordiate a grandi linee i contenuti dell'ultima conferenza. Passiamo ora all'analisi della situazione della donna nella fase seguente dello sviluppo economico e ci troviamo dunque a 2500 anni fa, cioè nell'antichità pre-cristiana. Non abbiamo più il problema dei clan selvaggi e poco civilizzati, ma Stati altamente evoluti che dispongono di eserciti potenti e dove esistevano la proprietà privata, grandi differenze di classi, un artigianato ed un commercio fiorenti. Il loro sistema economico era fondato sul lavoro servile, una forma transitoria dell'economia naturale ed un commercio di scambio più sviluppato. Vediamo apparire per la prima volta un accumulo del capitale sotto la sua forma più elementare.
Quale era il ruolo della donna in questa fase dell'evoluzione? Quali diritti aveva nelle repubbliche pagane della Grecia, di Roma e nella città libera di Cartagine?
E' quasi impossibile ora parlare del ruolo della donna nella produzione senza determinare prima la sua appartenenza di classe. Quando il sistema sociale di quest'epoca culminò sul piano economico, si suddivise in due classi chiaramente distinte: i cittadini liberi e gli schiavi. Solo il lavoro dei cittadini liberi era riconosciuto, anche se gli schiavi erano responsabili della fabbricazione del pane e di tutti gli altri prodotti di prima necessità. La stima di cui godeva un cittadino dipendeva dai servizi che rendeva allo Stato organizzato. Gli uomini di Stato, capaci di disciplinare la collettività e far rispettare l'ordine e la legge nella vita sociale, usufruivano del più alto prestigio. I guerrieri venivano immediatamente dopo. In compenso, i commercianti e gli artigiani avevano solo diritti limitati e gli schiavi, veri produttori della prosperità di tutti, non ne avevano assolutamente nessuno. Come era possibile? Perché i membri più utili alla comunità, che avrebbero occupato indubbiamente il primo posto nel periodo del comunismo primitivo, erano i più disprezzati?
Il principio fondamentale dell'inviolabilità della proprietà privata e del commercio fu responsabile principale di questo stato di cose. Quando un proprietario terriero poteva organizzare effettivamente i suoi schiavi, imporre loro una disciplina e costringerli a fabbricare i prodotti necessari alla popolazione, godeva della stima e della considerazione dei suoi contemporanei. Si riconosceva dunque soltanto il guadagno dello schiavista. Negli Stati molto sviluppati culturalmente, come lo stato greco e romano, la donna era completamente sprovvista di diritti, quasi schiava. Ma, anche in Grecia, la situazione della donna non era sempre stata così. Era differente quando la popolazione viveva ancora raccolta in piccole tribù e non conosceva né proprietà privata, né potere statale. All'origine, i greci erano un popolo di agricoltori e di pastori. Ma per ragioni allo stesso tempo climatiche e geografiche, furono obbligati molto presto ad evolvere verso una forma di economia più complessa. Le donne non lavoravano soltanto la terra, furono adoperate anche nella sorveglianza e cura delle immensi greggi, nella filatura e tessitura.
All'epoca di Omero - i suoi racconti poetici spiegano la vita dei greci antichi - le donne furono a fianco degli uomini, parte attiva nella produzione. Non erano completamente uguali nei diritti, ma tuttavia relativamente libere. Sembra difficile stabilire con certezza l'esistenza del matriarcato in Grecia. In ogni caso, poiché la popolazione greca conobbe precocemente una forma economica mitigata, possiamo supporre che il matriarcato non fosse così diffuso in Grecia tanto quanto in Egitto o in altri popoli più specificamente agricoli. Se si tengono conto delle loro religioni, la donna svolse tuttavia un ruolo importante presso gli antichi Greci.
Onoravano Demetra, dea della fecondità e non soltanto per la terra, come fu il caso in periodi più arretrati della storia dell'umanità. Attraverso la dea Atena, i greci veneravano la saggezza femminile. Gli uomini devono ad Atena - ma in realtà alle donne dei loro antenati - le arti della filatura e della tessitura, come l'invenzione dei pesi e delle misure e la coltura dell'ulivo. Altre religioni hanno riflesso la posizione della donna nei sistemi economici precedenti: gli antichi norvegesi, ad esempio, veneravano la dea Idun come protettrice e giardiniera del melo.
Dai greci, la giustizia non era rappresentata con la figura di un uomo, ma con quella di una donna, la dea Temis, che tiene i due piatti della bilancia. Ciò prova a sufficienza che, nel periodo pre-classico della Grecia, la donna aveva occupato una posizione dominante e che era essa stessa a regolare i conflitti interni alla famiglia.
La scoperta del fuoco è attribuita alla dea Estia (Vesta). Delle giovani vergini (le vestali) erano le custodi del fuoco sacro. La mitologia greca ci offre una grossa quantità di esempi che riferiscono della lotta tra il diritto materno e paterno. Questo tende a dimostrare che ci doveva essere stato un periodo durante il quale la donna come madre, dirigeva il sistema economico della tribù.
All'epoca di Omero, la donna presenziava ai banchetti ed era amata e rispettata come moglie. Gli uomini erano deferenti e attenti al suo riguardo. Ma non si trattava affatto di un sistema matriarcale. Omero ci racconta come Penelope, modello di sposa perfetta seppe attendere il ritorno del suo marito scomparso. Penelope, nel corso di una festa, ritenne che sua suocera non dovesse avere il suo posto fra gli invitati, che avrebbe fatto meglio a tornare nei suoi appartamenti e ad occuparsi dei lavori domestici.
Fu precisamente all'epoca di Omero che si imposero il matrimonio, la proprietà privata e l'economia familiare individuale. Non bisogna dunque stupirsi se in questo periodo economico, i greci iniziarono a predicare alle donne "le virtù familiari", incitandole a mostrarsi indulgenti verso le scappatelle extraconiugali dei mariti. Ciò permetteva non soltanto di ridurre il numero dei membri della famiglia, ma anche di evitare al padrone di casa di dovere nutrire bocche inutili. La moglie del re Priamo, Ecuba, si lagnava amaramente della sua sottomissione e diceva che si sentiva messa alla porta di suo marito come "un cane al suo posto nella cuccia".
Occorre ora esaminare la situazione della donna all'epoca in cui lo Stato greco si basava sulla proprietà ed il lavoro degli schiavi. Fu mentre sbocciava la cultura greca, costruita in tempi splendidi, che gli scultori crearono le immortali statue di Apollo e di Venere e che le città greche diventarono le metropoli del commercio internazionale, dove l'artigianato era fiorente e dove si aprirono scuole filosofiche rinomate, culle della scienza moderna, nello stesso periodo dunque in cui la donna dovette rinunciare alla totalità dei suoi vecchi diritti e privilegi e divenne la schiava domestica del suo signore e padrone, in breve, di suo marito.
L'uguaglianza dei sessi non esisteva all'epoca che tra gli schiavi. Ma di quale uguaglianza si trattava? Erano anche loro senza diritti, private di qualsiasi libertà ed oppresse, effettuavano gli stessi lavori spossanti e soffrivano al pari per la fame e di ogni specie di male. Le condizioni di vita degli schiavi sono spiegabili per la loro posizione senza diritti in stretto collegamento con il loro status sociale. Ma il fatto che le greche, libere cittadine di una repubblica culturale estremamente sviluppata, erano anche private dei loro diritti ed oppresse esige un'altra spiegazione.
Naturalmente, comparate agli schiavi, le donne di Atene e di Sparta erano cittadine aventi diritti e al tempo stesso anche privilegi. Ma questi li dovevano alla posizione del proprio marito e non ai loro meriti. Per loro stesse, non avevano alcun valore - come esseri umani e come cittadine - e non venivano considerate se non come complementi dei propri mariti. La loro vita intera era posta sotto tutela, inizialmente sotto quella del padre, poi sotto quella del marito. Non avevano il diritto di assistere alle feste che segnavano la vita pubblica in Grecia. Le cittadine della Grecia libera, di Cartagine e di Roma non conoscevano altro che l'universo stretto del focolare. Erano interamente occupate a filare, tessere, cucinare e sorvegliare i servi e gli schiavi della casa. Le donne più ricche erano anche dispensate da questi compiti. La loro esistenza si svolgeva negli appartamenti che erano riservati loro. Emarginate ed isolate da qualsiasi forma d'attività, conducevano in un'atmosfera soffocante una vita da eremita, molto poco distante da quella alla quale saranno condannate le donne e le ragazze dell'aristocrazia russa, di numerosi secoli più tardi.
Il satirico autore Aristofane ha descritto con ironia la vita delle donne ricche: "Porta abiti zafferano, si copre di trucchi, calza sandali alla moda, vive del lavoro del proprio marito e dei suoi schiavi e rimane di fatto un parassita". Non ci si deve stupire dunque se, dal punto di vista dell'uomo, il compito della donna finisce per ridursi al parto. Era innalzata in funzione "del focolare". Anelava ad essere "virtuosa", cioè disinteressata e stupida. Le donne più apprezzate erano quelle che non trovavano nulla da ridire né nel bene, né nel male. Da un lato, l'uomo poteva vendere la donna adultera come schiava; dall'altro, poteva procurarsi una prostituta quando la moglie virtuosa iniziava ad annoiarlo. Fuori dal matrimonio monogamico legale, la poligamia illegale era però generalmente accettata e molto diffusa in Grecia: "Come procreatrice e casalinga, la sposa ufficiale, una schiava per l'asservimento delle necessità della carne e un'etera per la soddisfazione della vita intellettuale ed affettiva".
Nelle repubbliche greche e romane così fiere delle loro culture e delle loro ricchezze, la donna del cittadino libero era dipendente per tutto e priva di diritti, come i servi e gli schiavi che ella comandava a bacchetta in nome di suo marito. Le donne della tribù dei Balonda vivevano probabilmente in una capanna di bambù, ma erano nettamente più libere ed eguali all'uomo, che le loro compagne dell'epoca greca o romana che abitavano in case di lusso.
Come era possibile? Come si può spiegare questa assenza di diritti per le donne, mentre le società di cui facevano parte beneficiava parallelamente di una crescita economica e culturale prodigiosa?
Non dovrebbe essere difficile indovinarlo, compagne. Vedo sui vostri visi che avete compreso. Le donne della tribù africana Balonda effettuavano un lavoro produttivo per la comunità, mentre le greche, sempre che facessero qualcosa, erano occupate soltanto da lavori domestici nel quadro limitato della famiglia. In una fase molto precoce dello sviluppo sociale, la donna greca era stata anche una forza produttrice importante per la collettività. Tuttavia, con l'arrivo della proprietà privata e da quando la produzione si è basata sul lavoro degli schiavi, si era trasformata poco a poco in strumento di procreazione. Ricordate dunque, compagne, che in una società tanto illuminata come la Grecia o anche Roma, con le loro innumerevoli colonie e nella città libera di Cartagine, anche le donne delle classi dominanti non godevano di alcun diritto, né di alcun privilegio. Tuttavia, dobbiamo tenere conto del fatto che in Grecia il matriarcato si era poco sviluppato, che il patriarcato ha potuto così imporsi molto presto e che la donna è caduta rapidamente in una grande dipendenza. In compenso, nella repubblica romana, permanevano vestigia del matriarcato mentre Roma era già il paese più potente del mondo. Anche quando la proprietà privata era protetta dalla legge e gli schiavi effettuavano il lavoro produttivo, la matrona romana godeva sempre della stima e del rispetto di tutti. Nelle vie, i cittadini liberi si scostavano al suo passaggio per cedergli il posto. A casa, la sua autorità restava incontestata ed era la madre che educava i bambini.
A che è dovuta questa differenza? Il regno romano fu fondato da una tribù di agricoltori. È per questo che il matriarcato era ancorato profondamente nel passato di questa società e continuò ad influenzare queste fasi di evoluzione ulteriore.
Accanto alle donne schiave, alle virtuose spose, esisteva anche in Grecia un gruppo autonomo di donne indipendenti, le etere. Erano le amanti dei grandi uomini della Grecia. Le etere erano sia delle cittadine libere, sia delle schiave affrancate, che trasgredivano coraggiosamente le leggi morali del matrimonio. Numerose etere sono entrate nella storia, come Aspasia, l'amica del famoso uomo di stato Pericle, come Lais, Frine o Lamia. Queste donne erano molto colte e si interessavano alla scienza e alla filosofia. Erano politicamente attive ed influenzavano gli affari di Stato. Le mogli rispettose e virtuose le fuggivano. Gli uomini, invece, apprezzavano la loro compagnia.
Succedeva così, che i filosofi ed i pensatori dell'epoca erano ispirati dalle idee e dai pensieri nuovi di queste etere colte. Contemporanei hanno testimoniato l'amicizia tra il celebre filosofo Socrate ed Aspasia, come pure i brillanti discorsi politici di quest'ultima. Frine ispirò il famoso scultore Prassitele e Lamia, che vissero nel V secolo prima della nostra era, svolgendo un ruolo determinante in una cospirazione contro due tiranni che si erano accaparrati tutto il potere nella repubblica. Fu, così come i suoi compagni, che avevano lottato per la libertà, gettata in prigione e crudelmente torturata. Per non denunciare, si tagliò la lingua di colpo tra i denti e la sputò sul viso del giudice.
L'esistenza delle etere è la prova che la donna cercava al tempo di liberarsi della soffocante prigione che gli era stata attribuita e che rappresentava la sua dipendenza. Mancava tuttavia alle etere una condizione essenziale e capitale al successo: non effettuavano alcun lavoro produttivo. Per l'economia nazionale non avevano più valore delle mogli ignoranti e limitate degli uomini greci e romani. Le libertà ed i privilegi che avevano conquistato erano costruiti sulla sabbia; da un punto di vista materiale, dipendevano dagli uomini, ora come prima.
In Grecia, c'erano anche delle donne isolate che portarono un contributo importante alla scienza, all'arte ed alla filosofia. La poetessa greca Saffo, ad esempio, fondò una scuola per le sue amiche. Agnodice la prima dottoressa, si era travestita da uomo per poter seguire gli studi, dopo di che iniziò a curare i pazienti. Ad Alessandria viveva una donna professoressa e filosofa, donna estremamente colta e inoltre molto bella. Attorno ad essa si raccolse un cerchio di eruditi e di curiosi venuti dal mondo intero. Tuttavia, questa donna trovò una morte tragica. Fu letteralmente smembrata da una folla cieca e scatenata, aizzata da sacerdoti invidiosi. Ciò avveniva all'inizio del cristianesimo. Queste belle e potenti figure di donne dimostrano ciò di cui la donna fosse capace quando la sua ragione, il suo cuore e il suo spirito non erano distrutti da un'esistenza degradata tra le quattro pareti del suo focolare. Purtroppo, queste donne rare e coraggiose non avevano alcun potere reale sull'atmosfera generale dell'epoca, segnata dal parassitismo e dall'ozio delle donne. Erano eccezioni e per questa ragione incapaci di cambiare nulla nelle condizioni di vita femminile e che occupavano nell'economia un ruolo poco importante. Certamente, molte donne soffrivano per la loro situazione senza diritti ed alcune tentarono di seguire la loro via, ma la maggior parte perseverava nel proprio ruolo di schiava del focolare, dell'uomo e della famiglia.
Le donne sentivano istintivamente che l'economia domestica, la proprietà privata ed il matrimonio legale erano i principali ostacoli alla propria liberazione. Nella "Assemblea delle donne", commedia del celebre autore greco Aristofane, sono ridicolizzate perché vogliono introdurre un ordine nuovo e prendere esse stesse in mano il destino dello Stato. È soprattutto interessante notare che l'eroina di questa commedia, Prassagora, raccomanda la proprietà comune. "Chiedo - dice Prassagora - che tutto diventi comune, che tutto appartenga a tutti, che non ci siano più né ricchi, né poveri. Ciò non può durare più a lungo, che alcune persone regnino su campi immensi, mentre il piccolo lotto di terra che possiedono gli altri basta appena per collocare la propria tomba. La donna deve essere proprietà di tutti. Ciascuno deve avere diritto di fare bambini con chi vuole". Così le donne protestavano contro la proprietà privata, il matrimonio forzato e la dipendenza, nel 400 a.C., cioè circa duemilatrecento anni fa. Il sogno di un'organizzazione comunista, che avrebbe potuto restituire la donna alla sua tutela, doveva essere così generalmente diffuso che il celebre Aristofane poté trasporlo nelle sue commedie molto conosciute ed accessibili a tutti. Le donne vedevano in un sistema di organizzazione comunista, la possibilità di liberarsi dalla loro situazione, probabilmente anche perché la lingua popolare ricordava il loro passato felice all'epoca del comunismo primitivo. In ogni caso le greche avevano completamente ragione di pensare che fosse impossibile cambiare alcunché nel ruolo femminile, senza uno sconvolgimento radicale della società greca intera, che si basava sulla divisione delle classi e il lavoro degli schiavi. I tentativi di donne isolate per strappare la grande massa delle donne alla loro schiavitù fisica e mentale, dovevano fallire dunque interamente. Sono trascorsi più di venti secoli prima che il sogno di Prassagora diventasse realtà. La Russia attuale è tuttavia la prova vivente che Prassagora aveva ragione quando credeva che l'affrancamento della donna fosse possibile soltanto con il comunismo.
* * *
ndt:
4) attuale Benin
5) Indispensabile leggere: "L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato", Friedrich Engels - A110 anni dalla scomparsa trascrizione e conversione in html a cura del CCDP
6) Per nozione di schiavismo consulta il Dizionario enciclopedico marxista su Resistenze.org
Terza conferenza - La condizione della donna nell'economia naturale dell'autosufficienza
Compagne, la nostra ultima conferenza terminava con la descrizione della situazione della donna nell'antichità, quando la proprietà privata, il commercio e l'artigianato esistevano già e il lavoro era segnato dall'assenza di libertà e dalla schiavitù. Accanto al lavoro degli schiavi, c'erano naturalmente i primi abbozzi di artigianato libero. Ma il lavoro produttivo garantito dagli schiavi era la base di questo sistema economico.
La donna era condannata a vivere tra le quattro mura della sua casa e perse poco a poco ogni tipo di significato per il sistema economico. Cessò presto di essere "un'unità di lavoro" che contribuisce in un modo o nell'altro alla prosperità dello Stato e della società. Il suo ruolo si limitò sia a quello di riproduttrice, che genera bambini per il suo uomo, sia a quello di oggetto di piacere, sia che questo fosse sotto la variante grezza della schiava o sotto quella, più rilevante, dell'etera. Le condizioni economiche dominanti trasformarono le donne in parassiti della società.
La vita delle donne-schiave si svolgeva ai margini della società invalsa. Curve sotto il giogo della dura fatica, condividevano la sorte con i compagni di disgrazia, gli uomini-schiavi. Qualunque cosa accadesse, il loro lavoro non fu mai riconosciuto per ciò che era: di fatto, la fonte di ogni prosperità.
Non era il lavoro, ma il reddito e il profitto che erano apprezzati. Progressivamente, in queste vecchie società pre-cristiane, apparve il primo proletariato (ndt 7) della storia, come pure la lotta tra le classi. Gli Stati dell'antichità furono rovinati da queste lotte di classe, ma anche dall'insufficienza del loro sistema di produzione che si basava sul lavoro forzato degli schiavi. Uno Stato dopo l'altro sprofondò nella decadenza, si disgregò e scomparve. Gli Stati dell'antichità furono respinti dai nuovi popoli che praticavano altre forme di organizzazione economica. Abbandoneremo dunque le vecchie civiltà per passare a un periodo più vicino a noi: il Medioevo.
In tutta l'Europa dell'epoca - cioè tra gli 8 e i 900 anni fa - era il tempo del regno dell'economia naturale, che dipendeva non più, come nell'antichità, dal lavoro degli schiavi, ma da quello dei contadini servi. I contadini non regalavano più la totalità dei frutti del loro lavoro al grande proprietario terriero. Una parte dei prodotti serviva a migliorare le condizioni di vita dei servi. Ben inteso, il servo doveva versare imposte al signore, sotto forma di compensi in natura o di servigi effettuati.
Tuttavia, conservava una parte dei prodotti e poteva farne ciò che meglio gli sembrava. Poteva, ad esempio, scambiarli con altri prodotti. Da questi scambi che avvenivano in posti precisi sorsero i mercati. Questi si svilupparono presto in maniera regolare e videro nascere in città luoghi di scambio e di commercio. Se queste città si trovavano sulle terre del proprietario, le considerava come sue e le tassava anche. Ma c'erano anche città libere (città franche) che si sono sottratte alla dominazione dei boiardi e dei cavalieri.
Le nostre città libere, Novgorod e Pskov, ne sono un esempio. La popolazione era divisa in tre classi: quella dei proprietari terrieri, quella dei contadini e quella dei borghesi. Mentre il Medioevo era al suo apice - tra il 900 e il 1300 - la condizione della donna era molto differente a seconda della classe alla quale apparteneva. Ma all'interno di ogni classe sociale, la sua posizione era determinata da un unico fattore, in questo caso dal suo ruolo nella produzione.
Innanzitutto, analizzeremo le condizioni di vita della grande nobiltà e dei boiardi. Quando il feudalesimo (ndt 8) raggiunse il suo culmine e tutto il potere fu concentrato nelle mani dei grandi proprietari terrieri e della nobiltà, il sistema economico si basava sull'economia naturale. Ciò significava che tutti i beni di consumo necessari al proprietario terriero - signore feudale con proprietà immense - e ai suoi contadini servi, erano fabbricati dai servi stessi all'interno dei confini della proprietà. Il commercio di scambio era insolito (al di fuori di questi confini). Il modo di vivere e l'economia domestica di quel tempo ci sono stati trasmessi da resoconti di questa epoca.
Il castello del proprietario feudale rappresentava il centro economico. I domestici erano servi. Tutto ciò di cui il castello aveva bisogno - e questo conteneva numerosi abitanti, in primis la famiglia vicina e lontana del signore, poi gli ospiti, il domestici, i custodi ed i soldati - era prodotto sul territorio della proprietà.
I servi pagavano il loro canone in materie prime - pelli, lana, carne e cereali - che portavano al castello o in Russia, alla casa del nobile proprietario. Il trattamento di queste materie prime era realizzato all'interno del castello. L'economia domestica dei signori feudali era estremamente complicata e richiedeva pertanto un organizzatore competente. E chi erano abitualmente nel Medioevo, in Francia, in Inghilterra e in Germania, gli organizzatori dell'economia domestica feudale? Il proprietario terriero, il signore o il cavaliere in persona? In generale, il padrone di casa era troppo occupato a combattere o a saccheggiare. È per questo che abbandonava l'amministrazione del suo castello a sua moglie.
Era lei che raccoglieva le tasse dai contadini nei tempi giusti. Sarti, ciabattini, maniscalchi ed altri artigiani lavoravano sotto la sua sorveglianza. Si tessevano panno fine o lino grezzo, si fabbricavano pizzi o si forgiavano elmi. La donna del signore faceva anche macinare la farina ed era responsabile della riserva di provviste per l'inverno. La cantina del castello conteneva centinaia di barili di vino e di birra, i negozi erano forniti di ogni specie di merce. Tutto questo era consumato nel castello, sia da parte del signore stesso e dei suoi ospiti, che dai servi e dai soldati e doveva essere prodotto sul posto. Nulla poteva essere comperato. I commercianti visitavano di tanto in tanto il castello e bene vi erano accolti. Ma di solito avevano solo merci straniere da proporre o articoli di lusso: seta orientale, vetro lucidato veneziano, armi o pietre preziose.
Va da sé che le donne che appartenevano alla classe dominante erano rispettate come organizzatrici della produzione. Secondo i diritti consuetudinari tedeschi, inglesi e francesi, la donna poteva ereditare titoli e proprietà da suo marito.
All'inizio del XI secolo, dopo che le crociate avevano fortemente decimato gli eredi maschili, questo diritto ereditario feudale diventò legge in Inghilterra, nelle Fiandre, in Borgogna e Castiglia. I cronisti del Medioevo celebrarono con entusiasmo la saggezza e l'umanità degli amministratori femminili delle proprietà feudali. Quando Eleonora, sovrana di Aquitania, sposò il re di Francia, tutto il suo popolo pianse. Le cronache riferiscono come Eleonora si prendesse cura dei suoi subordinati, come avesse ridotto i dazi doganali per facilitare il commercio, come garantisse legalmente l'auto-amministrazione delle città, per proteggerle dall'arbitrariato dei proprietari terrieri. Apprendiamo anche quanto fosse caritatevole.
Gli storici e i cronisti popolari osannarono quasi negli stessi termini Anna di Bretagna. La principessa Olga, che fu la prima russa di origine principesca a convertirsi al cristianesimo, sopravvive tutt'oggi nella memoria del popolo per essere stata una saggia sovrana. Secondo il vecchio diritto francese, il potere del padre sulla famiglia era trasmesso, in caso d'assenza o di morte, alla madre. Era considerata tutrice dei suoi bambini. Come le contesse e le principesse, le donne delle famiglie possidenti esercitavano anche la funzione di giudice. Le badesse avevano privilegi simili. Succedeva anche che le giovani potessero ereditare il diritto a rendere giustizia. Alcune donne assistevano dunque alle sedute dei tribunali dell'epoca e si coprivano con un berretto da giudice.
Durante l'assenza del signore, la moglie non aveva soltanto tutto il potere sui suoi servi, ma anche sui suoi vassalli, cioè i proprietari di domini più piccoli, che dipendevano direttamente dal signore feudale. Era suo dovere preservare l'onore del suo blasone. In occasione delle feste e dei tornei, si sedeva al posto d'onore. I tornei di cavalieri erano allora un passatempo molto in auge nell'alta società. Le donne erano venerate dai cavalieri; i poeti e i trovatori ne cantavano le virtù. Il più grande dovere del cavaliere era "difendere la donna". Se un cavaliere incontrava una donna, scendeva dal suo cavallo. Ogni cavaliere aveva "una signora nel suo cuore" che ammirava a distanza, senza la più piccola speranza di vedere il suo desiderio realizzato. Tuttavia, tali omaggi si rivolgevano soltanto alle donne delle classi della nobiltà. Il cavaliere non aveva alcun sentimento di dovere o di rispetto nei confronti delle donne degli altri strati sociali.
Mentre la donna, in quanto rappresentante della nobiltà, godeva di un certo status, poiché il suo ruolo di organizzatrice dell'economia domestica feudale rafforzava il potere del signore, i suoi diritti venivano contemporaneamente calpestati come essere umano ed individuo. La duchessa o la margravia, dinanzi alla quale tremavano centinaia di servi e che anche i giovani aristocratici non osavano fiatare, poiché era essa che, secondo l'usanza e in mancanza del marito, teneva il timone, questa donna potente dunque tremava di paura davanti a suo marito, essendo niente di diverso che la sua proprietà e la sua schiava.
In questo periodo in cui la nobiltà era al potere, regnava il diritto del più forte. Il cavaliere, proprietario terriero, doveva il suo potere alle spedizioni di saccheggio e ai suoi atti di violenza e di vandalismo. Il capofamiglia esercitava la sua sovranità sui suoi subordinati, vassalli e servi e garantiva la sua supremazia sulla totalità del suo territorio. Il potere del padre e del marito non avevano mai rivestito nell'antichità forme così caricaturali come nel Medioevo. Il terrorismo che esercitava il proprietario terriero paralizzava tutti i suoi sudditi. Aveva tutti i diritti su sua moglie e sui suoi figli. Poteva, ad esempio, maltrattarli, ridicolizzarli, cacciarli o anche lasciarli in eredità ad un amico, insieme al miglior cavallo o alla migliore spada rubata ai Saraceni, se tale fosse stato il suo desiderio. Fino al XII secolo, poteva giocarseli ai dadi. Se la moglie gli fosse stata infedele o se si fosse resa differentemente colpevole, era legittimato ad ucciderla. L'onnipotenza dell'uomo era allora illimitata. Così l'elegante e fiera contessa, che non si abbassava a rispondere al saluto di un cavaliere di piccola nobiltà, strisciava in ginocchio davanti a suo marito quando quest'ultimo era di cattivo umore e si rassegnava silenziosamente alle sue percosse e ai suoi maltrattamenti.
In Inghilterra, oltre alle contesse e alle principesse, anche le grandi proprietarie terriere avevano diritto al voto in occasione delle elezioni parlamentari. Le loro mogli persero questo diritto soltanto gradualmente, nella misura in cui la struttura sociale generale si modificò con l'emergere delle condizioni della società borghese (anche in un periodo così tardivo come il XVII secolo, la proprietaria terriera inglese, Anne Clifford, cercava di riconquistare i suoi vecchi diritti). Allo stesso tempo, il marito ingannato poteva vendere sua moglie all'asta. Come spiegare la natura contraddittoria della situazione delle donne delle classi benestanti? Molto semplicemente: famiglia e clan familiare esercitavano nel Medioevo un controllo assoluto sui propri membri e all'interno della famiglia, segnata dal clima di brigantaggio e di illegalità generale che regnava al tempo, quello che aveva più potere era colui che difendeva meglio gli interessi della famiglia e del clan di fronte all'ostilità del mondo esterno. (ndt 9)
Qualunque fosse stata l'utilità del lavoro svolto dalla donna nell'ambito dell'economia feudale, il mestiere delle armi tuttavia rivestiva un valore maggiore. In che modo le entrate e le ricchezze del principe o di un conte aumentavano in modo certo e più visibilmente? È ovvio che il patrimonio della famiglia aumentava più rapidamente con il saccheggio dei vicini e dei contadini, che mediante il lavoro pacifico economico. È per questo che anche la gestione della donna rivestiva agli occhi della nobiltà soltanto un aspetto secondario. E il fatto che sia stato possibile arricchirsi in questo modo, saccheggiando i beni di altri, rafforzava naturalmente la popolarità dei redditi acquisiti fuori del lavoro. Ciò condusse presto al disprezzo di qualsiasi forma di lavoro.
Queste condizioni spiegano il carattere contraddittorio della condizione della donna: da un lato, aveva diritto, come moglie del signore, a titoli e a proprietà, esercitava sui suoi subordinati sovranità assoluta - spesso delle donne governavano sui regni - ed aveva lo stesso potere assoluto sui suoi servi come un uomo nella sua posizione, cioè potevano cacciarli, punirli, torturarli ed anche ucciderli; d'altra parte, rispetto al capofamiglia, queste donne non possedevano i diritti umani più elementari. Per quanto riguarda la loro situazione nell'ambito del matrimonio, le mogli dei grandi proprietari terrieri del Medioevo erano ugualmente senza diritti ed oppresse come le donne delle tribù di allevatori.
In Russia, la situazione delle donne della nobiltà era ancora meno invidiabile. Queste avevano partecipato attivamente al lavoro come organizzatrici dell'economia soltanto durante un tempo estremamente breve della storia della Russia. Molto presto, furono soppiantate dagli elementi maschili della famiglia o da amministratori. Da allora, il dovere della donna dei boiardi consistette solo nel concepire eredi necessari a conservare la razza.
Il diritto paterno si impose molto presto in Russia. La dominazione dei Tartari (tribù di pastori nomadi le cui donne erano totalmente oppresse) non ha solo rafforzato le condizioni già esistenti, cioè il potere illimitato dell'uomo sulla donna. Ciò nonostante e fino al XI secolo, le vestigia di un matriarcato molto antico continuarono a trasmettersi con le leggende popolari. La donna dell'antica Russia avrebbe disposto di proprietà senza permesso speciale del marito. Prese parte alle deliberazioni giudiziarie e procedeva all'arbitrato. E secondo le prime leggi russe - "il diritto russo" fu scritto soltanto alla XII secolo - la filiazione si faceva da parte di madre e non da parte di padre.
Questa è una prova manifesta che esisteva tra i popoli slavi arcaici una miscela predominante di matriarcato, di comunismo primitivo e di economia agraria. Il diritto paterno si impose in Russia soltanto con il passaggio ad un'organizzazione economica più complessa e dopo l'introduzione dell'allevamento che richiedeva soltanto una piccola quantità di bestiame ed era, inoltre, più proficuo. Così l'agricoltura svolse presto soltanto più un ruolo secondario all'interno del sistema economico dell'ex Russia. Ma, fra i contadini della Russia settrentrionale, la memoria della posizione dominante della donna nel sistema economico rimase tuttavia viva a lungo. Si perpetuò attraverso le ballate e i ritornelli popolari che si cantavano ancora mentre l'oppressione della moglie del proprietario terriero e quella della moglie del contadino erano manifeste.
Qualora foste particolarmente interessate dal destino della donna russa, procuratevi l'opera di Siskov sulla storia della donna russa. Vi troverete numerose e molto interessanti descrizioni che riportano come la donna fu poco a poco trasformata in serva della famiglia. D'altra parte, questo processo si svolgeva parallelamente all'introduzione della proprietà privata e del diritto del più forte.
L'ignoranza del giovane aristocratico e la sua posizione subordinata rispetto alla sua famiglia furono rafforzate dalle esigenze del clan. Il suo destino era fissato da altri: nella nobiltà, era soprattutto il padre che decideva, ma altri membri più anziani d'età della famiglia potevano dire la loro quando si trattava della scelta del partner. Il suo matrimonio era un affare di famiglia. Si trattava soprattutto di proteggere gli interessi della casa. I matrimoni non erano realizzati per ragioni di sentimento, ma soltanto per ragioni d'ordine materiale. Sia che si cercasse di aumentare il proprio dominio con la dote della nuora, sia che si volesse calmare un vicino bellicoso proponendogli, a lui o a uno dei propri figli, la propria figlia in matrimonio.
Ciò permetteva di raddoppiare la propria potenza, la fortuna o anche il titolo della propria casa, mentre si riunivano due titoli in uno, ecc. Queste erano le vere ragioni di questi matrimoni. Spesso i fidanzati non si erano mai visti prima del giorno della cerimonia nuziale. Arrivavano generalmente da regioni distanti e non era raro che si fidanzassero dei bambini tra i cinque e i sette anni. Nel medioevo, il matrimonio tra minori era normale. Il duca di Bouillon, completamente rovinato, sposò una bambina di dodici anni per l'importanza della sua dote. Il marchese di Eauoise si fidanzò con una bambina di due anni, poichè il futuro suocero si era dichiarato pronto a versare annualmente una parte della dote al futuro marito. La saggia e lungimirante contessa Adelaide di Savoia promise al successore al trono di Germania la mano di sua figlia Berthe mentre il fidanzato e la sposa non avevano ancora sei anni. C'erano anche genitori che cercavano fidanzate per il loro figlio non ancora nato. L'assenza di diritti dei giovani e delle ragazze rispetto alla famiglia era uguale a riguardo, i loro matrimoni erano conclusi collettivamente dal clan familiare.
Tale violazione degli interessi individuali fu ancora a lungo diffusa fra i nostri contadini russi. Si trattava allora di preservare gli interessi economici dell'azienda agricola familiare. I genitori concludevano i matrimoni sulla testa dei loro figli. È soltanto la rivoluzione che mise fine a queste abitudini immorali ereditate del Medioevo abolendo completamente il vecchio diritto paterno.
Non è difficile immaginare ciò che poteva essere la vita di una donna sposata contro la sua volontà dai suoi genitori ed il cui marito aveva inoltre la legge dalla sua parte. Per la nobiltà di questo tempo, il matrimonio rivestiva un solo significato: doveva garantire la perpetuazione dell'illustre lignaggio. La capacità di una donna di generare bambini e garantire la discendenza della famiglia era pertanto molto apprezzata. È per questo che la sua infedeltà era così rigorosamente punita. Introducendo un bastardo nella famiglia, sporcava la nobiltà del proprio sangue. Nel caso di adulterio, l'uomo non era soltanto autorizzato legalmente a cacciare in modo disonorevole sua moglie, poteva anche torturarla ed anche ucciderla.
La difesa degli interessi della famiglia richiedeva misure di protezione contro eventuali mescolanze. Se un semplice mortale mescolava il suo sangue impuro con il sangue blu di una figlia di aristocratici, questa era immediatamente diseredata e relegata in convento o uccisa. La sterilità di una donna non era soltanto una sfortuna, ma era anche disonorevole. Un uomo, la cui donna non poteva dare eredi, era autorizzato a divorziare. Innumerevoli donne di signori e di cavalieri furono condannate ad una vita di nubilato in convento, mentre i loro mariti prendeva altre donne. L'ideale dell'epoca era una donna sana e fertile, capace d'altra parte di dirigere e amministrare una famiglia.
L'importanza attribuita alla produttività della donna si tradusse nel tempo con una serie di leggende tessute attorno a questo tema. Si raccontò ad esempio che la moglie del conte Henneberg aveva partorito 364 bambini. In occasione del battesimo tutti i ragazzi ricevettero il nome di Ivan, le ragazze quello di Elisabetta.
Mettere al mondo figli non era tuttavia sufficiente. Il dovere di una moglie, di una madre e di una casalinga, erano anche di vegliare sull'istruzione dei propri figli e fungere loro da esempio. La più importante e la più nobile delle regole di vita dell'epoca, era di piegarsi completamente e senza vacillare alla volontà dell'uomo. Numerosi scritti del Medioevo raccomandavano questo ideale di donna. Nei loro manuali di buona educazione, i difensori feroci dell'ordine che regnava dispensavano alle donne della nobiltà istruzioni adeguate al loro rango, nonchè saggi consigli agli sposi.
Quale importanza potevano ben rivestire i compiti delle donne nell'ambito delle famiglie di una società che si basava sulla forza, il lavoro dei servi e l'assenza totale di diritti umani per le donne? In quale dominio dell'economia la donna poteva prendere parte attiva?
Nel XIV secolo, lo scrittore italiano, Barberino (Andrea di Jacopo da Barberino ndt), divenne popolare con i suoi scritti in cui consigliava alle ragazze di comportarsi degnamente, cioè di rimanere a casa ad aiutare la loro madre nei lavori domestici. Barberino era anche del parere che avrebbero potuto completamente risparmiarsi l'apprendimento della lettura e della scrittura. Il pope russo Silvestro dispensava consigli simili nella sua famosa opera "Precetti di vita domestica".
Questi manuali consigliavano ai mariti di vegliare affinchè le loro mogli vivessero nella virtù e nel timore di Dio. E per raggiungere questo obiettivo, il ricorso alle punizioni corporali e ad altri metodi coercitivi non era in nessun modo da escludere. Tuttavia, quando l'organizzazione economica feudale raggiunse il suo apice (900-1200), le donne, nonostante il loro asservimento nell'ambito della famiglia o che fossero d'origine aristocratica, ricevettero un'educazione relativamente adeguata per l'epoca. Le ragazze di famiglie nobili apprendevano non soltanto a cucire, filare e tessere, ma anche leggere, scrivere, cantare e ballare. Ottenevano inoltre certe informazioni sulle scienze dell'epoca. Generalmente apprendevano anche il latino.
La formazione nei conventi inglesi includeva la lettura, la scrittura, la conoscenza della Bibbia, della musica, la cura dei malati, il disegno e la cucina. Le donne conoscevano spesso il latino (tutti gli scritti scientifici dell'epoca erano allora redatti in latino) e possedevano a volte conoscenze solide di astronomia e ciò nonostante il fatto che gli uomini - cavalieri e soldati intrepidi - fossero generalmente analfabeti. Spesso, cavalieri, signori di fama e proprietari di territori immensi, conservavano per settimane la lettera della loro amata, fino al momento in cui incontravano un fratello di armi che sapesse leggere e scrivere.
Molti di loro avevano assunto una scriba, incaricata di garantire la corrispondenza con la propria amata, mentre la donna credeva di corrispondere con il suo amante. E poteva, grazie alle sue lettere, provare una compassione profonda per "il cuore" dell'amato. Immaginate ciò che sarebbe avvenuto se avesse saputo che apriva il suo cuore ad una scriba. Uno dei poeti cortesi più famosi dell'epoca, Wolfram von Eschenbach, era incapace di trascrivere le sue poesie e dipendeva da copisti femminili.
La storia ci trasmette un lungo elenco di donne scrittrici e pensatrici che divennero famose nel corso degli anni bui dell'alto Medioevo. Nel X secolo, la monaca Roswitha scrisse drammi religiosi e tutta una serie di racconti scientifici. Nell'VIII secolo, dunque in un periodo ancora più arretrato, viveva in Inghilterra una badessa, Elfleda, famosa per la sua grande saggezza. Missionaria entusiasta al servizio della Chiesa nascente, assistette a concili ecumenici, cioè a conferenze internazionali su questioni religiose. Un'altra monaca, Ildegarda - che visse nell'XI secolo - era diventata famosa come filosofa. Al riparo dalle macchinazioni della Chiesa, rifiutò di abbandonare il proprio pensiero come avrebbe voluto la fede ed affermò apertamente le sue concezioni sulle forze della natura e della vita. Il suo pensiero era dei toni del panteismo, cioè riteneva che Dio fosse in verità null'altro che la forza nascosta di tutta la vita. Circa alla stessa epoca, la badessa tedesca Herrad von Landsberg elaborò la sua opera scientifica "Hortus deliciarum", che contiene i principi di base dell'astronomia, della storia e di altre discipline di quel tempo.
È dunque nell'XI e nel XII secolo che si aprirono scuole attigue ai conventi e nelle quali giovani e ragazze beneficiarono di un insegnamento di qualità. Le scuole dei conventi di religiose di Alais e di Poitiers in Francia erano particolarmente rinomate. Le badesse Gertrude di Nivelles, Aldegonda di Maubeuge e Bertilla di Chelles - tutte e tre francesi - esercitavano sulle loro allieve grande influenza. Nel XIII secolo viveva in Francia una religiosa chiamata Eloisa, il cui epistolario filosofico con l'amico Abelardo è diventato famoso.
I conventi non erano quindi luoghi di ozio, di vizio e di ipocrisia. Erano al contrario dei centri di lavoro, che custodivano i primi studi scientifici e filosofici. Il mondo circostante era segnato dal brigantaggio, da atti di violenza e vandalismo tra i più forti. Era dunque naturale per chiunque cercasse una relativa tranquillità e sicurezza per portare a termine la sua riflessione e la sua ricerca, rifugiarsi in convento. Le mogli sterili e le ragazze disonorate non erano dunque le sole a sparire nei conventi. Le donne indipendenti, che non avevano il minimo desiderio di sposarsi con gli uomini che consideravano oppressori, si unirono a loro.
È per questo che la maggior parte delle donne tra il X e il XII secolo che si erano fatte un nome nella scienza e in letteratura, erano religiose.
Più tardi - tra il 1300 e il 1400 - incontriamo anche fuori dai conventi donne che si dedicavano alla scienza, che del resto insegnavano apertamente. Già nel XIII secolo, ci fu una donna professoressa a Bologna, in Italia, in una delle università più apprezzate dell'epoca.
Questa donna doveva essere di una bellezza eccezionale. Per evitare di turbare i suoi allievi, teneva le sue lezioni nascosta dietro una tenda. Le due figlie D'Andrea, Novella e Bettina, insegnarono successivamente nella stessa università. Furono giuriste famose. E per citare altri esempi: Eleonora Vanvitelli e Teodora Danti, matematiche brillanti e Maddalena Bonsignore, autrice di un trattato notevole sul tetto coniugale dell'epoca.
Ma le donne non si distinsero soltanto nel campo scientifico e letterario. Queste rappresentanti della classe feudale svolsero un ruolo politico non trascurabile nel Medioevo, soprattutto tra il IX e l'XI secolo. Le Contesse che regnarono Matilde di Toscana e Adelaide di Savoia sono esempi famosi, entrambe vissero all'inizio dell'XI secolo nel nord dell'Italia.
La potente e fiera contessa di Toscana, Matilde, regnava sulla città opulenta commerciale ed artigianale di Firenze. Aveva sposato il margravio di Toscana ed ereditato dopo la sua morte tutte le immense proprietà, mentre, secondo la legge, aveva soltanto il titolo di contessa. La sua sovranità si estendeva sopra numerose città e comuni e sui possedimenti della piccola nobiltà. Questa attiva contessa era ansiosa di presiedere alle deliberazioni giudiziarie e firmare tutte le sentenze. Si conservano a Firenze dei documenti interessanti sulle sentenze pronunciate dalla contessa Matilde. Come tutte le donne della nobiltà regnante, disponeva di possedimenti personali a suo piacimento, il che significa assolutamente senza alcuna tutela.
Questo periodo fu anche segnato dalla crescente rivalità tra il papa e l'imperatore, cioè dalla lotta tra la Chiesa e lo Stato. Matilde, che era l'amica personale del potente e astuto papa Gregorio VII, si oppose all'imperatore e lasciò nel suo testamento tutti i beni al papa, cosa che rafforzò il potere di quest'ultimo. L'università di Bologna diventò un centro intellettuale importante perché Matilde vi aveva portato il celebre giurista Irnerio.
La contessa Adelaide di Savoia, sua contemporanea, amministrò da sola - benché avesse avuto due figli - le sue impressionanti proprietà e fece politica. I cronisti la descrivevano come una donna fiera ed energica, che affrontò senza timore il papa onnipotente e si permise anche di minacciare l'imperatore. Aveva anche la reputazione di essere giusta e buona. Ma, in realtà e nonostante il fatto che a volte proteggesse i deboli, lottava maggiormente per l'indipendenza delle sue città e si preoccupava piuttosto di rafforzare il suo potere. Le due donne possedevano conoscenze solide scientifiche e sapevano perfettamente ciò che la scienza poteva apportare per lo sviluppo dei propri domini. Tali donne costituivano eccezioni alla regola. Ma il semplice fatto della loro esistenza in un periodo così buio della storia dimostra che se ne aveva bisogno.
Si potrebbe essere portate a credere che le donne - schiave e proprietà dei mariti - incatenate contro la loro volontà a mariti odiati, fossero là soltanto per perpetuare la filiazione del clan e che non avevano dunque bisogno d'istruzione. Se queste donne fossero state istruite, sarebbe stato per ragioni economiche. Il diritto delle donne all'istruzione e alla conoscenza non si spiega che con il loro ruolo nell'organizzazione economica feudale, cioè il loro ruolo come mogli del proprietario di fortune immense. Del resto vi ho appena parlato del ruolo della donna come organizzatrice della complessa economia domestica feudale.
Una donna che sapeva leggere, scrivere e contare era naturalmente più utile di una persona ignorante e limitata. Le era più facile controllare le entrate e le spese, stabilire un bilancio, recuperare i debiti dai contadini e valutare con precisione la quantità di prodotti necessari per costituire o completare la riserva del castello. Non si chiedeva dunque soltanto alle donne di quest'epoca di essere belle, si chiedeva loro anche di essere intelligenti. Uno storico del XII secolo riferisce che la donna del duca Roberto di Calabria possedeva tutte le qualità: "buona nascita, bellezza e intelligenza".
D'altra parte, le donne erano molto apprezzate quando erano anche buoni medici. Ora sappiamo che le donne si sono sempre dedicate alla cura dei malati. Già all'epoca del comunismo primitivo, sperimentavano le proprietà curative di alcune piante. Nel Medioevo, l'arte della guarigione era molto poco sviluppata. Solo il signore poteva consultare un medico. Gli altri si curavano molto da soli, come potevano. Ma, le guerre, tanto civili che nazionali e la sequela di epidemie portarono il castello a trasformarsi in un ospedale per ricoverare feriti e pazienti e diventare, oltre ad un centro di produzione, un centro medico dove venivano i contadini del circondario.
Così, agli occhi della popolazione, il castello non rappresentava più soltanto la tirannia del signore, ma anche un efficace centro di soccorso. È per questo che era conveniente che la donna del signore sapesse curare i malati. Finché strappava i feriti e i mutilati alla morte e li guariva grazie alle sue pozioni, finché non era troppo orgogliosa per assistere una contadina in occasione delle sue doglie, i contadini erano pronti a perdonare al signore molte delle sue atrocità.
Nel Medioevo la medicina era appannaggio delle donne. La donna ideale, così come è stata descritta in numerose leggende, sapeva guarire i malati. Paracelso, medico famoso del Medioevo, garantiva che aveva appreso maggiormente dalle donne che dai manuali di medicina, confusi e spesso errati. Quando nel 1250 Luigi IX ritornò da una crociata a Gerusalemme, diede alla dottoressa, che lo aveva così bene curato in occasione del suo viaggio, un riconoscimento scritto. La cattedra di medicina dell'Università di Bologna fu occupata nel XV secolo da una donna, Dorotea Bucca.
A quel tempo la medicina era ancora molto poco scientifica, ingombra di formule magiche e di superstizioni. Non esistevano scienze esatte nel senso moderno del termine. Si ignorava perfino l'anatomia del corpo umano. L'arte di guarire, che era allora così strettamente legata agli incantesimi e ai sortilegi, era generalmente considerata come un'arte magica. La donna "guaritrice" non era nulla di diverso che una maga che, poiché comunicava con le forze dell'oscurità, sapeva curare gli uomini ed esercitava anche un controllo sulle loro vite, la loro felicità e la loro salute. Era temuta e rispettata di tutti. Ma, in condizioni sociali ed economiche diverse, la conoscenza di queste donne nel campo della cura, non ritardò a diventare una maledizione.
Furono presto perseguitate come streghe e maghe e bruciarono sui ceppi eretti a lungo per loro in tutta l'Europa. Centinaia, migliaia, decine di migliaia di donne furono così consegnate alle fiamme, e ciò semplicemente perché "i santi padri" della Chiesa e sospettavano di avere relazioni con il diavolo.
Ma parleremo più approfonditamente dei processi alle streghe nella prossima conferenza. Riassumeremo ora la situazione della donna della nobiltà all'epoca del feudalesimo.
A causa del suo alto lignaggio, la donna era rispettata e godeva di alcuni diritti. Al di fuori della sua famiglia, la cavalleria le si avvicinava con rispetto e ammirazione. Ma nella sua stessa famiglia, era priva di diritti come uno dei suoi servi.
Quando l'organizzazione economica feudale raggiunse il suo massimo (fine XIV secolo circa), la moglie del signore, incaricata dell'amministrazione di questa economia, beneficiò di una certa istruzione. Era responsabile anche dell'istruzione dei figli. Ma, con lo sviluppo del commercio, questa forma di organizzazione economica perse di importanza e portò alla svalutazione del lavoro della donna. Il denaro diventò il criterio principale di ricchezza. La donna fu ridotta ad essere soltanto una macchina per procreare. Si trasformò in parassita, come fu il caso delle mogli dei cittadini ricchi di Atene. Di conseguenza, cessò di sorvegliare il lavoro dei maniscalchi e quello dei tessitori. Non verificò più il buono stato delle mole e cessò anche di preoccuparsi della fabbricazione delle armi e delle armature.
Tutti questi rami della produzione cessarono di essere parte integrante dell'organizzazione economica feudale. Si trasferirono dal castello alla città o alla stalla del contadino. La proprietà feudale o il castello non conservavano più il lavoro domestico nel senso stretto del termine, cioè il lavoro casalingo. E le donne nobili si scaricarono anche da questi compiti, che abbandonarono alla loro servitù o al loro amministratore. La mollezza, la stolidità e la chiusura mentale generate da questa vita d'ozio e di pigrizia non tardarono a generalizzarsi fra le donne.
Si può dunque constatare che il crollo dell'organizzazione economica feudale di tipo autosufficiente costruita sull'economia naturale, fu responsabile di una caduta rapida del livello d'istruzione e di cultura delle donne appartenenti agli strati elevati della società. A prima vista, ciò può sembrarci strano. Ma come spiegare differentemente il fatto che un periodo anche oscurantista come il X secolo vide anche donne colte ed intelligenti come Roswitha o Ildegarda, mentre le donne del XVII e del XVIII secolo si distinguevano per la loro stupidità, la debole cultura, l'inclinazione alla superstizione e il gusto pronunciato per i pettegolezzi e gli intrattenimenti superficiali. Questo prova, ancora una volta, che la condizione della donna, il suo diritto alla dignità umana e all'istruzione dipendono sempre dalla sua partecipazione all'economia e alla produzione.
* * *
ndt:
7) Per nozione di proletariato consulta il Dizionario enciclopedico marxista su Resistenze.org
8) Per nozione di Feudalesimo consulta il Dizionario enciclopedico marxista su Resistenze.org
9) Indispensabile leggere: "L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato", Friedrich Engels - A110 anni dalla scomparsa trascrizione e conversione in html a cura del CCDP
Quarta conferenza - Il lavoro femminile nella comunità agricola e nella produzione artigianale
Analizzeremo ora le condizioni di vita delle altre classi. Quali diritti avevano nel Medioevo le donne delle città e delle campagne, come vivevano? Cominceremo dalle contadine. Per loro è difficile parlare in termini di diritti nel corso di un periodo così spietato come il Medioevo e mentre regnava esclusivamente la legge del più forte. Contadini e contadine erano servi del loro "signore". E' tutto detto. Il potere del proprietario terriero sui contadini era senza limiti.
Per comprendere le relazioni tra la cavalleria, i boiardi o proprietari terrieri nobili ed i contadini, dobbiamo cercare di comprendere chiaramente ciò che stava alla base del feudalesimo. L'economia del feudalesimo era completamente dipendente dalle grandi proprietà rurali sulle quali regnavano i padroni assoluti - cavalieri e guerrieri - che dominavano il paese. Terre e campi del patrimonio del grande proprietario terriero erano coltivati dai contadini che disponevano di loro propri lotti familiari. I contadini certamente non erano più schiavi come nell'antichità greca, romana o egiziana (essendo lo schiavo proprietà privata del suo padrone e perciò, un individuo non libero, mentre il contadino, era libero), ma si trovavano in una situazione di dipendenza economica e politica tale che il loro asservimento era inevitabile e diventarono presto i servi del proprietario terriero.
Naturalmente, cavalieri e boiardi si accaparravano le terre migliori. Per sopravvivere, i contadini erano costretti ad affittare le terre signorili per le quali pagavano molto, inizialmente in natura, più tardi in denaro e dovevano anche compiere servizi quotidiani per il loro signore. In origine, questo stato di fatto non era regolamentato giuridicamente, le leggi sulla schiavitù propriamente detta apparvero solo ben più tardi (in Russia, nel XVI secolo). Abbiamo a che fare qui con una conseguenza di questa legge del più forte che conferiva al signore un potere illimitato sui contadini.
Nel Medioevo, il proprietario non possedeva soltanto la terra, deteneva anche poteri politici straordinari. Nella pratica, ciò significava che aveva piena disposizione del suo patrimonio: emanava decreti, aumentava tasse, infliggeva pene e condanne a morte e distribuiva feudi. Così ogni grande signore proprietario terriero finisce per regnare su tutta una serie di piccoli signori e proprietari che gli erano sottoposti e che, a loro volta, comandavano i nobili che erano a loro inferiori. La gerarchia nobiliare, costituita da proprietari terrieri (signori) e dai principi e in altri paesi, da signori feudali e da vassalli (dove i secondi si trovavano in posizione inferiore rispetto ai primi) era nata. Questa rete di subordinazione e di dipendenza reciproca garantiva la stabilità del feudalesimo e rafforzava l'autorità dei principi e dei signori. In questa catena aristocratica, i contadini erano condannati ad una vita che somigliava più o meno a questo: cieca obbedienza al signore e duro lavoro, di cui i contadini stessi non raccoglievano i frutti, destinati soprattutto ai signori dei castelli che si occupavano a dilapidarli.
Qui, la posizione della contadina non si distingue affatto da quella del contadino. Tutti e due sgobbavano instancabilmente dalla mattina alla sera e guadagnavano per loro solo sofferenze, disprezzo e assenza totale di diritti. A quel tempo, solo le proprietà dei signori erano rispettate. Loro soli avevano diritti. Il fatto che il contadino fosse schiavo come sua moglie, contribuì a diminuire o a addirittura cancellare le differenze. Uomo e donna si piegarono insieme sotto il giogo della signoria.
Nella vita familiare tuttavia, il servo sottomesso e spogliato di ogni diritto non si comportava differentemente dal signore e padrone nei confronti di sua moglie e dei suoi bambini. Come il cavaliere nel suo castello comandava la moglie dotata di titoli nobiliari, il contadino esercitava la tutela sulla sua. Mentre il cavaliere era autorizzato a giocare sua moglie ai dadi o a chiuderla in un convento, il contadino da parte sua, poteva cacciarla o venderla all'asta al mercato. Quando la proprietà privata riescì ad imporsi nell'ambito della classe contadina, il diritto paterno e perciò il diritto dell'uomo sulla donna e i bambini, ne uscì rafforzato. Da quel momento anche i contadini si misero a contrarre matrimoni d'interesse e non più matrimoni d'amore. È vero che questi ultimi erano spesso contrastati dai signori che ordinavano semplicemente ad Ivan di tale villaggio di sposare Maria di tal altro. Così la contadina serviva due padroni allo stesso tempo, il suo signore, a cui doveva la propria sussistenza e suo marito.
Il cavaliere e i suoi figli non avevano alcun riguardo per le contadine. Per "la Signora del suo cuore", ovviamente di nascita nobile, il cavaliere era capace di vegliare notti intere, a piedi nudi e nonostante il freddo gelido, come dimostrazione di amore e ammirazione. In compenso, riguardo alle donne e alle ragazze dei contadini, lo stesso uomo si comportava nel modo più ignobile e senza alcun ritegno. Per rallegrare le sue bevute era capace di ordinare il raduno di tutte le giovani donne del villaggio più vicino. E se una contadina avesse avuto la disgrazia di piacergli, faceva cacciare il marito dalla sua casa. In qualsiasi momento il signore aveva il potere di trasformare botteghe e annessi del suo castello in un harem. Così la cavalleria, pur celebrando in versi la gloria delle donne, schiacciava senza pietà la volontà e i sentimenti delle donne del popolo. Era un periodo buio e prolifico di malattie di ogni tipo.
È soltanto verso la fine del Medioevo che i contadini iniziarono a rivoltarsi contro gli abusi dei signori. Le donne svolsero un ruolo molto attivo nel corso delle sommosse contadine. In occasione della "Jacquerie" (rivolta dei contadini francesi nel 1358), le donne furono quelle che dimostrarono più entusiasmo nel bruciare i castelli e massacrare gli abitanti a colpi di ascia o di forconi. Fatti simili si raccontano a riguardo delle donne dei lollardi (ndt 10) in Inghilterra (setta religiosa del XIV e XV secolo a carattere sociale e che subisce dure persecuzioni), delle donne dei contadini tedeschi, degli hussiti e dei seguaci di Thomas Münzer. Gli storici descrivono le contadine rivoltose come creature vendicative, insensibili e sanguinarie che superavano in crudeltà anche la rabbia scatenata dei contadini.
Come poteva del resto essere diverso? Le contadine, per diritti e consuetudini stabiliti contro di loro e che derivavano dal diritto patriarcale, conducevano una vita da cani. Subivano l'autorità del capofamiglia e non erano nulla di diverso che bestie da soma. Aravano, raccoglievano e governavano il bestiame. Nessun lavoro era troppo duro. Queste condizioni sono del resto invariate nelle regioni più arretrate e retrograde della Russia e in altri paesi economicamente sottosviluppati. La contadina non aveva alcun diritto mentre occupava lo stesso posto del contadino nell'ambito della produzione.
Com'era possibile?
Abbiamo già detto che il sistema economico nel Medioevo era fondato sulla proprietà privata. Ma, dove prevale la proprietà privata non è data importanza al lavoro, né al suo diretto risultato - intendo con ciò la produzione di beni di consumo indispensabili - ma solo ai guadagni, grazie al diritto di utilizzo della proprietà privata, del lavoro altrui, cioè ai profitti. Vi ricordate certamente che gli schiavi in Grecia erano i veri produttori di tutte le ricchezze e quali ricchezze! Tuttavia, il lavoro degli schiavi non aveva alcun valore agli occhi dei greci. Non erano considerati qui come forza lavoro e coloro che sfruttavano questa forza lavoro erano i soli a essere riconosciuti socialmente. Questo chiaramente significava che i proprietari ottenevano un massimo profitto sfruttando i loro schiavi. Non andava differentemente con il lavoro dei servi. L'avvento della proprietà privata comportò la disgregazione dell'azienda agricola in piccole unità indipendenti. Tuttavia prati e foreste erano ancora proprietà comunale. Ogni servo possedeva la sua fattoria che non apparteneva alla donna, ma all'uomo: il marito, il padre o il fratello. Questa concezione del diritto che si basa sulle abitudini patriarcali si sviluppò e si rafforzò.
Si deve anche tenere conto di quanto segue: nonostante la sua posizione subordinata nell'ambito della famiglia, la donna godeva tuttavia di una certa stima nel suo clan, in particolare nelle società derivate dagli ex popoli agricoli, avendo vissuto un periodo matriarcale. Per ciò che riguarda la posizione della donna, la schiavitù tra francesi, inglesi e tedeschi non prendeva forme così marcate come nelle tribù di pastori, come gli Unni e i Tartari che terrorizzavano i contadini pacifici dell'Europa con le loro invasioni.
La lotta tra le due forme di proprietà della terra, cioè da un lato la proprietà privata e dall'altro, la proprietà comunale, era lungi dall'essere completa. In Russia, questo diritto di possesso collettivo restò in vigore molto a lungo grazie al sistema del mir (assemblea -ndt) e fu abolito soltanto sotto il regno di Nicola II dalle leggi del ministro Stolypin. Per l'economia del villaggio, la donna rappresentava un'importante forza lavoro. La prosperità dipendeva tanto dal suo che dal lavoro del contadino. È per questo che poteva assistere in numerosi casi alle decisioni del villaggio, mentre riguardo a suo padre o a suo marito, non aveva praticamente voce in capitolo. Alle riunioni, anche gli anziani erano pronti ad ascoltarla. In una provincia russa, un'usanza autorizzava le contadine - in particolare in occasione dell'assenza del loro marito - ad assistere alle riunioni del mir e ciò nonostante la perdita dei loro diritti ancestrali ed il fatto che il pater familias aveva considerevolmente allargato le sue prerogative. Le cose iniziarono veramente a cambiare per la contadina soltanto con l'introduzione, particolarmente umiliante, dello status di nuora. A partire da questo momento l'uomo poteva ridicolizzare e maltrattare impunemente sua moglie. Questo status significava che la donna, nel caso in cui il marito fosse partito per l'estero, doveva restare presso il suocero ed avere con lui rapporti sessuali.
La situazione della contadina serva si distingue tuttavia a vantaggio di quella della sua omologa nobile. Nonostante il signore esercitasse un potere illimitato sui suoi contadini, forzando i loro matrimoni e le loro separazioni e praticando il famoso e degradante ius primae noctis, nell'ambito dei contadini chiaramente c'erano più matrimoni d'amore che nella nobiltà. (Lo ius primae noctis significa il diritto del signore di passare la prima notte nuziale con la nuova sposa.) Le ragazze dei contadini avevano maggiori possibilità di decidere i loro matrimoni che le ragazze degli aristocratici. Questo testimoniato anche da canzoni popolari e le leggende.
È interessante osservare che la ragazza del cavaliere che aveva avuto relazioni intime con un uomo prima del suo matrimonio, gettava discredito non soltanto su sè stessa, ma anche su tutta la sua famiglia - in modo che nessun uomo accettasse più di sposarla -, mentre presso i contadini, queste storie non erano in realtà considerate così gravi. Le relazioni prima del matrimonio erano percepite in modo naturale e non apparivano come disonorevoli. Perché? Per ragioni economiche. Presso i contadini di quest'epoca, la forza di lavoro, per le condizioni difficili imposte dal lavoro agricolo, rivestiva un valore particolarmente elevato. Ogni bambino significava forza lavoro supplementare e perciò, vantaggiosa per l'economia contadina. È anche per questo che il contadino poteva adattarsi allo ius primae noctis senza essere altrettanto obbligato a cacciare la propria moglie; non vi vedeva l'apice dell'ignominia, ma una prova sgradevole, niente più. Queste abitudini si modificarono successivamente, quando gli sfruttamenti si individualizzarono e si ridusse la dimensione della proprietà comunale. A partire da questo momento, il padre cacciava la figlia se era rimasta incinta al di fuori del matrimonio e l'adultera era frustata a sangue da suo marito.
Così l'avvento della proprietà privata nei contadini andava di pari passo con l'aggravarsi della situazione della donna, situazione sempre più disperata e insopportabile, spogliandola di qualsiasi diritto. Il cosiddetto "destino femminile" diventò la sorte delle contadine ovunque fosse diffusa la sovranità violenta del grande proprietario terriero, in breve, in ogni sistema economico basato sulla schiavitù e sulla proprietà privata della terra.
Riassumendo, si può descrivere la situazione dell'aristocratica e della contadina come segue: nel corso del Medioevo e per ragioni principalmente economiche, nessuna uguaglianza, nessuna indipendenza, nessun diritto umano fondamentale, nulla di tutto questo era rispettato.
Ora affronteremo la situazione della donna della terza categoria sociale, la borghesia (ndt 11), che, successivamente, si dividerà in due classi opposte e ostili, la borghesia e il proletariato. Abbiamo già parlato della nascita delle città. Si erano sviluppati principalmente a partire dai mercati, centri del commercio e degli scambi, in cui vivevano soprattutto commercianti e artigiani. Per borghesi, intenderemo solitamente le donne degli artigiani e dei commercianti che non svolgono un ruolo autonomo. Cosa che era probabilmente conseguenza del fatto che i commercianti lavoravano generalmente con merci straniere, cosa che richiedeva una mobilità e un'indipendenza che la donna semplicemente non possedeva. È soltanto verso la fine del Medioevo (nel XIII e XIV secolo) che lo scambio delle merci fu effettuato da commercianti intermedi, anziché essere diretto, come era il caso tra due produttori, cioè tra un artigiano ed un contadino o due artigiani di professioni diverse.
La donna della classe commerciale era padrona di casa e sposa. La sua attività produttiva si limitava al lavoro domestico che era al tempo chiaramente piuttosto complicato, poiché la soddisfazione delle necessità quotidiane dipendeva esclusivamente da questo. Il lavoro domestico soddisfaceva tuttavia soltanto necessità immediate e non produceva nessuna merce preziosa. Ne derivò una disistima del lavoro della donna. Nella classe commerciale delle città, l'uomo era capo e di solito l'unico capofamiglia.
Andava in maniera molto differente per le donne e le figlie degli artigiani che vivevano del lavoro delle loro mani e non del profitto che i commercianti ottenevano dalla vendita di una merce straniera o dal lavoro improduttivo della contrattazione. Più l'artigiano produceva scarpe, tavole, credenze, selle o abiti, più la sua vita ne era migliorata. Di conseguenza era completamente naturale che l'artigiano cercasse aiuto da sua moglie o dagli altri membri della sua famiglia. Solo così poteva sperare di "organizzare" una bottega. Più mani c'erano, meglio e più rapidamente progrediva il lavoro. I clienti preferivano artigiani che eseguivano l'ordine non appena possibile. Gli artigiani celibi erano dunque obbligati ad assumere aiutanti per competere coi loro concorrenti e le loro famiglie. L'artigiano assumeva apprendisti che potevano così imparare il mestiere e che diventavano successivamente assistenti o compagni di lavoro. Nasce così un modo completamente nuovo di produzione, l'artigianato, con un maestro artigiano al vertice e un intero battaglione di apprendisti e di lavoratori che gli erano subordinati. Questi non erano schiavi, ma lavoratori liberi sotto la direzione del padrone. Gli artigiani si unirono in associazioni, formando delle corporazioni in attesa di regolamentare le relazioni tra clienti e artigiani e attenuare la concorrenza che minacciava di influire seriamente sul tenore di vita dell'artigiano stesso. L'artigianato esisteva parallelamente alla schiavitù dei contadini e completava il sistema feudale.
All'interno dei mestieri artigianali la donna svolse un ruolo importante, particolarmente tra il XII e il XIV secolo. In alcuni mestieri il lavoro delle donne era predominante: ad esempio, nella tessitura, nella preparazione di pizzi coi fusi, di frange, di calze, di borse, ecc. Fino al XIV secolo, il padrone prendeva in apprendistato le ragazze come i ragazzi. Le donne lavoravano con il loro marito. Se il marito moriva, la donna ereditava la bottega e il titolo di padrone, non aveva tuttavia il diritto di assumere nuovi apprendisti. È per questo motivo che poteva proseguire il lavoro di suo marito soltanto se sposava uno dei suoi lavoratori. Questo lavoratore diventava allora maestro a sua volta ed aveva non soltanto ogni libertà di comando, ma anche di allargare i sui affari (con un matrimonio di questo tipo, i diritti dei due padroni di corporazione si accumulavano e permettevano l'aumento del numero di apprendisti, cosa che era naturalmente molto vantaggiosa per il proprietario di una bottega).
Tra il XII e il XIV secolo, il lavoro delle donne era così diffuso nelle numerose città dell'Inghilterra, Germania, Francia e Italia che alcune corporazioni erano composte solo da artigiane. E' il caso della filatura della lana, che da allora è sempre stato appannaggio delle donne e nel Medioevo esistevano specifiche corporazioni di filatrici, di cardatrici e di avvolgitrici. A Colonia, antico centro industriale tedesco, la gilda delle avvolgitrici era molto potente. Sbocciarono in Francia in particolare le due corporazioni che riuniscono le fabbricanti di borse e le modiste. La tessitura dei tessuti di lana era considerata un lavoro esclusivamente femminile. La tessitura, come il lavaggio delle vele, era esclusivamente riservato alle donne. Esisteva anche una corporazione di tessitrici di tessuti delicati e nel XIV e XV secolo, una corporazione di fabbricatrici di corde.
Nel XIV secolo, l'Inghilterra contava tante donne, quanto uomini, in 495 gilde su 500. Una legge promulgata nella metà del XIV secolo da Edoardo III ci permette di immaginare l'importanza del lavoro delle donne nelle varie corporazioni lavorative: infatti questa legge contiene regolamenti sui diritti delle donne occupate nelle industrie della birra, nelle panetterie, nei laboratori di tessitura ecc. In Inghilterra erano due i lavori femminili che erano particolarmente diffusi: la locandiere e la lavandaia. Anche la birraia era considerata un lavoro tipicamente femminile. Le donne si sono imposte in particolare anche nei seguenti lavori: la tessitura, la pigiatura del panno, il filatura del lino, il ricamo d'oro, la fabbricazione delle candele, il cucito, la panetteria, la fabbricazione di pizzi, calze e frange.
La preparazione dei bagni e dei lavaggi è stata sempre appannaggio delle donne. Anche il lavoro di parrucchiera era esercitato da donne. E se le donne non erano rappresentate nel grande commercio, il piccolo commercio era quasi esclusivamente nelle mani delle donne. Ciò era particolarmente vero verso la fine del Medioevo. Le donne offrivano rumorosamente al mercato polli, oche, fiori, frutta, ortaggi e altri prodotti di consumo. Molte tra loro vendevano anche vecchi abiti.
Quando una corporazione era composta da uomini e donne, queste ultime generalmente beneficiavano degli stessi diritti dei primi. Fino al XIV secolo, nelle città tedesche come Monaco, Colonia o Danzica, ogni padrone poteva impegnare come apprendista indifferentemente un ragazzo o una ragazza. Ad Amburgo e a Strasburgo, la corporazione dei tessitori era composta soltanto da donne. Le donne lavoravano anche nelle botteghe del cuoio, nelle oreficerie ed appartenevano alla gilda delle filatrici d'oro.
Il lavoro delle donne nei mestieri artigianali ebbe alla fine una tale estensione, che si finì per doverlo regolamentare con decreti. Il padrone di un atelier di oreficeria poteva prendere a suo servizio al massimo soltanto tre fanciulli, le donne continuavano tuttavia a lavorare come aiutanti. Nel 1920, i fabbricanti di tappeti proibirono il lavoro delle donne incinte, da un lato per favorire la loro gravidanza, dall'altro per rallentare la concorrenza tra donne.
Più tardi, nel XV e nel XVI secolo, quando la concorrenza tra gli artigiani era particolarmente inasprita, si iniziò a rifiutare l'entrata delle donne nelle corporazioni. Tuttavia, in occasione del periodo di espansione dell'artigianato, il lavoro delle donne svolgeva un ruolo importante nelle città.
Il motivo per cui il lavoro femminile fosse così tanto diffuso è dovuto al fatto che la borghesia del Medioevo contava una maggioranza di donne. Le statistiche di molte città del XIII e del XIV secolo mostrano che c'erano circa da 1.200 a 1.250 abitanti donne ogni 1.000 abitanti uomini. Ci sono stati periodi in cui la parte femminile della popolazione era ancora più numerosa. La carenza di uomini obbligava queste donne a guadagnarsi da vivere, non riuscendo ad accedere al matrimonio.
L'eccedenza della popolazione femminile nelle città è spiegabile con il grande salasso degli abitanti di sesso maschile causato dalle guerre incessanti. Queste guerre sterminarono un numero incalcolabile di esseri umani, in particolare uomini. Contemporaneamente si assisteva ad un esodo massiccio di donne dalle campagne alla città, esodo che rappresentava per alcune la sola possibilità di sottrarsi alla tirannia del grande proprietario terriero. Per sfuggire alla schiavitù, la figlia del contadino era obbligata a trovare un lavoro in città. Il figlio del contadino invece poteva partire per la guerra come soldato. Per una donna le sole scappatoie erano il convento o la città.
Le donne andarono dunque in città per garantire con il loro lavoro, la loro vita e sovente quella dei loro bambini. Se non vi riuscivano, restava sempre la possibilità di vendere il proprio corpo. Questo modo di guadagnare denaro era così diffuso che le prostitute formarono in molte città le loro corporazioni. Queste corporazioni furono legalizzate dai notabili delle città e le prostitute perseguitarono spietatamente qualsiasi donna che cercasse di prostituirsi al di fuori delle organizzazioni ufficiali. Ecco perché era molto difficile guadagnarsi da vivere come prostituta al di fuori delle corporazioni femminili, cioè dei bordelli.
Grazie alla sua partecipazione alla produzione, l'artigiana conduceva una vita completamente diversa dalle sue contemporanee contadine ed aristocratiche. Aveva voce in capitolo rispetto alle decisioni relative alla politica di produzione della città; gestiva i suoi profitti e partecipava attivamente alle numerose feste e bevute dell'epoca. Era innegabilmente indipendente e libera. Nella stessa Russia, che viveva ancora nel XVI secolo l'era del Medioevo, la donna della città aveva una posizione più vantaggiosa dell'aristocratica. Ciò era particolarmente vero per le città libere di Pskov, di Novgorod ed altre. Martha Posadwitz, sindaco di Novgorod, la grande, ne fu un esempio vivente, lottando appassionatamente per la libertà della sua città e contro il saccheggio e il vandalismo della nobiltà.
Questo dimostra che le donne facevano politica e che ciò non risultava ovviamente riprovevole agli occhi dei borghesi. Nel caso degli artigiani, il rapporto tra coniugi era molto più egualitario e si basava su un riconoscimento reciproco nell'ambito della famiglia borghese. Questo stato di fatto si spiega abbastanza bene come segue: nel Medioevo, molte donne partecipavano in modo attivo alla produzione delle botteghe artigiane delle città, in un periodo in cui l'artigianato locale era la forma economica dominante. Il fatto che uomini e donne fabbricassero prodotti di medesimo valore attenuava considerevolmente le abitudini patriarcali e l'esercizio del diritto dell'uomo sulla donna fu momentaneamente eliminato.
Non occorre tuttavia sopravvalutare l'importanza del ruolo della donna nell'economia delle città e nel sistema di produzione in generale dell'epoca. Anche se un grande numero di donne garantiva la propria sussistenza, la grande maggioranza di loro rimaneva oppressa, dipendente dal lavoro del marito a cui badava la famiglia. Queste donne fornivano un lavoro che occupava nell'economia un posto di secondo piano. Era dunque naturale che i diritti delle artigiane e dei membri femminili delle gilde non fossero assolutamente uguali a quelli dei loro mariti e dei loro fratelli. Non potevano pretendere un'uguaglianza totale di diritti finché la maggioranza delle donne - o almeno una gran parte di loro - non avesse prodotto merci ed effettuato un lavoro utile per l'insieme della società. In ultima analisi, l'uomo era e restava il produttore principale e il creatore di tutte le ricchezze e di tutti i prodotti, indipendentemente dalla sua posizione. È anche per ciò che la donna rimase spogliata dei propri diritti nell'ambito della società e dello Stato e che la sua dipendenza nel matrimonio e nella famiglia restò invariata.
Gli storici borghesi vedono di solito il Medioevo come un'epoca benedetta, dove la vita di famiglia degli abitanti delle città era felice e dove la donna di città beneficiava di un'indipendenza e di una stima ragionevoli. Anche le donne più anziane vengono descritte come adulate dagli uomini. Con la penna di questi scrittori borghesi il Medioevo intero appare con un'aurea di romanticismo. Sappiamo tuttavia ciò che era la realtà. Conosciamo la crudeltà e la barbarie di quest'epoca. Le donne, qualunque sia stata la loro classe sociale, vivevano per la maggior parte in condizioni difficili ed erano esposte a qualsiasi tipo di sofferenza inimmaginabile, conseguenza dell'oscurantismo dell'epoca. Si diffuse in questo periodo la credenza aberrante che la donna fosse "uno strumento del diavolo". Il cristianesimo diffuse "la mortificazione della carne" introdusse esercizi di preghiera fino all'esaurimento e inoltre predicò il digiuno e l'astinenza. La Chiesa cattolica non esigeva soltanto il celibato dai suoi sacerdoti e dai suoi monaci, attendeva la stessa cosa dal resto della popolazione. Il matrimonio era considerato come espressione della concupiscenza della carne. La Chiesa, nonostante ne avesse fatto un sacramento, non considerava meno la vita coniugale, ma come un abbandono al peccato. In occasione del concilio di Mâcon (Francia, 585) nel IX secolo, la Chiesa dichiarò che qualsiasi vero cristiano doveva sottoporsi "alla mortificazione della carne". Ci è facile immaginare le conseguenze che comportarono tali concezioni sul corpo e sui bisogni umani della donna.
Tutte le religioni segnate dal patriarcato si sono rese colpevoli di discriminazione verso le donne, principalmente per avere stabilito nella legge divina l'inferiorità della donna rispetto all'uomo. Il cristianesimo, in origine religione degli schiavi, ma da cui i ricchi e i potenti hanno saputo rapidamente trarre vantaggio, da questo punto di vista ha particolarmente attaccato le donne. Il cristianesimo deve la sua ardua espansione al Medioevo, al suo desiderio di legalizzare la proprietà privata, all'abisso scavato tra le classi e alla violenza verso i poveri. Il cristianesimo elevava la povertà, la dolcezza e la pazienza alla stregua di virtù che i servi senza diritti avevano il dovere di praticare e per i quali un giorno, inoltre, sarebbero stati in gran parte ricompensati. L'effetto soporifero della religione sul pensiero e sulla volontà impediva ogni risveglio: "Credete senza dubitare!". La classe dei grandi proprietari terrieri aveva bisogno di essere sostenuta da Dio stesso per garantire la propria supremazia. "Mortificarsi" era estremamente sgradevole. I cavalieri, i proprietari terrieri o anche i rappresentanti fanatici della Chiesa, rispettavano queste regole sante di vita? No, in nessun modo! Conducevano una vita di vizi disgustosi e lasciavano ai monaci e agli eremiti, il compito "di mortificare il loro corpo". Versavano regalie ai conventi per la redenzione dei loro peccati.
Il cristianesimo era dunque e sotto tutti gli aspetti, una religione molto comoda per i potenti, poiché confermava le classi non abbienti e dominate e in particolare le donne, che appartengono a queste classi, nella loro oppressione e le terrorizzava. La chiamata all'Onnipotente legalizzò il diritto del più forte nell'ambito della famiglia e la sottomissione della donna alla tirannia dell'uomo. Ciò ebbe naturalmente conseguenze catastrofiche sul futuro destino della donna. Il cristianesimo rimproverava alla donna di incitare l'uomo all'amore carnale. I padri della Chiesa del Medioevo compilarono enormi grimori per tentare di provare la natura peccatrice della donna. Resero le donne responsabili della loro concupiscenza. E il popolo, semplice e ignorante, che non aveva imparato a pensare da solo, credeva ciecamente agli insegnamenti della Chiesa.
In realtà, la corruzione dei costumi non diminuì. Nel Medioevo la prostituzione era fiorente e se esaminiamo più attentamente i costumi dell'epoca, scopriamo presto che, sul piano della dissolutezza, non avevano nulla da invidiare al nostro secolo borghese capitalista. Con la comparsa "della doppia morale" che schiacciava con tutto il suo peso la donna, il clima di bigottismo e di ipocrisia continuò a peggiorare. La Chiesa, l'uomo della strada, tutti si occuparono degli affari coniugali e così cominciò la brutale persecuzione delle madri nubili. Spesso attentarono alla vita di queste donne o a quella del loro bambino. Ma fra i crimini cui la religione cristiana ha dovuto rimproverarsi, i peggiori sono stati tuttavia i processi alle streghe.
Il cristianesimo sosteneva la pigrizia dello spirito e il conservatorismo, arretrava dinanzi a qualsiasi innovazione e considerava naturalmente ogni forma di lavoro intellettuale come dannoso. Le scienze, ad esempio, erano perseguitate perché la Chiesa sospettava gli scienziati capaci di scoprire la ciarlataneria religiosa e di incantare gli occhi dei credenti. Tutti coloro che esercitavano un'influenza spirituale sul loro ambiente senza portare una tonaca, erano vigorosamente perseguiti dalla Chiesa.
Ma le donne, "strumenti del diavolo" erano in molti casi chiaramente più colte degli uomini. Il cavaliere era dedito alle sue guerre, ai suoi atti di vandalismo e ai suoi vizi. Si rendeva colpevole di crudeltà indescrivibili, ma il suo cervello non funzionava affatto. Lasciava ad altri il compito di pensare. Se peccava, andava a trovare il suo confessore. E quest'ultimo gli assegnava generosamente l'assoluzione. Per le donne della nobiltà, andava in modo differentemente. La loro cultura più elevata e le responsabilità che prendevano nella conduzione dell'economia feudale, formarono la loro facoltà di pensare e le resero spiritualmente superiori ai loro mariti. Il confessore era costretto ad essere più vigile. Doveva a tutti i costi riuscire a mettere i loro pensieri e la loro volontà sotto la propria influenza. Se non vi fosse riuscito, una lotta spietata sarebbe iniziata tra il confessore e la donna del cavaliere. Controllava se il cavaliere seguiva i saggi pareri della moglie anziché ascoltare il cattivo consiglio del sacerdote o del monaco. La Chiesa non avrebbe mai perdonato tale vittoria alla donna. La braccava e la perseguitava senza sosta, aspettando l'occasione propizia per precipitarla in rovina. Anche le buone qualità di questa donna diventavano per il sacerdote o il monaco armi dirette contro di lei. Quando ad esempio una contadina riusciva a guarire la malattia del suo vicino e guadagnava pertanto il suo rispetto e il suo riconoscimento, la Chiesa vedeva in lei una rivale, poiché poteva esercitare un'influenza spirituale su coloro che le erano intorno.
Ecco perchè la Chiesa si affrettò a suscitare sfiducia a suo riguardo: il suo lavoro era "opera di Satana" o più semplicemente ancora "stregoneria". Più una donna era intelligente e colta e più correva il rischio di essere definita strega dal clero. Da quel momento la chiesa mise in scena, per molti secoli, una serie di processi alle streghe, durante i quali le donne furono perseguitate e assassinate in modo spaventoso. Tra il XV e il XVII secolo, migliaia di presunte streghe salirono sul rogo. In un solo anno, ad esempio, 700 "streghe" furono bruciate vive nella sola città di Fulda e nella regione che circonda il lago di Como, a nord dell'Italia, non meno di uno centinaio di donne furono giudicate per avere "commerciato con il diavolo". Un'opera specialistica, il Martello della strega, indicava in modo dettagliato come riconoscere facilmente una strega e come comportarsi a suo riguardo nel caso in cui avesse gettato un sortilegio. Numerose vittime di questa "devozione" cristiana crollarono sotto orribili torture, confessando storie incredibili naturalmente completamente inventate. Confessavano di aver assistito "alla festa delle streghe" sul Monte Calvo, che avevano firmato un patto con il diavolo, che si erano trasformate in animali, che avevano stregato uomini o che avevano portato loro disgrazia e malattia, ecc.
Il popolo semplice, ignorante e maltrattato, credeva a tutti questi "peccati", e il clero vi trovava il suo tornaconto. A noi quello che interessa, è il fatto che le donne non erano allora altro che delle figlie obbedienti e serve della Chiesa, altrimenti le persone di mentalità ristretta non avrebbero mostrato tale rabbia contro di loro in occasione dei numerosi processi alle streghe. È soltanto con il tempo che le donne furono definitivamente domate, quando le condizioni economiche tolsero loro ogni iniziativa e persero le loro facoltà intellettuali e pratiche. La persecuzione delle donne per magia e stregoneria cominciò circa a metà del Medioevo. Questo processo una volta intrapreso non sembrava voler più fermarsi. Continuò per numerosi secoli, anche dopo che la donna era stata relegata ai suoi fornelli e ridotta ad essere soltanto il complemento e le spalle del proprio marito.
Riassumeremo la conferenza di oggi come segue: dal IX al XV secolo, dunque l'epoca del feudalesimo e dell'economia naturale, la donna, benché dipendente e sprovvista di diritti, si trovava in una posizione migliore che nell'epoca seguente, che annuncia l'economia capitalista, essendo caratterizzata dall'aumento del commercio, del capitale e della manifattura.
L'aristocratica, responsabile dell'organizzazione domestica del castello, godeva di alcuni privilegi che derivavano dalla sua fortuna, che le conferivano un potere sulle altre classi della società. Ma riguardo al proprio marito, era completamente sprovvista di diritti e secondo la legge, sottomessa.
Non c'era uguaglianza tra i sessi. L'artigiana che, nella sua specificità di rappresentante di un lavoro produttivo, aveva alcuni diritti, non ne aveva nessuno nell'ambito della propria famiglia dove il potere del padrone di casa sulla donna e sui bambini non poteva essere messo in discussione. E accadeva lo stesso nella famiglia contadina. Teoricamente, più simbolicamente e come reminiscenza del passato, il contadino considerava sua moglie, riconoscendola come conservatrice del clan e produttore principale dell'economia; nella pratica, il contadino trattava sua moglie come il suo servo o il suo schiavo. Così viveva la donna nel sistema feudale.
Ma prima di potere definitivamente sbarazzarsi di questo fardello, il ruolo di serva o di schiava priva di qualsiasi diritto, la donna dovette ancora subire dure prove, voglio dire con ciò che essa dovette guadagnare la propria vita come schiava dipendente sotto la sovranità del capitale. Il capitalismo permise alla donna di accedere ad un lavoro produttivo e creò così la condizione necessaria alla lotta delle donne per l'uguaglianza dei diritti e per la sua liberazione. Ma la liberazione definitiva della donna è possibile soltanto in un sistema di produzione più sviluppato della nostra epoca - il sistema comunista - quando le forze della donna verranno usate in modo produttivo per la collettività.
* * *
ndt:
10) Setta che si sviluppò tra i poveri tessitori inglesi nel secolo XIV ed ebbe ramificazioni nel Paesi Bassi, nella Fiandra e nel Brabante. I lollardi chiedevano la riforma della chiesa inglese e la comunità dei beni. Si andarono estinguendo sebbene lentamente, dopo che Giovanni Ball, loro massimo rappresentante fu ucciso durante il grande movimento insurrezionale del 1358. - 5a nota a margine di Friedrich Engels: La guerra dei contadini in Germania - Capitolo II - su Resistenze.org
11) Per nozione di borghesia consulta il Dizionario enciclopedico marxista su Resistenze.org
Quinta conferenza - La collocazione della donna durante l'epoca fiorente del capitale mercantile e della manifattura
Compagne, ora noi passeremo ad analizzare la posizione della donna nel periodo della nascita del capitalismo. Nell'ultima conferenza ci siamo occupati del feudalesimo, della schiavitù, dello scarso sviluppo del commercio di scambio e della crescita dell'artigianato nelle città. Abbiamo scoperto che in questo periodo - come in tutti i periodi remoti dello sviluppo economico - il ruolo della donna nella società e i suoi diritti dipendevano dalla sua collocazione nella produzione. All'epoca del feudalismo e dell'economia naturale la maggior parte delle donne partecipava alla produzione. L'economia familiare individuale e privata teneva le donne lontane dal lavoro produttivo destinato a tutta la collettività, relegandole al solo lavoro produttivo destinato alla cura della famiglia. Anche se la donna spendeva molta energia nelle sue attività domestiche e svolgeva un lavoro faticoso fisicamente, il suo lavoro nell'economia nazionale non era riconosciuto perché non poteva venderne i prodotti.
Abbiamo anche rilevato che la collocazione della donna nella società variava nel Medioevo in funzione dell'appartenenza di classe (ndt 12). La società dell'epoca comprendeva le seguenti classi: la nobiltà, la borghesia (nel senso degli abitanti dei borghi o delle città), il contadiname, i servi.
La contadina serva, per le stesse ragioni del marito, il contadino servo, perse i suoi diritti. L'uomo e la donna erano dipendenti e senza diritti. In Germania ad esempio, il contadino rispettava in qualche modo la donna in quanto la tradizione popolare aveva mantenuto gli elementi della sua precedente funzione nell'economia naturale. Per contro, nelle tribù nomadi dell'Antichità, la donna era solo schiava e serva del marito (la classe contadina russa è stata fortemente impregnata dagli usi e costumi dei nomadi).
Con l'avvento della proprietà privata e della famiglia, il patriarcato si impose anche alla classe contadina e l'attività della donna venne nuovamente limitata al solo lavoro domestico. Le borghesi presero attivamente parte alla produzione. Ma non erano la maggioranza. L'artigiana libera, in quanto membro di una corporazione, beneficiava di certi diritti nella misura in cui la sua produzione contribuiva ad aumentare la prosperità della città.
Tuttavia in famiglia restava sotto il controllo del proprio marito o del proprio padre, che continuava a sostenere la famiglia come in passato. Finché la maggior parte delle donne dipese dal lavoro degli uomini e svolse lavori che nell'economia nazionale occupavano soltanto un posto secondario, la sua custodia restò invariata.
Nella classe dei signori e dei grandi proprietari terrieri, la donna viveva sotto il dominio del marito; tuttavia essa godeva di un certo prestigio, in quanto era responsabile dell'organizzazione dell'economia domestica feudale. Ma proprio all'epoca del feudalismo l'economia naturale è arretrata in favore dell'economia di scambio e si è sviluppato l'artigianato. Il denaro si è quindi imposto come moneta di scambio e il numero dei servitori che eseguivano lavori a pagamento si è rapidamente moltiplicato. Di conseguenza la donna in quanto organizzatrice economica perse molto del suo valore. Divenne inutile continuare a immagazzinare con competenza provviste per parecchi anni o sorvegliare la produzione domestica all'interno del castello. Il controllo e la ripartizione metodica delle riserve degli accantonamenti erano diventate altrettante attività superflue, poiché la maggior parte delle necessità potevano essere soddisfatte senza troppe difficoltà, con un giro di acquisti nella vicina città commerciale e artigianale. Le fortificazioni che tra il IX e il XII secolo erano ancora un'unità economica chiusa sotto la direzione della castellana, divennero veri e propri covi di briganti. La cavalleria cercava solo di massimizzare i suoi profitti per dotare il castello e i suoi abitanti di tutto il lusso possibile e immaginabile. Il che poteva accadere solo succhiando abbondantemente il sangue alla classe contadina da parte della borghesia delle città. Le donne dell'aristocrazia finirono per disprezzare ogni forma di lavoro e rinunciarono persino ad occuparsi della propria famiglia. Abbandonarono il governo ai loro servi o ai loro domestici. Il compito di queste donne si limitava a giocare alle "galline ovaiole" e mettere bambini al mondo.
Avendo raggiunto il suo punto culminante, la forma economica feudale non tarderà a diventare un freno all'ulteriore sviluppo delle forze di produzione. Lo stesso è valso per il lavoro dei servi. Il nuovo sistema economico che stava nascendo, cercava di trarre il massimo profitto dalle operazioni commerciali e di scambio. Secondo le leggi imprescindibili dello sviluppo economico il sistema esistente è diventato ormai obsoleto ed è stato sostituito da un altro basato sul commercio di scambio, il capitalismo (ndt 13).
Vi chiedo ancora un po' di pazienza. Prima di passare all'analisi della collocazione della donna in seno al capitalismo è necessario che voi possiate avere chiaro che il capitalismo non è apparso improvvisamente, in tutta la sua forza, come lo conosciamo oggi. Nel corso del suo sviluppo ha seguito naturalmente diverse fasi. Ha avuto inizio con un processo di concentrazione del capitale, sia nel commercio (all'epoca il capitale mercantile era il più redditizio), che nella produzione. Verso la fine del XVIII secolo, la manifattura (ndt 14) si è progressivamente evoluta verso la forma della fabbrica e dell'impresa industriale. In quel momento il capitale industriale ha avuto la meglio sul capitale mercantile ed è diventato il fattore sempre più dominante dell'economia. Così assistiamo a un periodo di concorrenza illimitata, in cui i piccoli e i grandi produttori si sono battuti senza sosta. I piccoli produttori furono spietatamente rovinati dal grande capitale e il mercato del lavoro si ritrovò, in modo costante, con un eccesso di manodopera disponibile. Nel XIX secolo le industrie si sono fuse sotto forma di trust imponendosi parallelamente alla vittoria della grande produzione. D'altro canto, nel sistema economico capitalista, il capitale finanziario (ndt 15) era stato finora una forza sconosciuta.
La sovrapproduzione dei paesi più sviluppati e la ricerca di nuovi sbocchi per il capitale accumulato, hanno spinto gli Stati capitalisti ad una politica di conquista coloniale. Pertanto il sistema capitalista, raggiunto il suo punto culminante, non può che crollare, data la necessità di continuare ad aumentare le forze produttive richieste dallo sviluppo economico. Il sistema capitalistico impedisce proprio lo spiegamento di queste forze e non lascia spazio alla creatività economica della classe operaia, che è diventata la principale classe produttiva. In sostanza, rimane una sola via d'uscita: un sistema economico più sviluppato dove riuscire a imporsi, consentendo lo sviluppo dell'attività creativa economica e lo sviluppo completo del potenziale di lavoro della collettività laboriosa lavoratrice, ossia il comunismo. Mi sono 3volutamente allontanata dall'argomento perché volevo darvi una visione d'insieme - anche se grossolana - della storia dello sviluppo capitalista.
Ma torneremo ora all'inizio di questo processo di sviluppo, al momento in cui nasce il capitalismo mercantile (ndt 16). A quel punto si intensificò la lotta tra il feudalismo e il capitalismo, rendendo obsoleta l'economia naturale. In alcuni paesi, come l'Italia, questo processo si concluse all'inizio del XII secolo; in altri paesi come la Francia e l'Inghilterra, non cominciò prima del XIV secolo e si estese in Germania per tutto il XVII secolo, fino alla metà del XVIII secolo. In Russia, questa evoluzione si è attenuata solo all'inizio del XVIII e si è protratta fino al XIX secolo. In Asia è ancora in corso. La disuguaglianza dello sviluppo capitalista nei vari paesi può essere spiegata da una serie di circostanze, che nella maggior parte dei casi restano nell'ambito della casualità. Nel complesso, la prima fase dello sviluppo capitalista si svolge ovunque nello stesso modo. Ma poiché questo stadio ha avuto un peso decisivo sul destino delle future generazioni di donne, ci occuperemo adesso in modo particolare di questo.
Cosa caratterizzava il sistema capitalista? In che cosa si distingueva dagli stadi di sviluppo economico precedenti? Il capitalismo non si basava più sul lavoro dei contadini servi, ma su quello dei lavoratori liberi. Nell'economia naturale, in cui il commercio di scambio era solo scarsamente sviluppato, la produzione era orientata al soddisfacimento dei bisogni vitali e non alla vendita. Nella produzione artigianale, l'artigiano lavorava su ordinazione e per uno spazio di mercato limitato. Non vendeva la sua forza lavoro, ma il suo prodotto. Sotto il sistema capitalistico di produzione, il lavoratore vendeva la sua forza lavoro al capitalista. Durante l'epoca d'oro dell'artigianato, il padrone non era affatto interessato all'aumento della produttività. I prezzi erano fissati dall'azienda e non doveva preoccuparsi degli ordini. Le forze di produzione aumentarono lentamente. Nel capitalismo, l'imprenditore o a seconda dei casi l'intermediario, cercava un profitto costante, il che significa che si preoccupava sia di ampliare i propri sbocchi, che di aumentare la produttività. Quest'ultima si può ottenere con un maggior sfruttamento degli operai, ma anche con l'introduzione di nuove forme di lavoro - ad esempio il sistema della manifattura e lo sviluppo della tecnica. Mentre i maestri di corporazione cercavano di limitare in tutti i modi possibili l'aumento del numero delle apprendiste, poiché temevano la concorrenza, i capitalisti cercavano invece di disporre del maggior numero possibile di lavoratrici. Di conseguenza, le forze di lavoro a basso costo erano molto ricercate e questa domanda è stata anche all'origine della partecipazione delle donne alla produzione.
I primi periodi del capitalismo, tra il XIV e a seconda dei casi, il XVII o il XVIII secolo, furono tempi molto duri per coloro che non avevano la fortuna di appartenere alla classe possidente. Era un periodo buio e movimentato, ricco di significati per gli uomini, ma in cui le guerre intestine tra l'aristocrazia degenerante e la crescente borghesia segnavano l'annientamento del precedente sistema produttivo.
La nascita di questo nuovo sistema economico è avvenuta senza conseguenze? Città e villaggi furono ridotti in cenere. I mendicanti, i vagabondi e altri senzatetto si moltiplicarono in modo allarmante. Per un periodo relativamente breve, le donne sole furono immesse nel mercato del lavoro. Donne di artigiani rovinati, contadine che cercavano di sottrarsi alle eccessive tasse dei signori, innumerevoli vedove di guerre civili e nazionali, senza dimenticare la folla brulicante di orfani, le donne affamate invasero le città dove si rifugiarono in massa. La maggior parte di loro cadde nella prostituzione, mentre le altre offrirono i loro servizi ai maestri artigiani con una tenacia diventata insolita ai nostri giorni. Dopo essere riuscite a entrare nel ruolo, si sono impegnate a consolidare la loro posizione. Spesso erano vedove o figlie di vedove che, per la loro abilità lavorativa o per la loro astuzia, contavano di trovare in bottega un marito a loro piacimento. La corsa della forza lavoro a buon mercato nelle officine era tale nel XIV secolo e all'inizio del XV secolo, che le corporazioni, per mettere un freno alla concorrenza femminile, furono costrette a regolamentare il loro accesso ai mestieri artigianali. Alcune corporazioni dissuaderono i padroni dall'assumere donne in apprendistato. Si andò persino a vietare alle donne l'esercizio di determinati lavori. In Francia, ad esempio, una legge emanata nel 1640 proibì alle donne di fabbricare pizzi ai fusi, benché si trattasse di un mestiere tipicamente femminile.
La fame, la povertà e l'assenza di una casa costrinsero le donne a rispettare le leggi a loro imposte. Si rassegnarono a lavori che non erano ancora riservati esclusivamente agli uomini e dato che le loro possibilità di successo erano scarse, sottovalutarono il valore della loro forza lavoro. Il che ha aggravato ulteriormente le loro condizioni di vita. Non sorprende quindi che, a partire dalla fine del XIII secolo, il numero dei conventi si moltiplicò in modo insolito. Il convento era un rifugio sicuro per le contadine o le cittadine sole e indifese.
Qui le donne trovavano protezione dalla povertà e dalla violenza delle classi dirigenti. Ma anche le donne di alto rango si ritirarono nei conventi per sfuggire al dispotismo del marito o del padre. Nel Medioevo vennero aperti dei rifugi per donne sole, chiamati "beghinaggi". In generale erano finanziati dalle donazioni di ricchi benefattori che cercavano di riscattare i propri peccati e di assicurarsi un posto nell'aldilà. I beghinaggi erano comunità di donne lavoratrici, animate da un severo spirito religioso. Le abitanti di queste case conducevano una vita di abnegazione e si impegnavano ad eseguire tutto il lavoro che veniva loro affidato. Indossavano un abito particolare e sulla loro testa un cavolo bianco, o béguin, come una cuffia che le distingueva dalle altre donne della città. Per questo le chiamavano "beghine". Dovevano svolgere tutte le mansioni - visitare i malati, cucire, filare, ecc. - che i borghesi esigevano da loro. Le leghe fioriscono tra il XIII e l'inizio del XV secolo e poi spariscono. La causa principale della loro disaffezione è stata la comparsa delle botteghe di manifattura alle quali le donne sole si sono rivolte. Così, durante il XV e XVI secolo, quindi fino ad un'epoca più avanzata, le donne tentarono di riunirsi in associazioni diverse per lottare contro l'aggravarsi delle loro condizioni di lavoro e di vita.
Il XV e XVI secolo sono stati battezzati col prestigioso nome di Rinascimento. Sarebbe più giusto definire questo periodo "periodo della formazione del capitalismo". L'economia naturale e autarchica era finita. Le forze produttive richiedevano un altro sistema economico per continuare a prosperare. Il nuovo capitale commerciale cercava nuovi mezzi per aumentare i propri profitti. Il grande proprietario terriero che faceva trottare i suoi servi a colpi d'arma da fuoco fu sostituito da un altro personaggio, l'imprenditore intermedio, che comprava la forza lavoro dei poveri, costringendo il proletariato in crescita a riempirgli le tasche. Le prime vittime di questo gruppo di imprenditori rapaci in rapida espansione erano naturalmente le donne, senza sostegno e senza protezione. A quel punto, parallelamente alla produzione artigianale assoggettata al regime delle corporazioni, nasce un nuovo ramo dell'economia, il "lavoro a domicilio". Si va sviluppando tra il XV e il XVII secolo in quasi tutti i paesi europei.
Il lavoro a domicilio rappresenta una forma transitoria tra l'artigianato e il lavoro salariato. Si distingueva dall'artigianato per il fatto che quest'ultimo non necessitava di un intermediario tra il prodotto e il suo acquirente. Al contrario nel lavoro a domicilio il produttore distribuiva il suo prodotto attraverso un acquirente che si accaparrava un preciso mercato. L'operaia a domicilio rinunciò quindi ad una certa parte del suo utile a favore dell'intermediario. Per poter provvedere in modo dignitoso alle proprie necessità, l'operaio, nella fattispecie l'operaia, fu costretta ad aumentare costantemente il proprio rendimento. Ciò ha comportato un aumento generale della produttività contemporaneamente a una nuova forma di sfruttamento.
Con l'aumento del numero di lavoratori a domicilio che, per potersi nutrire, dovevano produrre sempre più, divenne necessario non solo vendere i propri prodotti all'acquirente intermedio, ma anche reclamare a quest'ultimo la fornitura del materiale da lavoro. Ciò significava il passaggio al lavoro a cottimo o lavoro salariato.
Tra il XI e il XIV secolo, nelle grandi città italiane, accanto all'artigianato in declino, si diffuse tutta una serie di attività a domicilio. In particolare, le industrie di tessitura, di filatura, di ricamo su seta e altri rami del lavoro che occupavano in modo particolare le donne. Nelle Fiandre parte dell'Olanda e in Inghilterra, nacque nel XV e XVI secolo la confezione dell'abbigliamento e dei tessili. La produzione era nelle mani di imprenditori che assumevano operaie a domicilio. Le donne povere e prive di risorse non erano tuttavia le uniche ad essere coinvolte nella produzione. Il lavoro a domicilio offriva alla contadina la possibilità di lavorare, senza per questo essere costretta a lasciare la sua casa o la sua famiglia. Il lavoro a domicilio divenne, in un momento in cui le esigenze del grande proprietario terriero continuavano a crescere, un importante apporto economico per la popolazione laboriosa delle campagne. Ma con l'aumento del numero di uomini che avevano accesso alla produzione, i metodi di sfruttamento degli imprenditori peggioravano, aggravando ulteriormente la sorte dei poveri. La situazione delle donne era particolarmente desolante. Gli imprenditori sapevano perfettamente che potevano fare di questi poveri quello che volevano. Per esempio potevano minacciare la contadina in fuga di consegnarla al suo signore o denunciare la cittadina che era stata costretta a prostituirsi e a vagabondare, il che portava a sanzioni severe e umilianti. Per questo le operaie a domicilio e più tardi le salariate delle manifatture, accettarono le condizioni dettate da questa sanguisuga che fu l'intermediario.
Al culmine dell'artigianato, se nella famiglia la donna era senza diritti e sotto la tutela del marito, tuttavia come membro e produttrice della corporazione, godeva del rispetto e della considerazione di tutti. L'operaia a domicilio perse questo privilegio. Il suo duro lavoro - perché lavorava dal mattino fino a tarda notte - rivestiva agli occhi dell'impresario solo un valore aggiunto al suo lavoro domestico. Le norme delle corporazioni, per quanto modeste, che tutelavano il lavoro delle donne nei laboratori di artigianato, non furono presto più applicate alle operaie a domicilio. E non è così anche al giorno d'oggi: le donne che devono guadagnarsi da vivere con lavori a domicilio sono le più svantaggiate. La qualifica di sfruttamento sanguinario attribuita al sistema del lavoro a domicilio è quindi del tutto giustificata.
La cosa più dolorosa del lavoro a domicilio è stata, da un lato, l'interminabile giornata di lavoro e dall'altro, le basse tariffe orarie. La crescente concorrenza tra le lavoratrici a domicilio non organizzate e il timore di perdere le commesse degli imprenditori, le portarono ad effettuare giornate di quattordici e persino quindici ore di lavoro. Ma i redditi non aumentavano in proporzione, anzi, al contrario, tanto che le lavoratrici a domicilio e le loro famiglie continuarono ad impoverirsi. La donna vendeva il proprio corpo alla luce del sole. La prostituzione fuori dalle case chiuse si è diffusa massicciamente nelle città in cui il capitalismo nascente era riuscito ad integrarsi con successo.
Spesso questi imprenditori, trafficanti e commercianti, erano uomini audaci e arditi. Nella loro continua ricerca di nuovi mercati essi svolgevano lunghi e pericolosi viaggi di esplorazione, ampliando così il loro orizzonte. La ricerca di questi mercati ha permesso la scoperta dell'America (1493) e ha aperto la strada dell'India al traffico marittimo. La classe capitalista attiva e in piena espansione garantiva lo sviluppo della scienza e la libertà di pensiero. Le debolezze che un tempo erano state alla base del sistema capitalista, ossia l'inerzia, l'assoggettamento e la cieca fede ai valori secolari di diritto e di morale, ora frenavano lo sviluppo economico. La crescente borghesia si liberò rapidamente di queste nozioni obsolete. Ha scosso la base della Chiesa cattolica dominante e ha costretto i rappresentanti della Chiesa a riconoscere la potenza monetaria. Hanno messo in discussione l'infallibilità del Papa. La borghesia dispiegò nelle guerre di religione la bandiera della ribellione e combatté contro il potere dei grandi proprietari terrieri e del feudalesimo. La borghesia riuscì anche ad imporre il concetto che il capitale è un bene più prezioso della proprietà terriera, dalla redditività incerta.
Questo periodo di transizione verso un nuovo sistema è stato scosso da innumerevoli crisi. Ma era anche un'epoca ricca e brillante, che mise fine all'atmosfera oscura, soffocante e brutale del Medio Evo. Quando l'umanità scoprì le leggi di rotazione delle stelle e altre verità scientifiche di base, la scienza e il pensiero si svilupparono rapidamente. Da quando la società non era più divisa in stati (nobiltà, clero, terzo stato), la ricchezza rapidamente acquisita si concentrò nelle mani di una minoranza, mentre la grande maggioranza si impoverì in modo particolare. All'epoca esistevano solo due classi principali che si ergevano con ostilità: la classe dei possidenti e quella dei non possidenti. La nascita dell'economia monetaria indusse i signori a sostituire le attività quotidiane svolte in natura con il prelievo di imposte in denaro estremamente pesanti per i contadini. Ciò contribuì a tendere ancora di più i rapporti tra proprietari terrieri e i contadini. Questi si ribellarono apertamente contro i signori. Si unirono nella "nuova religione", ossia il luteranesimo, il calvinismo e altre dottrine. Tutta l'Europa è stata devastata da un'ondata di guerre contadine. Nelle città la popolazione si divide in due parti: da un lato, i rappresentanti del capitale commerciale, i ricchi; dall'altro, gli artigiani delle corporazioni e i lavoratori a domicilio. Una sorda lotta si accese tra le due fazioni. I commercianti benestanti dirigevano la città. Più tardi essi estesero il loro potere nei dintorni, dove i contadini impoveriti cercavano faticosamente di raccogliere con il lavoro a domicilio il denaro necessario per pagare tasse e canoni di ogni tipo. La vita era solo una lotta senza tregua e disperata per l'esistenza, una competizione e una lotta permanenti. Il mondo invecchiato del feudalesimo crollò. Ma il capitalismo era solo ai suoi primi vagiti.
Qual è stata la posizione economica della donna in questo periodo di crisi economica?
Nella nuova legislazione dei XIV e XV secolo, la donna è stata, come in passato, considerata un essere minore e dipendente dall'uomo. Rispetto agli usi e alle consuetudini del Medio Evo, la posizione della donna si era aggravata durante il fastoso periodo del Rinascimento. Nell'interesse del capitale le ricchezze accumulate non potevano essere frammentate tra innumerevoli eredi, per cui le ragazze persero il loro diritto all'eredità. All'epoca della cavalleria la donna era proprietaria legale della sua dote. I legislatori del Rinascimento, per garantire il processo di accumulazione del capitale, decisero che tutti i possedimenti della moglie sarebbero andati al marito. Si emanavano leggi che punivano la prostituzione, ma senza tener conto delle condizioni che spingevano le donne ad esercitare questo mestiere. Il nuovo ordine sociale, conseguenza della presa di potere della borghesia, non ha affatto strappato la donna alla tirannia del Medio Evo e non ha portato alcun miglioramento alle sue condizioni di vita. L'antica mancanza di diritti, la subordinazione e lo sfruttamento continuarono a regnare, ma in forme diverse e finora sconosciute.
In questo periodo movimentato e contrastante, incontriamo tipologie di donne diametralmente opposte. Da un lato, il corteo di donne indebolite dal lavoro e dalle preoccupazioni, assolutamente prive di diritti, rassegnate e sottomesse al loro "benefattore"; dall'altra parte, le donne parassite e disubbidienti che nuotano nel lusso, avide di distrazioni di ogni tipo per cercare di sfuggire alla loro noia. Queste ultime, le mogli di conti e di principi impegnati a sperperare la loro fortuna, abbandonarono naturalmente la cura della loro famiglia e della loro progenie alla servitù. Certo, questi parassiti non avevano più diritti di quelle precedenti, ma finché il potere del denaro e del titolo garantiva loro una vita piacevole, era anche molto più facile per loro farne a meno. Il matrimonio era per loro un affare commerciale, una semplice questione di denaro. L'influenza della Chiesa si allentò e le signore cessarono di consultare i sacerdoti per le loro questioni di cuore. Dopo tutto, c'erano altri modi per aggirare la legge. Il vigoroso periodo del Rinascimento offriva un quadro variopinto di dissolutezza e di eccessi amorosi di ogni genere. Gli scrittori dell'epoca, tra cui il grande scrittore satirico e storico Boccaccio, descrivevano onestamente e senza mezzi termini il clima di immoralità che regnava allora.
All'epoca del Rinascimento le donne della classe dominante divennero creature senza anima, ipocrite, arroganti e inutili, la cui unica funzione era quella di distrarre gli uomini. Questi parassiti della società si interessavano solo alla moda e alle distrazioni. Le suore del Medio Evo, preoccupate di "verità eterne", erano di gran lunga superiori a queste donne, così come le castellane responsabili del buon funzionamento dell'economia domestica feudale e che partecipavano coraggiosamente alla difesa del castello in caso di attacchi nemici.
Da un lato, lato luce, suonavano le risate e i cinguettii delle belle imbrigliate di seta e di pietre, alla ricerca di divertimento. Dall'altra parte, lato ombra, nelle fasce più svantaggiate della popolazione, le contadine e le operaie a domicilio conducevano una vita miserabile, piegate sotto il peso di un lavoro eccessivo. Anche l'artigiano di una potente corporazione, con la concorrenza che continuava a crescere, temeva per il suo futuro, perché rischiava in ogni momento di ritrovarsi in strada. Mentre le une si divertivano e festeggiavano, le altre soffrivano di precarietà, povertà e fame. E' stato effettivamente un secolo ricco di contrasti e di diversi sconvolgimenti. La società ha quindi ridistribuito le classi, il potere del denaro si è rafforzato e la forza lavoro libera è diventata una merce negoziabile.
Ma il Rinascimento non aveva solo aspetti negativi. Infatti in questo periodo di profonde trasformazioni si aprono anche le valvole della creatività umana nei settori più disparati, dai nuovi metodi di produzione alle conquiste della scienza e della filosofia. Ragione e volontà umana cercarono e sperimentarono insieme.
Mai, finora, l'individualità umana aveva acquisito un tale valore. Nelle culture greca e romana, l'individuo era riconosciuto come cittadino dello Stato, ma non come essere umano. Nel Medioevo, il valore di un uomo dipendeva dalla sua posizione sociale e dai suoi titoli. La borghesia in ascesa chiedeva ora il diritto al riconoscimento individuale. Nel primo periodo dell'accumulo di capitale, il patrimonio del commerciante o dell'imprenditore era ancora considerato come il risultato del suo lavoro e delle sue doti personali, tenacia, coraggio, determinazione, forza di spirito e di volontà. Per questo motivo la borghesia riteneva che, se la ricchezza era superiore al rango e ai titoli, lo fossero anche le donazioni, i meriti e le realizzazioni individuali indipendenti dalle origini familiari. Queste nuove concezioni svolsero anche un ruolo nella relazione con la donna, anche se solo all'interno della borghesia. Infatti, non era di alcun interesse che i plebei, i lavoratori asserviti della società, potessero avere una "personalità umana".
Durante questo periodo di transizione, la donna distinta godeva, in seno alla borghesia in ascesa, di un certo riconoscimento e di alcune libertà. Queste donne non potevano solo ammazzare il tempo in innumerevoli feste e riunioni mondiali, ma avevano anche libero accesso, se lo avessero voluto, agli studi scientifici e filosofici. Esse potevano anche ampliare le loro conoscenze a contatto con i famosi pensatori dei loro tempi e nel caso in cui ne avessero provato il desiderio, partecipare attivamente alla politica. Così il Rinascimento ebbe anche il suo contingente di donne forti ed espressive. Molte donne ebbero una corrispondenza con filosofi e poeti del loro tempo. Intorno ad esse si riunirono persone progressiste che condividevano le stesse idee. Proteggevano e incoraggiavano con la loro amicizia numerosi studiosi, artisti e poeti.
Durante le guerre civili, le donne combattevano coraggiosamente al fianco degli uomini e questo in entrambe le parti. Parteciparono alle guerre di religione che misero a fuoco e sangue tutta l'Europa e che furono al centro della lotta tra feudalesimo e borghesia. Spesso sorpresero i loro nemici per la loro grande resistenza e la loro ostilità. Le guerre civili del XVI secolo (vale a dire la lotta tra gli ugonotti borghesi e i cattolici nobili in Francia, lo scontro tra i luterani e i seguaci della Chiesa cattolica in Germania, tra i cattolici e i protestanti in Inghilterra, ecc.), le guerre civili dunque strapparono spesso le donne alle loro case. Non solo persero tutti i loro beni, ma furono massacrate, imprigionate o condannate al rogo, fianco a fianco con i loro correligionari "eretici".
Ma le donne non si sono arrese di fronte ai tormenti provocati dalle guerre civili. Il loro istinto di classe era superiore alla loro passività, sottomissione e rassegnazione abituale. Altrettanto caratteristico è stato il fatto che gli uomini, che prima avevano predicato che il posto delle donne era a casa, cercavano allora di ottenere la loro adesione e di trascinarle nel vortice delle lotte sociali e politiche.
I riformatori religiosi (Lutero, Calvino e Zwingli) avevano mogli che non si accontentavano solo dei loro lavori domestici. Erano anche loro allieve e e adepte appassionate. In ogni caso la donna ha svolto un ruolo importante nella riforma della Chiesa. In effetti, la riforma, che lottò contro l'autorità del feudalismo, aprì la strada alla borghesia. Le mogli di alti dignitari appoggiarono alla corte le nuove religioni. A volte persino le regine ingaggiavano segretamente i propri sacerdoti protestanti, cioè gli ideologi della borghesia. Diffondevano le nuove religioni, partecipavano alle cospirazioni e alle riunioni segrete e elevavano i loro figli nello spirito della nuova classe. Le donne erano spesso seguaci più zelanti delle nuove religioni che gli uomini. Scrivevano opere per la difesa del protestantesimo, affrontavano le torture dell'Inquisizione con lo stesso eroismo dei martiri della prima comunità cristiana e incoraggiavano, con la loro resistenza, i deboli e gli esitanti.
Molte donne appartenenti alle classi feudali sostengono la riforma. Il che è facilmente spiegabile. La borghesia, assumendo il potere, aveva inferto un colpo mortale al diritto paterno, cioè all'onnipotenza dell'uomo sulla moglie e i suoi figli. Promise alla donna di classe benestante il riconoscimento della sua individualità e dei suoi diritti umani. Per questo motivo la donna si è appassionata ai riformatori e agli umanisti, i pionieri del suo tempo. Così appaiono figure come Renata di Francia [Renata di Valois-Orléans, ndt], figlia del re di Francia, che rinunciò al suo titolo e alla sua fortuna e riunì il protestantesimo. Le aristocratiche russe, come la Morozova [Feodosija Prokof'evna Morozova, ndt], presero il sopravvento sullo zar e aderirono al movimento democratico popolare Avvakoum (l'arciprete Avvakoum, morto nel 1682, fu il fondatore di una setta russa). Guglielma la Boema, figlia del re di Boemia, fondò una setta e fu fermamente convinta che fosse lei stessa l'incarnazione dello Spirito Santo. Dopo aver ricevuto una solida istruzione, lasciò il suo paese per recarsi a Milano dove, grazie al suo talento da oratrice, convinse numerosi adepti, tra cui sacerdoti, monaci e arcivescovi. Il movimento religioso si chiamò dei Guglielmiti in onore della sua fondatrice. Tuttavia, dopo la sua morte, il suo corpo fu bruciato su ordine del Papa.
A Firenze apparve un'altra setta, la Catherine, fondata da una fiorentina, conosciuta anche per i suoi talenti da oratrice. I cronisti la descrivono così: "Le sue parole le guadagnarono molti adepti".
Le donne allora avevano un'influenza notevole sulla politica. Mentre alcune di esse abbracciarono la nuova fede, le altre difendevano con altrettanta determinazione i principi e le prerogative immutabili della classe feudale. Tra il XVI e il XVIII secolo, ad esempio, le donne esercitarono un'influenza diretta o indiretta sulla politica francese. Questo è stato il caso dell'intelligente e furba Caterina de' Medici [ndt. Caterina Maria Romula di Lorenzo de' Medici, ndt], cattolica convinta e intrigante senza scrupoli (fu lei la responsabile della notte di san Bartolomeo, dove i protestanti furono massacrati per tradimento) e di Anna d'Austria, che rivaleggiò con il potente Richelieu. Due regine, Elisabetta d'Inghilterra e Maria Stuarda di Scozia, furono entrambe a capo di due gruppi antagonisti: da un lato, la Scozia feudale arretrata; dall'altra parte, l'Inghilterra progressista dove l'industrializzazione era più avanzata. In Russia, Sof'ja , figlia dello Zar Alessio Michajlovic Romanov e sorella di Pietro il Grande, è stata l'ispiratrice della congiura che avrebbe dovuto opporsi alla limitazione delle privilegi dei boiardi.
La contessa Mackintosh [Lady Anne Mackintosh, ndt] comandava le truppe dei sostenitori degli Stuart, suo marito dirigeva le truppe dell'opposizione, cioè l'esercito protestante della regina Elisabetta. Quando il "colonnello Anna" incontrò suo marito prigioniero, si scoprì secondo l'uso e lo accolse con queste parole: "Sono a vostra disposizione, capitano" e quest'ultimo disse: "Sono al vostro servizio, colonnello".
La storia è piena di esempi di donne che hanno partecipato attivamente ai sanguinosi combattimenti delle guerre civili. Ecco perché non è sorprendente incontrare donne che siedono in Parlamento o che, nonostante la loro posizione subalterna e senza diritti, svolgono missioni diplomatiche.
La Francia ha incaricato Mme Delhay come ambasciatrice a Venezia e Mme Gabrielle ha occupato lo stesso incarico in Polonia. Durante le discussioni estremamente delicate che presiedettero all'elezione del duca d'Angiò come re di Polonia, Catherine de Clairmeau, notevole diplomatica, guidò la delegazione francese.
Durante il Rinascimento e la Riforma, le donne non si accontentavano di fare politica, né di partecipare attivamente alle guerre civili. Inoltre, esercitavano una grande influenza su scienza, arte e filosofia. L'Italia di quell'epoca fu la culla di scoperte straordinarie, la patria di pensatori e creatori la cui influenza fu enorme. Grazie alla posizione geografica favorevole di questo paese, il capitale mercantile si sviluppava più presto che altrove, determinando presto il capitale industriale. È all'epoca del XIII secolo che incontriamo nelle fiorenti città italiane le prime manifatture. In un paese economicamente così sviluppato, l'influenza della borghesia cresceva rapidamente e le donne che si erano formate una reputazione grazie al loro lavoro intellettuale o artistico non erano più eccezioni.
Molti storici hanno definito il secolo del Rinascimento secolo "donne sapienti". Potremmo citare ad esempio Olimpia Morata figlia di un professore di Ferrara, che aveva una solida formazione scientifica e improvvisava conferenze straordinariamente viventi e immaginifiche. Olimpia era molto amica di Renata di Francia [Renata di Valois-Orléans, ndt], una delle prime seguaci del protestantesimo. Lei stessa si pronunciò per la nuova religione, sposò uno scienziato e attraversò con lui le prove della guerra civile. Un altro caso fu quello di Isotta Nogarola, famosa in tutta Italia per i suoi talenti di oratrice e di cui lo stesso Papa ha riconosciuto pubblicamente l'interesse che nutriva per le sue conferenze.
Ippolita Maria Sforza era una mecenate e un'attivista politica. Vittoria Colonna era legata da amicizia a Michelangelo su cui esercitava una grande influenza. Godeva dell'ammirazione di molti dei suoi contemporanei ed è stata descritta come un'alta figura spirituale, piena di maestà e di grazia. Nello stesso periodo, le due teologhe, Isabella Colonna e Juliane Morelli, si facevano un nome in Spagna. L'Inghilterra, dove il Rinascimento è comparso solo dopo, era famosa nel XVI secolo per l'istruzione delle sue donne. Le regine d'Inghilterra padroneggiavano perfettamente il latino e la grande cultura di Lady Jane Grey non era un segreto per nessuno. La madre del filosofo Bacone, figlia del precettore di Enrico VIII, si è distinta per le sue straordinarie conoscenze scientifiche. E lo stesso vale per Margaret Roper, la figlia dell'utopista Sir Thomas More. Margherita d'Angoulême, regina di Francia, era soprannominata scrittrice della scuola italiana. La sua corrispondenza è ancora oggi in parte interessante. Anne Le Fèvre Dacier, figlia di un filosofo esperto, tradusse Omero e celebrò nei suoi trattati la bellezza imperativa delle epopee dell'Iliade e dell'Odissea.
Le donne colte passavano per essere attraenti. Molière scrisse una satira, l'Hotel Rambouillet, dove ridicolizzò le donne che si interessavano alla scienza definendole calzini usati.
Per quanto riguarda l'Italia, il Rinascimento è stato un periodo in cui le donne hanno beneficiato a volte di una formazione più approfondita. Non è possibile attribuire questo solo alla moda o alla mania. Il fatto che ci fossero così tante donne che cercavano di conquistare un'esistenza autonoma attraverso lo studio e la conoscenza, ovviamente, aveva cause puramente economiche e sociali. La guerra civile e il crollo delle condizioni di produzione che avevano dominato finora hanno indebolito la forza di resistenza dell'istituzione familiare. Il maremoto della rivoluzione economica ha gettato sempre più donne nella lotta per la sopravvivenza, non solo le donne delle classi svantaggiate, ma anche i membri isolati della borghesia e talvolta anche della nobiltà. Le donne dei contadini e le mogli degli artigiani rovinati lavorarono nell'industria domestica. Tuttavia, le donne di buona famiglia, grazie alla loro conoscenza e alla loro formazione, tentarono di abbracciare una carriera scientifica o letteraria per assicurarsi così una certa sicurezza materiale. Molte donne famose erano figlie di insegnanti, scrittori, teologi o scienziati. Questi padri si preoccupavano di dare alle loro figlie la migliore arma per la lotta per la vita, cioè la conoscenza. In un'epoca tormentata, il matrimonio non era più una garanzia sufficiente per garantire la loro sicurezza. Le donne dovevano pensare a proteggersi dalla povertà e dalla privazione materiale ancora minacciose e a prepararsi a guadagnarsi da vivere con i propri mezzi. E' stato quindi naturale per queste donne intraprendere un'ulteriore formazione e chiedere pari diritti. Talvolta si spinsero persino ad affermare nelle loro argomentazioni che la natura femminile era superiore alla natura maschile. Questa concezione è stata diffusa in Francia nel XV secolo, ad esempio, da Christine de Pizan (autrice de Il Dibattito sul "Romanzo della Rosa", poesie dirette contro la seconda parte antifemminista del Romanzo della Rosa e della Città delle Dame).
Nel XVII secolo, l'inglese Mary Astell adottò posizioni molto più aggressive nella sua lotta per i diritti della donna. Nel suo eccellente libro A Serious Proposal, che la rese famosa, chiedeva l'uguaglianza di genere nell'istruzione. Lo scrittore italiano Tommaso Campanella, che difendeva con forza questi pensieri, nella sua utopia politica chiedeva nella Città del Sole, non solo il diritto all'istruzione, ma anche l'accesso a tutte le professioni senza eccezioni: "La donna deve avere accesso a tutto ciò che riguarda la guerra e la pace."
Fintanto che rivendicazioni di questo tipo furono formulate all'epoca delle guerre civili e mentre la borghesia utilizzava volentieri la donna per servire i propri propositi politici, sembravano accettabili. Ma poiché queste idee non corrispondevano in realtà alle concezioni della borghesia o ai suoi interessi economici, la lotta delle donne per l'uguaglianza fu ben presto definita utopistica e derisa. La forza di resistenza della famiglia rispetto al mondo circostante era il fondamento della ricchezza di questa classe. Così, non appena svanirono i fumi delle guerre civili, la borghesia gettò freddamente in mare tutto ciò che non rientrava nelle sue vedute e nelle sue concezioni.
Le donne di cultura e politicamente attive del Rinascimento furono di nuovo ampiamente e completamente assorbite dai loro compiti domestici. Tale ritiro all'interno dello stretto guscio familiare ebbe luogo parallelamente alla stabilizzazione del nuovo ordine economico e allo sviluppo del capitale industriale.
A cosa si doveva tutto questo? Come potevano le donne tornare ai loro forni senza battere ciglio, dopo un periodo in cui erano state particolarmente attive in tutti i settori della società?
Sappiamo già che i diritti della donna e la sua situazione nella società dipendono dalla sua partecipazione al lavoro produttivo. All'epoca del Rinascimento, la donna era rimasta per lo più dipendente dal marito o dal padre, il capofamiglia. In realtà era solo una minoranza e non una maggioranza di donne, che cercava di crearsi un'esistenza indipendente. E anche se molte donne appartenenti a classi più svantaggiate si avventurarono nel mercato del lavoro, restavano comunque una minoranza accanto alla grande maggioranza di contadine e donne di artigiani che continuavano a vivere al riparo dalle attività del marito.
La conferenza di oggi si è prolungata un po' più del previsto. Ma avete potuto farvi un'idea del fantastico periodo di formazione del capitalismo. Tuttavia, prima di passare al periodo successivo e di avviare l'analisi delle condizioni di vita della donna durante lo sviluppo della grande industria, dobbiamo occuparci ancora di una caratteristica del periodo che ci interessa qui oggi, vale a dire lo sviluppo della manifattura.
La manifattura, proveniente dall'industria a domicilio, non era nient'altro che la riunione sotto lo stesso tetto degli operai a domicilio, fino ad allora sparpagliati. In tal modo è stato più facile rifornire l'operaio di materie prime e anche più facile riunire i prodotti finiti e manifatturati. Più tardi, il capitalista scoprirà che è possibile aumentare la produttività attraverso una divisione del lavoro più razionale. Nelle fattorie è nata un'organizzazione moderna del lavoro e la sua divisione ne ha semplificato il processo. Questo sistema è stato perfezionato al punto che un operaio poteva passare anni su un'unica operazione, ad esempio affilare gli aghi. Se il lavoro dell'artigiano era complesso e richiedeva un saper fare professionale, il lavoro dell'operaio reclamava esattamente il contrario, era semplice e la sua esecuzione insipida. Chiunque era in grado di imparare in un periodo estremamente breve il lavoro straordinario che gli veniva richiesto. Di conseguenza, la formazione professionale non svolgeva assolutamente alcun ruolo nelle botteghe.
Ecco perché era naturale che la manifattura rappresentasse un'opportunità insperata per la grande maggioranza delle donne senza qualifica. Ma l'offerta di avere la possibilità di auto-sostenersi si ritorse rapidamente a scapito della donna. Per esempio, durante tutto il periodo della produzione (e dell'industria a domicilio) e' rimasta seduta nella sua casa oscura e affumicata per fornire il mercato mondiale di beni di lusso o di uso corrente. Lavorava giorno e notte sul telaio, cuciva o conciava la pelle. Ciò era la condizione necessaria affinché il suo lavoro potesse competere con le corporazioni monopolistiche - questi aristocratici che detestano il lavoro. Per questo motivo, le operaie a domicilio francesi lottarono duramente per la soppressione delle organizzazioni corporative. Quando queste scomparvero nel 1791, i proletari festeggiarono. L'evento è apparso come il primo passo verso la liberazione economica. Tuttavia, la modifica dei diritti sociali ha portato con sé un nuovo orientamento delle forze produttive. Il monopolio delle corporazioni artigianali aveva spinto le donne a rientrare nella famiglia. Solo con l'uso del vapore, questa eminenza grigia, tornarono alla produzione.
La manifattura si sviluppa tra il XVI e il XVIII secolo. In Russia, Pietro il Grande introdusse la produzione manifatturiera e industriale. Le prime fabbriche russe nacquero nel XVII secolo. Producevano vetro, lana e cotone. Gli imprenditori assumevano in parte servi, in parte lavoratori dipendenti. Nelle fabbriche russe il lavoro femminile era completamente sconosciuto. La donna lavorava in altri settori economici che non la obbligavano ad abbandonare completamente la propria casa. Se non aveva una famiglia, lavorava nelle "case dei padroni" o si rifugiava al convento. In altri paesi, in cui il capitalismo era più radicato, come in Inghilterra, Francia o Olanda, la manifattura inghiotte un numero sempre maggiore di donne. Il periodo della manifattura deve essere considerato un capitolo oscuro nella storia della donna.
Nello stesso tempo in cui si costituiva la classe dei lavoratori salariati o proletari, la donna affrontava una nuova svolta della sua storia e si apprestava a subire una triplice oppressione, assenza di diritti nello Stato e nella società, schiavitù e dipendenza dalla propria famiglia, sfruttamento spietato da parte del capitalista. Il periodo in cui la donna, in quanto artigiana libera e membro della sua corporazione, godeva del rispetto dell'intera società, era definitivamente trascorso. La schiavitù femminile era ancora una volta all'ordine del giorno. Sempre più spesso le donne appartenenti alle classi povere dipendevano economicamente dagli imprenditori intermedi e dai proprietari dei manufatti.
Le onorabili mogli degli artigiani, contadini e commercianti benestanti erano particolarmente disprezzanti nei confronti delle operaie della manifattura, queste volgari "ragazze di fabbrica". Le consideravano rifiuti della società e le paragonavano alle prostitute. Solo la miseria più nera poteva spingere le donne nelle manifatture. Così la vergogna e l'obbrobrio venivano ad aggiungersi alla disgrazia di essere "ragazza di fabbrica".
Com'era possibile? Come si spiega il fatto assurdo che le donne che svolgono compiti domestici improduttivi fossero considerate meglio delle lavoratrici che alla fine lavoravano per aumentare la prosperità della nazione?
Ciò è dovuto al fatto che le donne che andavano in fabbrica appartenevano alla classe degli schiavi salariati al servizio del capitale, quindi al proletariato, disprezzato dal mondo borghese. Situazione che corrisponde esattamente a quella che regnava nell'antica Grecia e in cui i cittadini liberi disprezzavano gli schiavi sottomessi. Sotto il dominio del capitale e sotto il potere della proprietà privata, non si rispettava chi creava oggetti di consumo, ma solo quelli che riuscivano ad accumulare tali oggetti. "Non è stato il lavoratore a produrre ricchezza nazionale con le proprie mani, ma l'imprenditore capitalista con il suo senso di risparmio, la sua perspicacia e la sua abilità. "L'organizzatore" del lavoro raccoglieva il rispetto di tutti. Non dobbiamo tuttavia dimenticare che, all'epoca della manifattura, solo una minoranza di donne lavorava nella produzione. Le donne che erano costrette a vendere la loro forza lavoro e che in questo modo erano sotto gli artigli del capitale non erano ancora un fenomeno tipico. Inoltre speravano di poter reintegrarsi un giorno nella vita normale e gestire la propria casa come le loro contemporanee. Purtroppo, però, questa speranza è stata per la maggior parte delusa. Il metodo di produzione capitalista si rafforzò e si imponeva definitivamente.
All'assenza di diritti nella famiglia e nella società si aggiunge da adesso in poi il dispotismo dell'imprenditore capitalista.
Nel contempo sono emerse le condizioni necessarie per la liberazione definitiva della donna. In effetti la proletaria dovette condividere il triplo destino della classe operaia e iniziò per le donne un nuovo periodo storico che legava indissolubilmente il suo destino a quello della classe operaia stessa. Il suo lavoro, che fino ad allora era stato svalutato, acquisisce un nuovo valore per l'economia nazionale. L'uguaglianza della donna, calpestata nel corso dei secoli, poteva essere riconquistata solo con una lotta comune della classe operaia per i suoi diritti e per il dominio del proletariato. Il modo di produzione comunista, che mobilita tutte le donne al lavoro produttivo, è oggi un fondamento sicuro per la loro liberazione totale e universale futura.
La conferenza di oggi si conclude così.
* * *
ndt:
12) Per nozione di classe consulta il Dizionario enciclopedico marxista su Resistenze.org
13) Per nozione di capitalismo consulta il Dizionario enciclopedico marxista su Resistenze.org
14) Per nozione di manifattura consulta il Dizionario enciclopedico marxista su Resistenze.org
15) Per nozione di capitale finanziario consulta il Dizionario enciclopedico marxista su Resistenze.org
16) Per nozione di mercantilismo consulta il Dizionario enciclopedico marxista su Resistenze.org
Sesta conferenza - Il lavoro femminile nel periodo di espansione della grande industria capitalistica
Nell'ultima conferenza abbiamo affrontato il primo periodo di accumulazione del capitale (ndt 17). E' stata un'epoca di interminabili e sanguinose lotte tra la crescente borghesia e il mondo feudale in declino.
Abbiamo analizzato la situazione della donna in questo periodo transitorio, dall'economia naturale all'economia monetaria, dal lavoro a domicilio alla manifattura. Come ricorderete abbiamo constatato che la maggior parte delle donne, povere e lavoratrici, dopo l'introduzione del lavoro non qualificato, sono migrate verso l'industria. Tuttavia non dobbiamo perdere di vista il fatto che durante il periodo della manifattura e del lavoro a domicilio, la grande maggioranza delle donne non era particolarmente interessata a garantirsi un reddito proprio attraverso il lavoro. Queste donne non svolgevano un lavoro socialmente produttivo. Naturalmente all'epoca il lavoro domestico manteneva un valore importante e completava l'economia nazionale, dato che l'industria era ancora scarsamente sviluppata. Ma di fatto il lavoro domestico non contava per l'economia nazionale. Nonostante questo compito relativamente pesante, la donna non era utile né alla società, né allo Stato. Il suo lavoro serviva solo alla sua famiglia. E il reddito nazionale non si calcolava in funzione del lavoro di ogni membro di questa, ma soltanto in funzione del risultato di questo lavoro, cioè in funzione del reddito globale della famiglia stessa, cosa che la rendeva l'unità di base dell'economia.
In campagna, era uguale; si valutava il lavoro "del padrone di casa", mentre si ometteva completamente di menzionare quello degli altri membri della famiglia. In altre parole, (la famiglia) è considerata un'unità economica indivisibile. E dal momento che il lavoro femminile non era assolutamente significativo per tutta la ricchezza nazionale, la donna rimase come in passato, una serva sottomessa e priva di diritti.
L'avvento della manifattura e del grande capitale non portò alla liberazione della donna, ma piuttosto a nuove forme di oppressione sotto l'aspetto del lavoro salariato al servizio del capitale. Ricordiamo che la manifattura è derivata dal lavoro artigianale a domicilio. Perché lo sviluppo delle forze produttive, grazie allo sfruttamento sotto forma di lavoro a domicilio, ha subito una così forte accelerazione rispetto al ritmo lento di sviluppo del periodo della produzione artigianale? La spiegazione di ciò è relativamente semplice: i lavoratori a domicilio sono stati obbligati ad aumentare la loro produttività più degli artigiani, se non altro per garantirsi il minimo vitale e questo perché dovevano cedere una parte del reddito del loro lavoro all'appaltatore. Gli artigiani consegnavano i loro prodotti direttamente ai loro clienti e quindi ricevevano l'intero plusvalore. Un intermediario, l'imprenditore-acquirente, assicurava il collegamento tra l'operaio a domicilio e la clientela. Con l'espansione del commercio il divario tra il produttore e il mercato è cresciuto, se non altro per ragioni geografiche e l'importanza dell'intermediario, del negoziante o del commerciante è cresciuta di conseguenza. Il plusvalore si divide così tra il produttore e il commerciante, ma sempre a vantaggio di quest'ultimo, poiché quest'ultimo è stato in grado di sfruttare la povertà e la posizione svantaggiata del lavoratore domestico. In questo modo il commerciante raccoglieva una grande somma di denaro e si arricchiva a vista d'occhio, mentre il popolo lavorava sempre di più e diventava sempre più povero. Ma l'aggravarsi dello sfruttamento è andato di pari passo con l'accelerazione di questo processo di impoverimento. Alla fine la totalità dei membri delle famiglie di contadini e di artigiani rovinati - uomini, donne e bambini - furono costretti a vendere la loro forza lavoro (ndt 18) sul mercato.
Fu un'epoca d'oro per i profittatori, cioè i primi produttori e imprenditori della manifattura.
Grazie alla divisione del lavoro la manifattura ha aperto le porte ai lavoratori non qualificati e quando l'imprenditore assumeva produttori inesperti, sceglieva ovviamente la "forza lavoro" che era più economica e conveniente per sé. E quella forza lavoro erano donne e bambini. Tra il XVI e il XVIII secolo possiamo pertanto registrare, parallelamente allo sviluppo delle imprese manifatturiere, una rapida crescita del lavoro femminile. Per l'imprenditore non era tanto la qualità del singolo lavoratore ad essere redditizia (come nel caso della forma di produzione artigianale) quanto il numero dei lavoratori da lui impiegati, cioè la quantità. Egli beneficiava della somma totale delle ore di lavoro non retribuite fornite dai suoi operai e dalle sue operaie. La quantità di ore di lavoro non retribuite aumentava in proporzione al numero di lavoratori e alla durata delle giornate di lavoro, il che andava a tutto vantaggio dell'imprenditore, che si arricchiva senza vergogna.
L'epoca della prima accumulazione del capitale era definitivamente superata e l'umanità stava entrando ad un ritmo folle nel sistema di produzione del grande capitale. Il mondo cambiò aspetto. Già da tempo le città avevano preso il posto dei castelli feudali ed erano diventate i nuovi centri di artigianato e produzione. I principi e i conti cessarono di combattere tra loro per sottomettersi al potere assoluto di un re, mentre le tribù isolate si riunirono per formare nazioni. Come in passato l'agricoltura rimaneva essenziale per l'economia, ma nel corso del tempo il baricentro si spostò a favore dell'impresa industriale, che era diventata la fonte più importante di qualsiasi ricchezza. Alla fine del XIX secolo, paesi come l'Olanda, l'Inghilterra e la Francia - in seguito la Germania, l'Austria e infine la Russia - aderirono uno dopo l'altro alla grande produzione capitalistica.
Noi, figlie di questo secolo del capitale, siamo così abituati a vedere la produzione costruirsi sulla grande impresa capitalistica che ci è difficile immaginare che tutti questi giganteschi laboratori, fabbriche, stabilimenti, che occupano migliaia e migliaia di operai, sono comparsi solo in epoca molto tarda. Infatti il tipo di officine e di fabbriche che conosciamo esiste solo da 150 anni e in Russia da ancora meno. Nel XVI secolo le fabbriche non erano ancora entrate in concorrenza con l'industria a domicilio e la manifattura. Anche in America, dove il capitalismo era altamente sviluppato, si dibatteva ancora a metà del XIX secolo sul fatto se gli Stati Uniti dipendessero per la loro economia dalla grande industria o dall'agricoltura.
Meno di cento anni fa l'umanità ancora non conosceva le regole e le leggi che governano lo sviluppo economico e molti paesi arretrati hanno quindi mantenuto l'illusione di poter proseguire il proprio cammino. Basta guardare la crescita estremamente rapida del capitalismo in paesi come Giappone, Cina e India per poter prevedere con sicurezza che anche in questo caso l'industria su larga scala sostituirà presto il lavoro a domicilio e che le città annetteranno le periferie per soddisfare le loro esigenze.
Le grandi invenzioni scientifiche e tecniche del XIX e XX secolo hanno contribuito in gran parte al successo del sistema capitalista. E mentre ora troviamo difficile immaginare un mondo senza ferrovie, ciminiere, elettricità e telefoni, i nostri antenati da parte loro sarebbero stati molto sorpresi da queste invenzioni, non senza mostrare un certo scetticismo nei loro confronti.
A causa di una serie di invenzioni che migliorano la produttività del lavoro, la produzione capitalistica nel XVIII secolo intraprese un aumento prodigioso. La macchina a vapore di Watt per esempio fu una grande invenzione. Essa pose le basi per la meccanizzazione della produzione nella manifattura e i lavori fin'ora eseguiti dagli uomini, furono d'ora in poi eseguiti dalle macchine. Allo stesso tempo tutte le operazioni di lavoro poterono essere semplificate fino all'estremo e ridotte ad alcuni movimenti manuali elementari. Così il telaio meccanico, la maglieria, la cardatrice e le innumerevoli altre invenzioni si succedettero una dopo l'altra e dalla fine del XVIII secolo, incoraggiarono fortemente lo sviluppo della produzione industriale. Il miglioramento della tecnica è stato un fattore essenziale per ottenere il massimo profitto.
Nel corso degli stati precedenti dello sviluppo la massima produttività fu raggiunta dal lavoro manuale, organizzato nel modo più razionale. Per aumentare i suoi profitti l'imprenditore cercò di modificare i principi che erano alla base della manifattura. Il profitto massimo non dipendeva più esclusivamente dal numero di operai che lavoravano in fabbrica, ma anche dalle macchine. La tecnica aumentava la produttività in modi che in passato sarebbero stati impensabili: invece di una bobina, l'operaia poteva avvolgerne e arrotolarne fino a 1.200 a macchina. Una bobinatrice che fino ad ora era riuscita a montare solo poche bobine al giorno, era in grado di produrne quasi un centinaio. Una singola operaia che produceva 600.000 aghi al giorno alla macchina, sostituiva 135 lavoratrici. Grazie alla macchina per la lavorazione a maglia, la resa di un'operaia è passata da 20 a 1200 paia. Le macchine sostituivano una forma di lavoro manuale dopo l'altra. La produttività è aumentata in modo prodigioso e il mercato è stato presto invaso da prodotti fabbricati in modo meccanico e destinati al consumo in massa. Il ritmo di produzione, lo stoccaggio e la ricchezza degli imprenditori, dei padroni e dei baroni industriali è cresciuto in modo sproporzionato.
Tuttavia l'aumento della produttività del lavoro attraverso i macchinari non ha migliorato il tenore di vita dei lavoratori. Al contrario la loro schiavitù e il loro sfruttamento da parte del capitale diventarono ancora più grandi. Naturalmente la meccanizzazione della produzione (ndt 19) avrebbe potuto migliorare la situazione dell'intera popolazione, se ad esempio un'operaia che in precedenza realizzava 20 calze al giorno e che ora con l'aiuto della macchina ne produceva 60 volte di più, fosse stata effettivamente pagata per le 1.200 paia di calze che aveva prodotto. Non dobbiamo dimenticare che l'umanità viveva in un mondo in cui la proprietà privata era profondamente radicata. Il capitalista considerava la macchina che aveva comprato come parte della sua azienda, parte del suo inventario. Quando assumeva un operaio questo era obbligato ad usare gli strumenti da lavoro che erano messi a sua disposizione. L'imprenditore avrebbe fatto un buon affare se fosse stato in grado di procurarsi un dispositivo che fosse riuscito ad aumentare di sei volte la produttività del suo lavoratore. Il padrone non pagava l'operaio in base alla sua produttività, ma sulla base della propria forza lavoro. Era quindi nel suo interesse sfruttare al massimo la forza lavoro che aveva comperato. Questo è il motivo per cui la meccanizzazione della produzione, che ha aumentato drasticamente la produttività degli schiavi salariati, uomini e donne, non ha portato ad un miglioramento delle loro condizioni di vita, ma piuttosto al loro peggioramento. La meccanizzazione ispirò gli economisti e gli imprenditori della borghesia e li condusse all'idea "brillante" che la forza lavoro viva dell'uomo non fosse in alcun modo indispensabile per la produzione e la creazione di ogni ricchezza, mentre la forza morta e meccanica della macchina era assolutamente indispensabile. Se un imprenditore possedeva dei macchinari, sapeva perfettamente che sarebbe stato facile per lui procurarsi manodopera. Ma se invece, non avesse avuto le attrezzature necessarie, non avrebbe avuto alcuna possibilità di competere sul mercato con il solo vantaggio ottenuto dalla forza lavoro viva di cui disponeva. Per questo il capitalista si è abituato a considerare la manodopera come accessoria e complementare alle macchine.
Vi ricordate che avevamo già constatato che il lavoro della donna non aveva alcun valore per le tribù dei pastori nomadi? Il gregge (o la mandria) era considerata la principale fonte di ricchezza per la tribù e la donna che la governava era considerata come accessorio e senza valore. La stessa cosa accadde con la meccanizzazione delle fabbriche: il lavoro si svalorizzò. Nonostante l'introduzione dei macchinari gli operai e le operaie non migliorarono in alcun modo il loro reddito. Al contrario, il tenore di vita della classe operaia continuava a diminuire e l'imprenditore che possedeva le macchine era l'unico a beneficiare della straordinaria crescita dei profitti.
Lo sviluppo della grande industria ha portato da un lato una maggiore accumulazione di capitale e dall'altro una maggiore concorrenza tra gli imprenditori stessi. In definitiva ogni industriale cercava di ottenere il massimo profitto. Per questo motivo ha aumentato il suo fatturato, ha sommerso il mercato dei suoi prodotti vendendoli a prezzi inferiori rispetto ai concorrenti che non erano ancora riusciti a dotarsi delle macchine più moderne. I piccoli imprenditori e soprattutto gli artigiani, fallirono e furono costretti a chiedere lavoro ai grandi industriali che erano responsabili della loro rovina. La concentrazione del capitale, vale a dire l'accumulo dei mezzi di produzione nelle mani dei grandi industriali che si arricchirono molto rapidamente e l'impoverimento degli operai sono i due più importanti processi che caratterizzano lo sviluppo delle grandi imprese capitaliste verso la fine del XIX secolo. Nel XX secolo i capitalisti, per lottare efficacemente contro la cieca concorrenza, costituirono un nuovo potere: l'associazione di molti imprenditori, cioè i trust. La lotta tra lavoro e capitale si intensificò.
L'impoverimento e il fallimento dei piccoli imprenditori travolse il mercato del lavoro con una manodopera a basso costo. La voracità del grande proprietario terriero, le tasse troppo pesanti e il sottosviluppo dell'agricoltura, cacciarono i contadini dalle loro terre. Questo esodo rurale ha ulteriormente aumentato il numero dei disoccupati. La disoccupazione assunse proporzioni così allarmanti nel XIX secolo che diede origine ad una scuola teorica di un tipo speciale, il malthusianismo. Malthus predicava il controllo delle nascite della classe operaia per tentare di arginare così l'afflusso di nuovi lavoratori sul mercato del lavoro. Ciò avrebbe comportato un indebolimento della concorrenza e condotto a migliorare la situazione della classe operaia stessa. Ma questa teoria non ha naturalmente trovato alcuna eco. È tuttavia esemplare nella misura in cui ci mostra a quale punto le idee degli uomini sono dipendenti dalla loro situazione economica. Al tempo dell'economia naturale e della manifattura, quando il successo economico dipendeva al massimo dal numero di lavoratori disponibili, una grande famiglia era considerata un "dono del cielo ". Più braccia c'erano, più ricchezza c'era. La produzione meccanica fu all'origine della concezione che le macchine erano creatrici di ogni ricchezza. Pertanto l'intenzione era di eliminare il lavoro manuale riducendo la prole del lavoratore. Questa teoria è profondamente reazionaria e d'altra parte completamente sbagliata e da tempo confutata dalla storia stessa. E' proprio il pericolo opposto che ci minaccia oggi: la mancanza di lavoratori è attualmente una minaccia per l'ulteriore sviluppo della forza lavoro ed è per questo che la limitazione delle nascite non può in nessun caso essere la preoccupazione degli uomini. Al contrario, ora si tratta di stimolarle.
Passiamo ora ad un'analisi più approfondita del lavoro nella produzione industriale. Il mercato del lavoro è stato quindi, come abbiamo già detto, costantemente sommerso da lavoratori disponibili. Dal XVIII secolo ci siamo anche noi, tra i disoccupati, un numero crescente di donne. Queste cercavano di vendere l'unica cosa che possedevano - la loro forza lavoro - all'imprenditore. E se quest'ultimo si fosse rifiutato di assumerle? C'era solo una soluzione: la prostituzione. Ecco perché la prostituzione femminile seguiva il lavoro salariato come un'ombra. L'aumento della curva di questo tipo di commercio basata sul corpo della donna è andata di pari passo con la normalizzazione del lavoro salariato per le donne.
La vita quotidiana delle lavoratrici al tempo del declino dell'artigianato e della manifattura era assolutamente priva di gioia e di diritti e il lavoro che svolgevano era particolarmente faticoso. Erano la preda designata delle truffe dei potenti. E le sofferenze che sopportavano nell'inferno della fabbrica hanno superato in intensità quelle dei secoli precedenti. Basta studiare il libro di Engels: la situazione della classe operaia in Inghilterra, per rendervene conto. Anche se è stato scritto nel 1840, molte delle condizioni descritte in questo libro non sono ancora state eliminate nei paesi capitalisti. Possiamo riassumere la vita dell'operaio della fabbrica nella prima metà del XIX secolo come segue: una giornata lavorativa interminabile, di solito superiore a dodici ore, salari bassi, abitazioni malsane - gli uomini vivevano in stretta promiscuità, stoccati come animali - senza nessuna protezione del lavoro o assicurazione sociale, un aumento delle malattie professionali, alti tassi di mortalità e costante paura della disoccupazione. Queste sono dunque le condizioni di vita e di lavoro della classe operaia prima che cominciasse ad organizzarsi all'interno del partito e dei sindacati per difendere i propri interessi di classe.
I padroni preferivano assumere le donne perché erano pagate meno degli uomini. I produttori semplicemente affermavano che il lavoro femminile non è qualitativamente paragonabile al lavoro maschile. Gli ideologi borghesi, inoltre, hanno prontamente fornito loro le argomentazioni desiderate, affermando spudoratamente che le donne erano per natura inferiori agli uomini in tutti i campi. Tuttavia, le cause della sottovalutazione del lavoro femminile fino ad oggi non sono affatto di natura biologica e devono essere ricercate piuttosto sul piano sociale.
Nella prima metà del XIX secolo la maggior parte delle donne non lavorava nella produzione per il mercato mondiale, ma come in passato, in casa, ad occuparsi di compiti improduttivi, il che consentiva di concludere erroneamente che il lavoro femminile sarebbe stato meno produttivo. Il fatto che, nella valutazione del reddito da lavoro, si tenga conto degli obblighi del marito di provvedere alla sua famiglia, ha contribuito a sottopagare la manodopera femminile. Non appena il salario non garantiva più il minimo vitale della famiglia operaia, si assisteva o alla massiccia disaffezione degli operai di questo ramo della produzione o al calo della qualità di vita per questi operai e le loro famiglie. Fu allora che donne e bambini furono costretti al lavoro salariato. Ma, poiché il suo mantenimento è rimasto responsabilità di suo marito - il capofamiglia - la moglie lavorava "occasionalmente" per migliorare il bilancio familiare. In breve, il suo lavoro è stato considerato solo come un lavoro secondario e complementare.
Naturalmente gli imprenditori non hanno avuto difficoltà a sostenere e incoraggiare questo concetto condiviso dagli stessi operai, che non avevano ancora capito dove si trovassero i loro veri interessi. Gli operai non si rendevano conto da un giorno all'altro che il lavoro femminile era ormai inseparabile dall'economia capitalistica. Essi compresero solo molto lentamente che le donne che lavoravano in modo produttivo nella grande industria non sarebbero mai tornate ai loro fornelli e che avevano definitivamente abbandonato la casa e il lavoro domestico. Durante tutto il XIX secolo, il lavoro femminile era estremamente sottovalutato rispetto al lavoro maschile, nonostante il numero di donne impegnate in attività professionali fosse in costante aumento e il loro salario sufficiente a sostenere i figli, i genitori anziani e talvolta anche il marito, disoccupato e malato. Tali anomalie continuano ad esistere negli attuali Stati capitalisti, nonostante l'attività dei sindacati su questo tema che chiede invano un salario uguale per un lavoro uguale senza discriminazione di sesso.
Tuttavia, la mancanza di qualifiche lavorative della donna contribuì anche al suo sfruttamento, soprattutto prima del 1850. In passato solo una piccola minoranza di donne aveva praticato un mestiere che ne garantiva il mantenimento. Senza transizione, la maggior parte delle donne in cerca di lavoro ha dovuto entrare nelle aziende manifatturiere. Non avevano, naturalmente, una formazione professionale o professioni alternative. E poiché soffrivano la fame e la miseria, poiché non avevano mai conosciuto un'esistenza autonoma ed inoltre, essendo abituate da millenni ad una cieca obbedienza, accettavano senza esitazione le peggiori condizioni di lavoro. Nonostante le teorie degli imprenditori sulla naturale inferiorità delle donne rispetto agli uomini, non hanno esitato a gettare per strada i lavoratori maschi e ad assumere le donne che avrebbero pagato meno. L'accumulo di profitti non soffriva affatto di questo tipo di operazioni. Possiamo quindi concludere che il lavoro femminile, in termini di produttività, non ha in alcun modo ceduto al lavoro maschile. Con lo sviluppo della produzione meccanica, la qualificazione del lavoro diventa sempre più priva di significato. In particolari settori di produzione (tessile, industria del tabacco, chimico, ecc.), il lavoro femminile non qualificato aveva assunto proporzioni tali da essere percepito dagli operai come una minaccia diretta. Non solo le donne hanno cacciato gli uomini dai laboratori vendendo a buon mercato la loro forza di lavoro, ma hanno anche offerto agli imprenditori l'opportunità di ridurre globalmente i salari. E più donne erano occupate in un'industria, più basso era il salario degli uomini. Ma man mano che crollavano i salari degli uomini, le donne - le figlie e le mogli dei proletari - erano costrette a cercare altro lavoro supplementare e ad impegnarsi nella produzione. Era nato un circolo vizioso.
Solo nella seconda metà del XIX secolo la classe operaia tentò di spezzare questo circolo impegnandosi in lotte politiche e sindacali. La coscienza di classe degli operai ha mostrato chiaramente agli uomini che le operaie non erano semplicemente "concorrenti dannose ", ma che anche loro appartenevano alla classe operaia. Ed era solo organizzandosi insieme che il proletariato poteva respingere le aggressioni sempre più sanguinose del capitale contro la classe operaia. Nella prima metà del XIX secolo, l'operaio affrontò la sua rivale sul mercato del lavoro con disgusto e ostilità. Le organizzazioni, destinate a difendere gli interessi di tutto il proletariato, vietarono generalmente il loro accesso a membri femminili.
Alla fine del XIX secolo, i salari delle lavoratrici non superavano nella maggior parte dei casi la metà dei salari dei loro colleghi maschi. Solo all'inizio del XX secolo i primi tentativi di riadattamento e di equiparazione dei salari dei lavoratori apparvero negli Stati capitalisti più sviluppati e sotto la forte pressione dei sindacati. Tuttavia, in Russia, alla vigilia della Rivoluzione, la donna guadagnava ancora solo due terzi o addirittura un terzo di quanto toccava all'operaio. E la donna continua a lavorare in queste condizioni in Asia, in Giappone, India e Cina.
Le condizioni di vita delle operaie nel periodo di sviluppo del capitalismo industriale sono state caratterizzate da un lato, da salari da miseria e dall'altro da condizioni di lavoro particolarmente insalubri che hanno provocato gravi danni al corpo e alla salute della donna (aborti, bambini nati morti e tutta una serie di malattie femminili). Mentre le prospettive per il futuro del capitalismo si annunciavano radiose, quelle del proletariato si oscuravano e la vita della donna divenne sempre più insopportabile (ndt 20). Ma il lavoro produttivo al di fuori della casa, che crea ricchezza per l'intera società e quindi riconosciuto dall'economia nazionale, è stato comunque la forza che ha spianato la strada alla liberazione della donna.
Sappiamo che la situazione della donna nella società è determinata dal suo ruolo nella produzione.
Finché la maggior parte delle donne è rimasta a casa, occupata da compiti improduttivi per tutta la società, tutti i tentativi e le iniziative delle donne di raggiungere la libertà e l'uguaglianza sono stati condannati al fallimento. Questi tentativi non avevano alcuna base nell'economia. Eppure la produzione industriale nelle fabbriche, che inghiottiva migliaia di operai, modificò in modo significativo l'ordine delle cose. Da allora in poi il lavoro domestico passò in secondo piano e il lavoro della donna fuori della casa, che fino ad ora aveva assunto un carattere secondario, divenne la regola, in breve, una condizione normale e necessaria.
Il XX secolo segnò una svolta nella storia della donna. All'inizio del XIX secolo le donne, costrette a lavorare come "ragazze operaie", sperimentarono questa situazione come una catastrofe personale - ma, dalla fine del XIX secolo e soprattutto nel XX secolo, il 30-45% delle donne negli stati capitalisti lavoravano. All'epoca della manifattura, le donne lavoratrici erano essenzialmente vedove, donne sole o donne abbandonate dai loro mariti. Nel XIX secolo, quasi la metà delle lavoratrici erano sposate. Perché?
Naturalmente il salario del marito non era più sufficiente per coprire le esigenze della famiglia. La sicurezza del mantenimento che il matrimonio dava alla donna, era finalmente finita. Per sfamare le loro famiglie, sia gli uomini che le donne hanno dovuto mettersi al lavoro. L'uomo non era più l'unico capofamiglia; era spesso la donna che doveva sostenerla, soprattutto in tempi di crisi o durante i lunghi periodi di disoccupazione del marito. Nelle famiglie della classe operaia non era raro che la donna andasse al lavoro e l'uomo restasse a casa a prendersi cura dei bambini e a fare i lavori di casa. Queste condizioni erano temporaneamente comuni nelle regioni tessili degli Stati Uniti. In alcune città, gli industriali preferivano assumere manodopera a buon mercato, così accadeva che la donna lavorasse in una fabbrica di tessitura, per esempio, mentre l'uomo rimaneva a casa. Queste piccole città venivano periodicamente chiamate "she towns" (città delle donne). Nel corso del tempo, il riconoscimento generale del lavoro femminile costrinse tutta la classe operaia a rivedere la propria posizione nei confronti delle donne e ad accettarle come compagne di lotta e membri a pieno titolo nelle loro organizzazioni proletarie.
Nella seconda metà del XIX secolo, il lavoro femminile si sviluppa notevolmente. Tra il 1871 e il 1901, nel settore industriale in Inghilterra ad esempio, la percentuale di uomini è aumentata del 23%, e la quota delle donne del 25 %. Allo stesso tempo le donne fanno la parte del leone per quel che riguarda il tasso di crescita della classe operaia inglese nel suo complesso: il gruppo delle operaie è cresciuto del 21%, mentre il gruppo degli operai è cresciuto solo del 8%. Nel 1901 il 34% delle donne francesi erano occupate e nel 1906 erano il 39%. Nel 1881 il numero di lavoratrici tedesche era stimato a 5,5 milioni, dal 1890 al 1895 a 6,5 milioni e nel 1907 a 9,5 milioni. Durante la Prima guerra mondiale, in Germania vi erano oltre 10 milioni di donne che lavoravano. Ancora in Germania, nel 1882, il 23% delle donne lavorava nella produzione e nel 1907 tale percentuale era pari a 30. Durante la Prima guerra imperialista mondiale, il 30% delle donne lavorava nell'industria (prima della guerra il lavoro femminile era dominante in soli 17 settori industriali, durante la guerra in 30 rami industriali). In Russia, il numero di donne impegnate in una professione è aumentato di venti volte durante la Prima guerra mondiale. Se si calcola che in Europa e negli Stati Uniti il numero delle donne lavoratrici è di 60 milioni prima della Prima guerra mondiale, si può, senza esagerare, portarlo oggi a 70 milioni. A ciò si aggiunge un numero crescente di donne lavoratrici in Asia, che attualmente vive una forte industrializzazione.
Su 2 milioni di proletari giapponesi, si contano 750 000 operaie e i recenti censimenti in India ci dicono che le donne sono impiegate nelle fabbriche, nella metallurgia, nel lavoro domestico, nell'agricoltura e nelle piantagioni di tè, caffè e cotone. In Cina, si stima approssimativamente che 10 milioni di donne lavorino nelle fabbriche o a casa o nei servizi pubblici o privati. I paesi occidentali ora si uniscono ai paesi in via di sviluppo orientali e incontriamo così ovunque la donna lavoratrice e l'uomo che lavora fianco a fianco. L'economia capitalistica del mondo non può più fare a meno della partecipazione delle donne, il che significa che le donne sono state definitivamente riconosciute come forza lavoro.
Quasi la metà di queste donne sono sposate. Questo fatto è di particolare interesse per noi perché spazza via il vecchio pregiudizio che le donne una volta sposate possano rinunciare a guadagnarsi da vivere. In Germania, Inghilterra e Russia, il numero di donne sposate raggiunge un terzo di tutte le donne che lavorano. Nelle fasi più avanzate dello sviluppo del capitale quindi, la donna non è più solo un complemento vivente e un'appendice del marito. Ha cessato di occuparsi del solo lavoro domestico improduttivo ed è per questo che si può prevedere la fine della sua millenaria schiavitù.
Cosa spinge le donne nelle fabbriche e nelle officine? Chi di voi può rispondere alla mia domanda? La donna lavora volontariamente in fabbrica o al servizio di estranei o è una forza sociale aliena che l'ha spinta a farlo?
Studentessa: Il lavoro dell'operaio era sempre più mal pagato, quindi non era più in grado di mantenere da solo la sua famiglia.
Kollontaj: Hai assolutamente ragione. Nel periodo della produzione meccanica il fatto che l'operaio potesse avere una famiglia a carico non viene più preso in considerazione nel calcolo del suo salario. Il padrone non si preoccupa minimamente delle condizioni in cui i figli del lavoratore sono condannati a vivere. Il progresso tecnico gli permette in ogni momento di disporre di una quantità sufficiente di disoccupati e se il salario non è sufficiente per nutrire il lavoratore, sua moglie deve solo mettersi al lavoro. Le statistiche mostrano che il 90% delle operaie maritate è andata in fabbrica costretta dalla povertà e dalla miseria più totale. Pertanto, queste migliaia di donne lavoratrici non hanno venduto volontariamente la loro forza lavoro, ma sono state costrette a farlo per necessità.
Il lavoro nelle fabbriche e nelle officine, faticoso e spesso pericoloso per l'organismo femminile, ha creato un problema nuovo che non era mai esistito fino ad allora: il problema della maternità. In altre parole: la maternità è compatibile con il lavoro subordinato al servizio del capitale?
La maternità e la professione, ossia la partecipazione della donna al lavoro produttivo, sono di fatto incompatibili nel sistema capitalista. La famiglia dell'operaio si dissolve, i bambini vengono lasciati a loro stessi e la casa viene trascurata. Inoltre, la donna non è una madre sana se lavora in un settore di produzione in cui regnano condizioni di lavoro malsane, si nutre male, non esiste protezione materna e le condizioni di vita sono comunque estremamente miserabili. Gli aborti e i bambini nati morti all'epoca erano molti. La mortalità dei lattanti nelle città industriali raggiunge il 30-50% e in mansioni particolarmente pericolose, come la preparazione della biacca di piombo o del mercurio, supera addirittura il 60%.
Se il capitalismo avesse potuto continuare a progredire in tutta tranquillità, cioè se la classe operaia non avesse conquistato il potere e il controllo sulla produzione, l'umanità sarebbe stata presto minacciata da una vera e propria degenerazione. Per fortuna il proletariato ha tratto dalla storia le giuste conclusioni per condurre la propria azione. La vittoria della Rivoluzione russa apre la strada - anche negli altri paesi - alla rivoluzione sociale. La pianificazione basata sui principi comunisti ha già offerto all'umanità la possibilità di risolvere i problemi della maternità. Nella società comunista, la forza vivente del lavoro e quindi anche quella delle lavoratrici, viene utilizzata in modo produttivo e nell'interesse della società. Ecco perché la nostra società protegge le donne incinte e quelle che allattano i loro figli e garantisce loro un tenore di vita che consenta di dedicarsi in modo soddisfacente ad altri compiti sociali.
Tuttavia la popolazione nei paesi capitalisti continua a vivere sotto il giogo del capitalismo e la maternità grava pesantemente sulle spalle della donna, che per di più è schiacciata dal doppio onere del suo lavoro e dalle cure alla famiglia. Il reddito dell'operaio migliorerà un giorno in modo da liberare la donna sposata dall'obbligo di guadagnare? Certo che no! Gli aumenti salariali degli operai e delle loro organizzazioni sindacali restano in costante disallineamento con gli aumenti dei prezzi degli oggetti di consumo corrente. Anche se la classe operaia riuscisse a far valere le sue richieste, ossia a bloccare l'aumento dei prezzi - il che sarebbe una vittoria incontestabile - il problema non sarebbe sostanzialmente risolto. Non dobbiamo dimenticare che anche le esigenze della famiglia lavoratrice sono in continuo aumento. Infatti, non basta allontanare la povertà per porre fine alla necessità del lavoro subordinato della donna perché nascono anche altre esigenze, come le rivendicazioni di carattere culturale dell'operaio e dell'operaia che reclamano una migliore istruzione e formazione per i loro figli, vogliono comprare qualche volta un libro o andare a teatro. Questo costringe ancora una volta le donne a un lavoro salariato.
Un altro fattore è la crescente domanda di manodopera femminile da parte della produzione in rapida espansione, che impedisce effettivamente l'applicazione delle leggi volte a limitare il lavoro femminile. La guerra ha dimostrato chiaramente alla società che non può più fare a meno delle donne. Nessuna legge o altro intervento statale può più obbligare le donne a tornare a casa. Non è più possibile tornare alla famiglia. (Una soluzione simile è stata ancora presa in seria considerazione circa cinquant'anni fa da scienziati borghesi, peraltro appoggiati da circoli proletari) E cosa può ancora fare la donna in famiglia, quando la maggior parte delle sue funzioni tradizionali sono state affidate da tempo a istituzioni esterne alla famiglia stessa?
Nel caso in cui vi interessasse di più la situazione delle donne che esercitano un'attività professionale, vi consiglio il capitolo "La professione e la maternità" nel mio libro Società e Maternità (ndt 21). In questo libro ho descritto in dettaglio le reazioni ostili al lavoro della donna all'interno del proletariato stesso. Inoltre, il libro contiene anche statistiche sulle donne sposate che esercitano una professione nei diversi paesi interessati.
Nella nostra discussione affronteremo ora un'altra questione, una questione di importanza cruciale per la valutazione del lavoro femminile nel capitalismo. Quali sono i rami di attività che occupano la maggior parte delle donne? Attualmente e soprattutto dopo la Prima guerra mondiale, le donne sono ovunque. Il lavoro femminile non ha solo guadagnato terreno nell'industria e nell'agricoltura, ma anche nei trasporti e nell'intera amministrazione, sia municipale che statale. Fin dal Medioevo le donne hanno sempre lavorato nel commercio, soprattutto piccolo commercio. In generale, tuttavia, si può dire che il lavoro delle donne in questi settori è dovuto principalmente al basso livello di qualificazione della loro forza lavoro o a qualifiche legate al loro precedente lavoro nell'economia domestica. Troviamo la maggior parte delle donne nell'industria tessile, del tabacco e della chimica, ma anche nel commercio, in altre parole in settori che richiedono qualifiche professionali relativamente basse.
In molti paesi - in Russia, Inghilterra, Germania e Giappone-ci sono più lavoratrici che lavoratori maschi nei rami di produzione che si sono sviluppati relativamente tardi a partire dal lavoro domestico e che sono, tra gli altri, il confezionamento di tessuti e indumenti, la produzione alimentare, il lavoro domestico in senso stretto, il lavoro nelle lavanderie, nei ristoranti e nei caffè. Il fatto che una donna non sappia cucire, stirare o apparecchiare la tavola è estremamente insolito. In questi settori, la formazione professionale è semplicemente sostituita dall'esperienza pratica. Tuttavia è notevole che, con l'introduzione della meccanizzazione del lavoro in settori precedentemente riservati alle donne (lavanderie elettrificate o a vapore, fabbriche di abbigliamento, ecc.), la forza lavoro femminile tenda ad essere sostituita dalla forza lavoro maschile. La forza lavoro viene ridistribuita. Gli uomini si introducono in settori tradizionalmente femminili, mentre le donne abbracciano professioni che passavano fin qui per essere maschili. Questa ridistribuzione ha un'unica causa: la meccanizzazione della produzione. L'uomo ha adottato la macchina da cucire elettrica e il ferro da stiro. La donna il tornio e il crivello. La meccanizzazione del lavoro da parte della macchina raggiunge il suo completamento. Questa meccanizzazione della produzione porta alla parità di condizioni tra uomini e donne, che a sua volta porta al riconoscimento della parità sociale tra uomini e donne. Il numero di donne che lavorano nel settore delle comunicazioni è aumentato considerevolmente negli ultimi due decenni. Questo lavoro richiede una formazione professionale, così come il lavoro d'ufficio. Tuttavia, questi ultimi due settori professionali sono presi d'assalto da parte delle donne. Il fatto che la donna si avventuri in settori che richiedono una formazione professionale più elevata è una prova certa della necessità di lavorare per la donna nella produzione.
La donna ha imparato a considerare il suo lavoro come necessario e non più come superfluo. Ha smesso di illudersi. Per il suo futuro, non si affida più al matrimonio, ma al suo lavoro. Per questo i genitori oggi cercano di dare ai figli e alle figlie - soprattutto nei paesi capitalisti avanzati - una formazione professionale adeguata. Grazie a questo, i loro figli potranno essere in grado di guadagnare più facilmente la loro vita. Nel XIX secolo quindi, il lavoro della donna ha perso il suo carattere casuale ed è finito per imporsi ovunque. La guerra mondiale ha portato a termine questa evoluzione, poiché ha tolto alle donne la loro ultima illusione, in questo caso la possibilità di reintegrarsi un giorno alla casa per occuparsi esclusivamente della propria famiglia.
Riassumeremo per l'ultima volta la nostra conferenza di oggi. Abbiamo analizzato il destino delle donne nella storia. Il cerchio si chiude nel XX secolo. In un periodo molto remoto la donna era a fianco degli uomini e godeva degli stessi loro diritti in quanto produttrice di beni di consumo per tutta la comunità. Era particolarmente rispettata non solo perché svolgeva i suoi doveri in relazione alla società lavorando, ma anche perché metteva al mondo i bambini assicurando così la perpetuazione del clan. Il suo significato per la comunità primitiva era quindi più importante di quello dell'uomo. La divisione del lavoro e la proprietà privata tuttavia hanno incatenato la donna alla propria casa facendola così diventare complemento e appendice del marito. Ma queste stesse forze produttive, che a un certo punto avevano consentito la divisione del lavoro tra i sessi e l'introduzione della proprietà privata, portarono in seguito la possibilità di una liberazione totale e universale delle donne. Attraverso la partecipazione alla produzione sono state gettate le basi della loro liberazione in tutti i settori sociali. Ma è solo nel nuovo ordine economico e sociale, il comunismo (ndt 22), che questa liberazione può trovare la sua applicazione pratica.
* * *
ndt:
17) Per nozione di accumulazione del capitale consulta il Dizionario enciclopedico marxista su Resistenze.org
18) Per nozione di forza lavoro consulta il Dizionario enciclopedico marxista su Resistenze.org
19) Per nozione di meccanizzazione della produzione consulta il Dizionario enciclopedico marxista su Resistenze.org
20) si approfondisca con "200 Engels. Engels e l'emancipazione femminile", Brinda Karat
Traduzione per Resistenze.org a cura del Centro di Cultura e Documentazione Popolare
21) 1913
22) Per nozione di comunismo consulta il Dizionario enciclopedico marxista su Resistenze.org
Settima conferenza - Le origini della "questione femminile"
Nella nostra ultima conferenza eravamo giunti alle seguenti conclusioni: mentre aumentavano le forze produttive e si imponeva la produzione delle grandi industrie capitaliste, aumentava anche il numero delle donne lavoratrici. Oggi stiamo constatando come, nell'ambito del sistema capitalista, la donna non sarà mai in grado di ottenere la totale liberazione, né la completa uguaglianza di diritti, indipendentemente dalla sua partecipazione - attiva o no - alla produzione.
E' infatti tutto il contrario! Rimane la contraddizione insormontabile tra il suo significato economico e la sua dipendenza, la sua condizione senza diritti nella famiglia, nello Stato e nella società. Esamineremo ora in modo più dettagliato come la consapevolezza della necessità di pari diritti e dignità della donna sia riuscita a imporsi nella società, mentre dimostreremo come questo processo sia collegato al rapido progredire del lavoro della donna .
Non ci sarà difficile riconoscere che le donne, lavorando nella produzione e diventando economicamente indipendenti, hanno reagito con una crescente amarezza per la loro esistenza di second'ordine - tanto nella famiglia, che nella società. Qualsiasi osservatore libero da pregiudizi può constatare facilmente che esiste una contraddizione palese tra il riconoscimento della donna come forza lavoro socialmente utile e la sua discriminazione da parte della legislazione borghese. Questa contraddizione tra il significato del lavoro della donna per la produzione da un lato e la sua assenza di diritti da un punto di vista politico e sociale dall'altro, nonché la sua subordinazione al marito che ha da tempo cessato di provvedere i suoi bisogni, questa contraddizione, dunque, la dobbiamo originariamente alla nascita della cosiddetta "questione femminile" (ndt 23).
"La questione femminile" fu posta con particolare veemenza nella la seconda metà del secolo scorso, anche se abbiamo già visto che inizia in un periodo chiaramente precedente. La troviamo già quando la concorrenza della manifattura spinse verso il fallimento i piccoli artigiani e i lavoratori a domicilio, costringendoli a vendere la propria forza lavoro alle grandi industrie insieme a quella delle loro mogli e dei loro bambini. Alla fine della XVIII° secolo e all'inizio del XIX° secolo, "la questione femminile" si concentrò tuttavia principalmente sul salario delle donne e il loro diritto "a un lavoro dignitoso". In tre secoli le corporazioni con i loro privilegi e la severità dei loro decreti, fecero in modo che la donna si trovasse esclusa dai mestieri artigianali. Le corporazioni tentarono di relegarla per sempre ai suoi fornelli, ciò voleva dire che la donna doveva ritirarsi dalla produzione e abbandonare questa all'uomo. Questo ha naturalmente portato ad un peggioramento della situazione della donna. Da quando perse la possibilità di esercitare una professione artigianale, è diventata più facilmente preda del fabbricante e vittima della sua politica di sfruttamento.
A quel tempo in Francia il sistema della manifattura era dominante nella produzione. Ma le fabbriche, solo eccezionalmente erano grandi abbastanza per essere chiamate imprese industriali, con più di un centinaio di lavoratori. Il lavoro a domicilio e la manifattura erano fiorenti e si diffusero in tutta la Francia. Piccole imprese manifatturiere che contavano da dieci ai venti operai si moltiplicarono come funghi nella regione parigina e nelle altre città francesi. In queste manifatture si preparavano dai tessuti e teli grezzi e grossolani fino ai più raffinati merletti, ma anche articoli in oro o in metallo, così come tutti i tipi di oggetti di uso quotidiano. Molte donne lavoravano nella tessitura e nella filatura. Rappresentavano spesso fino al 90% della forza lavoro totale occupata in questo settore. In Francia la lavorazione della seta era quasi entrata nella produzione industriale. In questo campo la fabbrica aveva prevalso sull'industria domestica e sulla produzione. Alla vigilia della Rivoluzione francese, il proletariato femminile si era considerevolmente sviluppato e i sobborghi di Parigi erano sommersi da mendicanti e prostitute e da una moltitudine di donne senza lavoro che soffriva per la miseria e per la fame. Non sorprende dunque che, in occasione delle sommosse del luglio 1789, le donne si siano impegnate in modo particolarmente tumultuoso contro la dominazione e lo sfruttamento dei ricchi. "Le donne del popolo" di Parigi rivendicavano costantemente nelle loro parole d'ordine e nelle loro petizioni, il diritto al lavoro e la promessa di poter "guadagnarsi da vivere onestamente". Rivendicavano inoltre il diritto di lavorare per uomini e donne, nonché il divieto per l'uomo di lavorare in attività tipicamente femminili, impegnandosi al tempo stesso ad astenersi dal cercare lavoro in settori specificamente maschili. "Se siamo alla ricerca di lavoro, non è per liberarci dagli uomini, ma per costruirci un'esistenza nostra in un quadro modesto", diceva una di queste petizioni. (ndt 24)
Durante la Rivoluzione francese le donne del terzo stato chiedevano il libero accesso a tutte le professioni artigianali o in altre parole, "la libertà illimitata di lavorare". Queste rivendicazioni dovevano permettere a decine di migliaia di donne che soffrivano per la miseria e la fame, di sfuggire alla povertà e alla prostituzione. Non erano rivendicazioni soltanto femminili, erano proprie degli interessi dell'insieme del proletariato industriale francese. Gli abitanti dei sobborghi di Parigi manifestavano e gridavano insieme: "Libertà di lavoro!" Libertà di lavoro significava chiaramente l'eliminazione definitiva del feudalesimo, il consolidamento e la predominanza della borghesia e la liquidazione dei privilegi delle corporazioni. Il loro interesse di classe indicò ai francesi la migliore via da seguire, se avessero davvero avuto un giorno la possibilità di guadagnarsi "onestamente il pane". Le donne del proletariato francese stavano innegabilmente dalla parte della Rivoluzione.
Per descrivere coscienziosamente il ruolo e le attività della donna nella Rivoluzione francese, la sua risoluzione eroica e la sua lotta rivoluzionaria, un libro intero senza dubbio non basterebbe. "Le donne del popolo" nelle province di Dauphiné e della Bretagna furono le prime ad attaccare la monarchia. Seguite dalle donne d'Angoulême e di Chenonceaux.. Parteciparono alle elezioni dei deputati per gli Stati Generali e il loro voto fu all'unanimità riconosciuto. Abbiamo già osservato che la classe borghese, in tempi di guerre civili o nazionali, accettava volentieri l'aiuto delle donne, dimenticando temporaneamente la loro "inferiorità naturale". Le donne d'Angers redassero un manifesto rivoluzionario contro la sovranità e la tirannia della casa reale e le donne proletarie di Parigi parteciparono alla presa della Bastiglia dove entrarono con le armi in mano. Rose Lacombe, Louison Chabry et Renée Audou organizzarono una manifestazione di donne che camminarono su Versailles e riportarono Luigi XVI sotto stretta sorveglianza a Parigi. Dopo il trasferimento di Luigi XVI a Parigi, le donne gareggiarono con gli uomini per ottenere l'onore di difendere le porte della città. Le pescivendole del mercato inviarono una speciale delegazione agli Stati Generali "per incoraggiare i deputati e ricordare loro le richieste delle donne". "Non dimenticate il popolo" urlò la delegata ai 1200 membri degli Stati Generali, cioè all'Assemblea nazionale francese. Le donne dei sobborghi parigini parteciparono anche alla grande manifestazione del popolo a Champ-de-Mars, firmarono le petizioni e furono vittime della perfidia del re. Le donne dello terzo stato furono parte attiva a tutte queste azioni, mobilitate dalla loro coscienza di classe proletaria. Solo una Rivoluzione vittoriosa poteva salvare le donne francesi dall'assenza di diritti, dalla fame e dalla povertà, come pure dalle conseguenze oltraggiose dell'inflazione e della disoccupazione. Il proletariato femminile francese conservò fino alla tragedia finale la sua fiamma rivoluzionaria e la sua intransigenza, galvanizzando con il suo entusiasmo la folla, a volte più esitante, degli uomini.
Molto tempo dopo il crollo della Rivoluzione, la memoria delle crudeli e sanguinarie "magliaie" ossessionò le notti della borghesia. Chi erano dunque queste "magliaie", queste furie, coma piaceva chiamarle i così pacifici contro-rivoluzionari. Erano artigiane, contadine, operaie, lavoratrici domestiche o della manifattura che soffrivano crudelmente di fame e di ogni sorta di malattia, che odiavano l'aristocrazia e l' "Ancien Régime" con tutto il loro cuore e con tutte le loro forze. Dinanzi al lusso e allo spreco della nobiltà arrogante e pigra, reagirono con un sicuro istinto di classe e sostennero l'avanguardia militante per una Francia nuova, nella quale uomini e donne avrebbero avuto diritto al lavoro e dove i bambini non sarebbero morti più di fame. Per non sprecare inutilmente il loro tempo queste oneste patriote e queste zelanti operaie continuarono a lavorare a maglia le loro calze non soltanto a tutte le feste e a tutte le manifestazioni, ma anche nel corso delle riunioni dell'Assemblea Nazionale e ai piedi della ghigliottina mentre assistevano alle esecuzioni capitali. Del resto, queste calze, non le lavoravano a maglia per loro stesse, ma per i soldati della Guardia Nazionale - divenuti difensori della Rivoluzione.
Dobbiamo senza dubbio cercare gli albori del cosiddetto "movimento delle donne" in un periodo precedente la Rivoluzione Francese, tra il 1774 e il 1783, quando l'America si liberò dalla tutela inglese. Incontriamo nella storia della Rivoluzione francese numerose donne il cui nome è rimasto strettamente legato non soltanto al movimento, ma anche a tutte le fasi dello sconvolgimento rivoluzionario propriamente detto. Accanto alle rappresentanti della tendenza politicamente più moderata dei Girondini, come Mme Roland - se vogliamo stabilire un parallelo con gli eventi attuali, potremmo dire che è una menscevica -, spicca Louise Robert-Kéralio, giornalista e scrittrice di fama, non chè democratica e difensore autentico della Rivoluzione. Nessuna delle due si interessava veramente al movimento delle donne o avanzava rivendicazioni specificamente femminili. Tuttavia, furono le prime femministe della storia nella misura in cui contribuirono al riconoscimento oggettivo della parità delle donne. Con la loro azione al servizio della Rivoluzione, portarono il loro ambiente sociale ad astrarre completamente la loro appartenenza "al sesso debole". Alla fine, sono state viste solo come rappresentanti di una linea politica specifica. A parte loro e l'estremista femminista Olympe de Gouges, c'erano altre due donne che si distinguevano per la natura particolarmente combattiva. Nel primo periodo rivoluzionario, Théroigne de Méricourt e Desmoulins chiamarono il popolo a prendere le armi. Théroigne partecipò alla presa della Bastiglia e l'Assemblea Nazionale le regalò una spada per ricompensarla del suo coraggio. Il 5 ottobre 1789, alla vigilia della manifestazione che la vide dirigersi su Versailles, prese il comando, entrò in città a cavallo e vestita con abito rosso cercò di conquistare le donne alla causa rivoluzionaria. In collaborazione con il filosofo Remond, fondò una società: Les amis de la loi, che si mobilitò per il sostegno dell'esercito nazionale. Fece appello alle donne per la difesa della nuova patria - la Repubblica - e il 15 giugno 1792 diresse essa stessa il cannone verso il castello reale e vi irruppe accanto al popolo di Versailles. La Repubblica le concesse "la corona civica" per ringraziarla dei suoi fedeli servigi. Trovò la morte in occasione degli scontri tra Girondini e Giacobini. Personalmente era vicina ai Girondini.
Rose Lacombe chiese inoltre la resa del re di Versailles. Era davvero lei alla testa delle donne dei sobborghi di Parigi. Era di grande modestia, ma contemporaneamente molto combattiva, possedeva una volontà potente e un grande senso dell'organizzazione. Era dotata di una voce melodiosa e di un viso piacevole. Il suo discorso alla galleria dell'Assemblea Nazionale, con il quale assunse la difesa della Rivoluzione contro l'esercito della seconda coalizione per una democrazia del potere, resta fra i documenti più importanti della storia della Rivoluzione francese. Lacombe nemica dichiarata della monarchia, fu ferita a una mano durante l'assedio del palazzo. L'Assemblea Nazionale le assegnò, come a Théroigne, "la corona civica". Dal 1793 divenne membro del gruppo giacobino del partito dei Montagnardi e portava il berretto rosso del movimento rivoluzionario dei sanculotti sotto la direzione di Jean-Paul Marat. Richiese l'arresto di tutti i membri dell'aristocrazia e delle loro famiglie, si circondò di numerose partigiane e diresse, con i Giacobini, l'agitazione contro i Girondini fino alla loro definitiva sconfitta. Ma quando si ostinò nel suo ardore a proseguire la lotta versi i contro-rivoluzionari e i cospiratori di ogni tipo e si permise di attaccare la Convenzione stessa, i Giacobini si irritarono e Robespierre iniziò a detestare questo giacobina pericolosa e popolare, particolarmente dotata per la retorica. I membri della Convenzione mal sopportavano di vedere Rose Lacombe e altri membri della Società delle rivoluzionarie repubblicane partecipare ai lavori della Convenzione, di vederle controllare le liste dei prigionieri e se necessario, prendere la difesa dell'uno o dell'altro dei condannati.
La Società delle rivoluzionarie repubblicane fu fondata in origine da Rose Lacombe e dalla lavandaia Pauline Léonie, dunque da due donne dei sobborghi di Parigi. In questo club, Lacombe tentò di istruire i suoi compatrioti allo spirito della Rivoluzione.
Le discussioni delle donne riguardavano argomenti come: "Che possono fare le donne per la Repubblica?" Rose Lacombe era una brillante sostenitrice degli interessi dei lavoratori e intervenne spesso a loro favore con Pauline Léonie. E' accaduto che abbia occupato con una folla di Parigine senza lavoro e senza pane la galleria dell'Assemblea Nazionale e chiedere cosa il governo intendesse fare per alleviare l'evidente povertà delle donne lavoratrici. Per Rose Lacombe, i problemi, i bisogni, in breve la miseria di queste donne le erano familiari e sapeva esporre i loro problemi in modo vivace con discorsi misurati e allo stesso tempo impetuosi.
Quando la Convenzione scioglie le associazioni e i club femminili, Lacombe difese vigorosamente la sua creatura, la Società delle rivoluzionarie repubblicane. Ma perde la sua battaglia. Dopo la caduta dei Giacobini e la vittoria contro-rivoluzionaria, ogni manifestazione pubblica di donne fu rigorosamente repressa. Lacombe non poté ovviamente tacere e proseguì la sua agitazione. È per questo che fu arrestata nella primavera del 1797 e si ritirò successivamente dalla politica. Dopo la definitiva presa del potere da parte della reazione, scomparve per sempre dalla vita politica. Rose Lacombe era una donna che dedicò anima e corpo alla causa della Rivoluzione, ben comprendendo che le necessità delle donne proletarie, le loro rivendicazioni e le loro preoccupazioni dovevano essere inseparabili dalla lotta di classe del movimento operaio nascente. Non richiedeva diritti speciali per le donne, ma esigeva da loro la più grande vigilanza e le invitava a difendere i loro interessi come membri della classe operaia. A causa della formidabile lotta che intraprese per le donne lavoratrici, è per noi oggi naturalmente la più vicina delle donne che si erano impegnate in modo più unilaterale in occasione della grande Rivoluzione.
Il movimento delle donne borghesi fu fondato in America da Abigail Smith Adams (moglie del secondo presidente della giovane Repubblica americana) e dalla sua compagna di lotta Mercy Warren, in Francia da Olympe de Gouges e in Inghilterra da Mary Wollstonecraft. Queste femministe borghesi, instancabilmente, grazie a un pugno di filosofi illuminati del XVIII° secolo e all'azione coraggiosa di alcune donne disinteressate, fecero si che la discussione sulla parità di diritti uomo e donna potesse avere luogo, certe che questi rari individui avrebbero difeso con determinazione "il gentil sesso" , richiesto la stessa educazione per uomo e donna, come pure il riconoscimento dell'uguaglianza di diritti. La loro lotta aperta avrebbe destato nella maggioranza delle donne la coscienza del loro valore fino ad allora dormiente. Le donne avrebbero cominciato ad organizzarsi e a difendere i loro interessi e nel corso del XIX° secolo e avrebbero strappato un diritto dopo l'altro con un'accanita lotta.
Questa visione è completamente falsa. La storia della liberazione delle donne è andata molto diversamente. Le femministe combattive - come Olympe de Gouges in Francia, Abigail Smith Adams in America o Mary Wollstonecraft in Inghilterra - poterono formulare "la questione femminile" in modo così preciso soltanto perché numerose donne lavoravano alla fine della XVIII° secolo nella produzione e perché la società iniziava a riconoscere la loro forza lavoro come necessaria. Olympe de Gouges sostenne la Convenzione in questi termini: "Se la donna ha il diritto di montare sul patibolo, deve anche avere il diritto di salire sulla tribuna". Lottò ostinatamente per il riconoscimento dei diritti politici della donna. Abigail Smith Adams informò il governo rivoluzionario americano che "le donne non si sarebbero sottomesse alle leggi della Repubblica finché non avessero ottenuto il diritto di voto". Fu la prima ad esprimere senza ambiguità la rivendicazione di un'uguaglianza politica tra uomo e donna. Mary Wollstonecraft richiese una revisione totale dell'istruzione delle donne, dunque un'uguaglianza di diritti sul piano dell'educazione. (Fu una scrittrice di talento della fine del XVIII° secolo. La sua opera, Défense des droits de la femme, fu pubblicata nel 1796 e fece scalpore.)
A causa delle loro differenti posizioni iniziali, le donne arrivarono anche a soluzioni diverse dalla contraddizione tra il ruolo della donna nella produzione e i suoi diritti nello Stato e nella società. Ma possono essere raggruppate sotto un unico denominatore comune: il diritto al lavoro. Questo diritto al lavoro equivaleva a quel tempo, alla vittoria della Rivoluzione. Si trattava allora di liquidare definitivamente il feudalesimo e gettare le basi di un nuovo sistema economico. Per questo, come per la conquista del diritto al lavoro per la donna, occorreva garantirsi il potere politico. È per questo che le femministe borghesi fecero un errore enorme nel cercare di dimostrare che la lotta delle donne per l'uguaglianza dei diritti e la loro coscienza crescente del loro diritto alla dignità umana, avrebbe permesso di accedere alla vita professionale. La storia prova esattamente il contrario. Olympe de Gouges scrisse nel suo famoso manifesto: "L'obiettivo di ogni assemblea legislativa deve essere quello di proteggere i diritti inalienabili di entrambi i sessi: libertà, progresso, sicurezza e protezione dall'oppressione. Tutti i cittadini e tutte le cittadine devono potere partecipare direttamente e tramite i loro rappresentanti alla legislazione. Tutte le cittadine devono avere uguale accesso a tutte le professioni dell'amministrazione pubblica e agli onori che le accompagnano."
Tuttavia, tutte queste richieste, incentrate principalmente sul "libero accesso delle donne a tutte le professioni della funzione pubblica", potevano essere formulate solo perché le "donne del popolo" avevano aperto la strada al lavoro produttivo delle donne. Durante la Rivoluzione francese, la richiesta di uguaglianza politica dei diritti non era ancora una questione scottante per le donne proletarie, ma piuttosto una preoccupazione di elementi democratici borghesi. Le donne dei sobborghi parigini erano scarsamente rappresentate nei club femminili. Intendo i club femminili fondati da Palm Alder e da altre pioniere della lotta femminista vera e propria. Le borgatare di Parigi lottavano ardentemente con tutto il proletariato per la soppressione del sistema corporativo e per altre rivendicazioni tipicamente proletarie. Il loro istinto di classe segnalava loro con sicurezza che le rivendicazioni "del diritto al lavoro" e "della soppressione delle corporazioni" avrebbero risolto i loro problemi in modo più radicale della lotta imperniata soltanto sui diritti politici della donna. Tuttavia, Olympe de Gouges, nel formulare le sue rivendicazioni politiche, credeva fermamente di difendere gli interessi della totalità delle donne. La situazione storica del XVIII° secolo era tale che il riconoscimento unilaterale dei diritti politici della donna avrebbe condotto a un ulteriore rafforzamento dei privilegi delle donne già appartenenti alle classi privilegiate. Ciò era valido tanto per la Francia, che per l'America e l'Inghilterra. Le donne del proletariato si sarebbero trovate ancora una volta con le mani vuote.
Il movimento delle donne e la sua rivendicazione per il riconoscimento dei diritti umani della donna sorsero alla fine della XVIII° secolo, in questo caso a causa dello sviluppo generale della produzione e dell'economia nazionale e del ruolo crescente che la donna occupava nella produzione. Ci soffermeremo ora sugli esempi dell'Inghilterra, della Francia e dell'America per sostenere la verità della nostra tesi, cioè che la posizione sociale della donna è dipendente dal suo significato nella produzione.
Abbiamo già visto in modo approfondito il progresso del lavoro femminile nel periodo della manifattura. La produzione industriale si sviluppò nel corso della XVIII° secolo in due stati capitalisti, la Francia e l'Inghilterra. Inutile ritornare su questo. Ma le nostre analisi si applicano anche all'America? Nel XVIII° secolo, l'America era ancora solo una delle numerose colonie del potente Impero britannico e inoltre una delle più arretrate. La sua industria era solo leggermente sviluppata e la piccola produzione era dominante nell'agricoltura. La popolazione era composta soprattutto da contadini. Perché allora fu precisamente l'America che diventò la culla del movimento delle donne? Perché le Americane richiedevano la parità dei diritti della donna e il riconoscimento dei loro diritti politici fondamentali in un'epoca ben precedente a quella dei paesi molto industrializzati dell'Europa? Questo fatto non è in contraddizione palese con la nostra tesi secondo la quale la lotta delle donne per l'uguaglianza dei diritti sarebbe soltanto il risultato del loro ruolo nella produzione? Le rivendicazioni delle donne per i loro diritti politici non derivavano piuttosto dalle rivendicazioni e dalle lotte politiche e democratiche della borghesia? Assolutamente no. Poiché l'America, al contrario, è invece un'ulteriore prova per l'esattezza della nostra tesi. Le rivendicazioni politiche delle donne americane erano naturalmente il risultato diretto del ruolo della donna nella vita economica dell'America settentrionale al XVII° e XVIII° secolo, cioè in un periodo dove l'America era ancora solo una colonia inglese.
L'America del Nord fu colonizzata da emigranti provenienti dal Vecchio Mondo - dall'Europa - che fuggivano generalmente la dominazione e la tirannia del feudalesimo o dalle persecuzioni religiose. La loro forza lavoro e la loro energia erano tutto ciò che possedevano. La maggior parte delle volte questi fuggitivi europei emigrarono con tutta la loro famiglia nel Nuovo Mondo, occuparono e dissodarono le nuove terre e diventarono coloni e contadini. Poiché la manodopera era carente, tutta la famiglia doveva mettersi al lavoro. Le mogli e le figlie dei contadini quindi hanno lavorato duro come gli uomini per cercare di raggiungere una certa prosperità. Le donne condividevano naturalmente le preoccupazioni economiche degli uomini che lottavano a tutti i livelli contro la natura ancora selvaggia e indomita. Come gli uomini, le donne erano permanentemente armate per difendere le fattorie costruite in comune contro gli attacchi degli indiani. È per questo che le donne erano una forza di lavoro preziosa, che contribuiva alla prosperità di tutta la colonia. È di quest'epoca che data il rispetto che gli americani continuano a portare attualmente per le donne. Questa alta stima sta tuttavia diminuendo con l'influenza crescente del capitalismo attuale estremamente sviluppato in questo paese. Quest'ultimo sistema trasforma la donna esclusivamente in schiava salariata, come mero complemento ed appendice del marito e dipendente da lui per il suo mantenimento.
Finché l'America fu una colonia inglese prevalse il seguente principio: rappresentanza per tutti coloro che pagavano le tasse. Tutti i contribuenti avevano dunque il diritto di partecipare agli affari dello Stato, anche le donne. Di conseguenza, non sorprende che le donne partecipino attivamente alla guerra civile americana. Si pronunciarono ovviamente per l'indipendenza del paese che avevano attivamente contribuito a costruire. Le donne lottarono con ardore fino all'ultimo giorno della guerra d'indipendenza per un'America libera e adottarono posizioni politiche spesso più radicali di quelle dei politici rivoluzionari maschili. Ad esempio, Mercy Warren, si pronunciò apertamente per un'indipendenza totale della madre patria in un'epoca dove anche il capo dei separatisti, Washington, non osava ancora avanzare una rivendicazione così radicale. Queste donne erano convinte che la nuova Repubblica andava a garantire loro il pieno esercizio dei diritti politici, dato che ne godevano già nel periodo dove l'America era ancora solo una colonia britannica. Ma dovettero presto ricredersi. In realtà l'Assemblea Costituente non si pronunciò mai ufficialmente contro il diritto di voto femminile (la questione fu abbandonata su iniziativa di ogni Stato federato), ma questo diritto non fu neppure ratificato dalla Costituzione. E' facile spiegare questa decisione: alla fine della XVIII° secolo, l'America non era più un paese di piccoli contadini, la grande industria stava nascendo. La donna cessava di essere una forza produttiva necessaria e il suo riconoscimento per l'economia nazionale declinò di conseguenza. Come sempre e dopo che la borghesia era riuscita a consolidare il suo potere, le donne furono riportate al loro ruolo esclusivo di mogli e di madri e relegate a fare parte della rendita.
Le donne appartenenti agli strati più svantaggiati della popolazione diventarono operaie di fabbrica e andarono ad ingrossare la massa degli schiavi del capitale. Occorre osservare che gli Stati federali industrializzati tolsero alle donne il diritto di voto, accordando solo agli uomini i pieni diritti, mentre negli Stati agricoli, come Virginia e New Jersey, le donne hanno mantenuto i loro diritti politici, tanto al livello di comune che al livello dello Stato.
Constatiamo dunque che le rivendicazioni femminili per la parità dei diritti furono generalmente sostenute dalla società americana, in particolare dagli ambiti rivoluzionari. La donna fu sfruttata dalla borghesia in tutti modi possibili e concepibili e utilizzata per la guerra civile. Sono state esaltate le sue qualità civiche "virili", il suo spirito di sacrificio e il proprio entusiasmo per la Repubblica. Ma, appena si sentirono le grida della vittoria e il vecchio nemico - l'Inghilterra feudale - aveva cessato di minacciare le prerogative della borghesia, l'interesse che avevano mostrato i democratici per le rivendicazioni delle donne, cadde rapidamente. Gli esempi francesi ed americani ci permettono di trarre la conclusione secondo la quale le rivendicazioni per l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna sono apparse dopo che la donna aveva impegnato le sue forze produttive lavorative per l'economia nazionale. Non erano dunque le rivendicazioni per la parità di diritti che hanno spinto le donne alla vita professionale, ma esattamente l'opposto, il ruolo della donna nella produzione la portò a chiedere questa uguaglianza.
Ma come spiegare allora che le donne in tutti gli Stati borghesi continuano a subire una manifesta discriminazione rispetto agli uomini? Che lo Stato borghese e la società capitalista rifiutano sempre di considerare la donna come un individuo e una cittadina a pieno titolo nonostante le lavoratrici costituiscano una parte significativa della popolazione attiva?
Questa situazione intollerabile è dovuta all'ordine sociale borghese e capitalista, basato sull'antagonismo di classe e sul lavoro salariato. Negli Stati borghesi la maggioranza delle donne lavoratrici si trova fra la classe operaia, cioè schiave salariate al servizio del capitale. Esattamente come le despote dell'Antichità che disprezzavano i loro schiavi, uomini ai quali dovevano in realtà tutta la loro fortuna, i borghesi al giorno d'oggi non vogliono riconoscere i diritti di migliaia di proletari, produttori di tutte le ricchezze e che costituiscono la base della prosperità della società borghese. Nel sistema capitalista, l'operaio, come l'operaia, non esercita alcun lavoro indipendente, creatore di prodotti che vanno direttamente al consumatore. Tutti e due lavorano in cambio di un salario e vendono la loro forza lavoro all'imprenditore. All'epoca dell'economia naturale, l'artigiano e il lavoratore a domicilio non vendevano la loro forza di lavoro al consumatore, ma il prodotto finito del loro lavoro. Nel periodo della schiavitù salariata, invece, l'operaio deve vendere la propria forza lavoro al capitalista. Abbiamo già avuto occasione di descrivere perché gli economisti borghesi sono fondamentalmente riluttanti a riconoscere la manodopera come la principale fonte di ricchezza. Gli economisti borghesi e gli imprenditori sostengono con tutte le argomentazioni possibili e concepibili l'idea che la macchina è quella forza creatrice di qualsiasi ricchezza e che l'operaio svolge un ruolo subordinato. In questa teoria borghese, operai ed operaie sono, in definitiva, i complementi viventi della macchina. In realtà, nella testa degli imprenditori, è il loro capitale ad essere la vera fonte di abbondanza.
Finché in una società prevarranno i rapporti di produzione borghesi, non ci può attendere che la forza di lavoro umana sia valutata differentemente o che ci possa essere una valutazione nuova del ruolo della classe operaia e della posizione della donna nella produzione. Il lavoro salariato ha strappato la donna alla famiglia per gettarla nella produzione. Il sistema attuale del lavoro salariato rende l'operaio e l'operaia, materialmente e politicamente, completamente dipendenti dalla borghesia. Il loro lavoro è sottopagato, indipendentemente dal loro sesso. Ai tentativi organizzati della classe operaia di ampliare i propri diritti e democratizzare lo Stato borghese, la borghesia reagisce opponendo una resistenza ben organizzata, raddoppiata da una cieca rabbia. Non è colui che crea valore, ma chi vive dello sfruttamento della forza lavoro che è più qualificato per occuparsi degli affari dello Stato e dell'organizzazione della società... Il destino della donna lavoratrice si identifica con quello dell'insieme del proletariato. Mentre milioni di donne sono ora costrette al lavoro salariato, la loro situazione sociale si sta degradando sempre più. Oltre all'asservimento del focolare e alla sua dipendenza nell'ambito della famiglia, il capitalismo impone alla donna un peso supplementare, cioè il lavoro salariato nelle mani dell'imprenditore.
Abbiamo detto precisamente che il matrimonio non può in nessun caso salvare la proletaria dall'obbligo di vendere la propria forza di lavoro. Sempre più frequentemente le operaie sposate sono costrette a combinare il lavoro professionale fuori casa con il lavoro domestico, con l'educazione dei bambini e al servizio del marito. La vita della donna si trasforma in una fatica ininterrotta, non dorme abbastanza e non si riposa mai. È la prima ad alzarsi la mattina e l'ultima a coricarsi. Ciò nonostante le famiglie operaie si sciolgono, la casa è trascurata e i bambini lasciati a loro stessi. Le donne faticano per niente e cercano disperatamente di garantire la coesione della famiglia. La donna vive sempre nel passato e accorda un valore più grande alla famiglia e al focolare che l'uomo, ma i rapporti di produzione implacabili non tengono alcun conto dei desideri degli uomini. Con la comparsa della produzione industriale si restringe il significato dell'economia familiare. Una funzione dopo l'altra si dissolve. I compiti che erano stati importanti un tempo per l'economia familiare e costituivano elementi inseparabili dal lavoro domestico, cadono in disuso e scompaiono. Ad esempio non è più necessario che la donna perda tempo prezioso a rammendare calze, fabbricare sapone o cucire abiti, mentre questi articoli si trovano in abbondanza sul mercato. Cosa che non le è di alcuna utilità, se manca il denaro. Per guadagnare denaro deve vendere la sua forza lavoro e cercarsi un'occupazione. Perché la donna dovrebbe continuare a preparare conserve per l'inverno, cucinare pane o preparare accuratamente il pranzo, se esistono centinaia di conserve già pronte, i panettieri sfornano sufficiente pane e la famiglia operaia può avere un pasto pronto e a buon mercato al grande magazzino o anche al ristorante più vicino?
Con questo processo, il lavoro familiare della donna diventa sempre più superfluo, tanto dal punto di vista dell'economia nazionale, che dal punto di vista familiare. È per questo che si assiste alla dissoluzione della famiglia, in particolare nelle città. Scompare con lo sviluppo dello scambio delle merci e della produzione di grande quantità di beni di consumo. La famiglia, che era stata una necessità all'epoca dell'economia naturale, diventa di conseguenza un handicap occupando la donna in modo inutile e improduttivo per l'economia nazionale. Poiché la famiglia non è più un'unità economica, è diventata superflua. In URSS, il lavoro femminile è posto al servizio della piccola unità familiare. Il numero di donne occupate nella produzione è in aumento. La Grande Guerra ha confermato definitivamente l'importanza del lavoro femminile per l'ulteriore sviluppo delle forze produttive. Non esiste alcun ramo di attività dove, nel corso degli ultimi sette anni, le donne non abbiano lavorato. Durante la guerra il numero delle donne che hanno esercitato un'attività professionale è aumentato solo in America e in Europa di circa dieci milioni e il lavoro della donna è diventato una necessità assoluta. Le statistiche mostrano che all'inizio del XIX° secolo un terzo del valore che circolava sul mercato mondiale era prodotto da donne. Da allora la partecipazione delle donne alla produzione internazionale di merci è naturalmente aumentata ancora. Il lavoro della donna è diventato un fattore di stabilità economica. Ciò nonostante, "la questione femminile" rimane irrisolta (ndt 25). Le donne di tutti i paesi - ad eccezione della Russia - hanno ancora molta strada da fare prima che finisca la loro lotta per la parità di diritti. Sappiamo tuttavia che la radice del male risiede nel sistema di produzione capitalista e nella divisione della società borghese in classi, società basata sulla proprietà privata. Nella misura in cui abbiamo riconosciuto le cause di questa situazione impossibile, siamo anche in grado di sviluppare forme di lotta che ci permettono di rimediare a questa situazione. La discriminazione di cui la donna è vittima, come pure la sua dipendenza, potranno essere superate definitivamente soltanto quando la società adotterà un nuovo sistema, dove produzione e consumo collettivi sostituiranno la proprietà privata, cioè con la vittoria del comunismo.
* * *
ndt:
23) Per nozione di questione femminile consulta il Dizionario enciclopedico marxista su Resistenze.org
24) Interessante leggere: "Cosa differenzia il femminismo di classe dal femminismo borghese" Clarisa Urbàn su Traduzione per Resistenze.org
25) Indispensabile leggere: Clara Zetkin "La questione femminile e la lotta al riformismo" Gabriele Mazzotta Editore, 1972 - Consulta il libro su Mels - Biblioteca digitale
Ottava conferenza - Il movimento femminista e il ruolo della donna lavoratrice nella lotta di classe
Il movimento delle donne fu dunque il risultato di una contraddizione esemplare in seno al capitalismo: la partecipazione crescente delle donne alla produzione non era corrispondente in nessun modo alla loro discriminazione persistente nella società, nel matrimonio e nello Stato.
La "questione femminile" non esiste in modo indipendente. Questa violenza nella società borghese che opprime la donna è prodotta in parte dalla grande antinomia sociale tra capitale e lavoro.
La contraddizione tra la partecipazione della donna alla produzione e la sua generalizzata assenza di diritti condusse alla comparsa di un fenomeno assolutamente sconosciuto fino a quel momento: la nascita di un movimento di donne. Ma fin dall'inizio, questo movimento prende due orientamenti diametralmente opposti: una frazione si organizza sotto l'egida di un movimento femminista borghese, mentre l'altra diventa parte integrante del movimento operaio.
Il movimento femminista borghese nel XIX secolo derivava da organizzazioni politiche maschili e borghesi e non cessò di essere successivamente, anche solo parzialmente, il riflesso delle classi sociali che lo componevano. Il movimento delle donne prese rapidamente ampiezza e forma, alla fine della XIX secolo, nella totalità degli Stati occidentali ed orientali, una rete solida di organizzazioni femminili. Il loro obiettivo principale era il riconoscimento dell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna su tutti i piani e nel quadro della società capitalista esistente. Le dirigenti borghesi del movimento delle donne non erano affatto interessate al movimento di rinnovamento sociale che apriva prospettive nettamente più vaste alla liberazione della donna e che ha dato loro l'unica base solida. Restarono completamente estranee al socialismo. E se, finalmente, una parte delle femministe borghesi aveva formulato verso la fine del XIX secolo delle rivendicazioni prese in prestito alle socialiste, fu solo per garantirsi il sostegno delle donne proletarie, per comperare la loro collaborazione e darsi così un più grande peso politico.
Il movimento femminista borghese si voleva esterno alla classe, neutrale e affermava di rappresentare le rivendicazioni e le iniziative di tutte le donne. Tuttavia, la realtà era molto diversa e le femministe borghesi alla fine, non rappresentavano nulla di più che le loro rivendicazioni e i loro interessi, cosa che non escludeva il fatto che il movimento femminista borghese reclutasse i suoi membri fra le classi sociali più diverse. Una terza caratteristica di questo movimento è che esso riuscì a scatenare un serio conflitto d'interessi tra l'uomo e la donna, nella misura in cui, alla fine, le femministe cercavano di imitare gli uomini. Commisero ancora un altro grave errore. Non presero in considerazione il doppio ruolo sociale della donna e trascurarono completamente che questi "diritti naturali" che difendevano con tanto ardore, esigevano donne non soltanto che svolgessero un lavoro produttivo per la società, ma anche che assicurassero la loro funzione riproduttiva nell'ambito di questa stessa società. Ma la difesa e la protezione della donna come madre, non entravano affatto nel programma, né nella politica del movimento femminista borghese.
E quando il movimento iniziò a discutere il problema della protezione della maternità tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, esso rappresentava una novità nel loro lavoro. A malincuore e senza credervi troppo, le femministe inclusero nel loro programma le rivendicazioni di protezione legale della madre e altre leggi speciali che dovevano garantire la tutela delle lavoratrici.
Le femministe tentarono ingenuamente di riportare la lotta per i diritti della donna dal piano stabile della lotta di classe, al piano della lotta tra i sessi. Ciò ha dato luogo ad una falsificazione, una caricatura. La loro mancanza di intuizione politica ha allontanato le femministe dalla giusta linea di lotta.
Il successo e l'appoggio che le femministe borghesi avevano incontrato in precedenza fra gli uomini della loro classe, furono persi entrambi perché in ogni occasione, buona o cattiva, difendevano una causa esclusivamente femminile, anziché sostenere gli interessi dell'insieme della classe borghese, che avrebbe potuto garantire in cambio i loro diritti. È soltanto all'inizio del XX secolo che i borghesi politicamente coscienti iniziano a collegare la propria lotta a quella di un determinato partito politico e che si presentano da quel momento come rappresentanti di questo partito. E' così che lavoravano ad esempio le giovani cadette, inizialmente nell'Associazione per i diritti delle donne e più tardi, nella Lega per i diritti delle donne.
Alcune organizzazioni inglesi e tedesche adottarono una politica simile.
Dato che le femministe borghesi hanno usato tutta la loro energia per dimostrare che la donna non era affatto e in nessun modo inferiore all'uomo, trascurarono completamente la specificità biologica della donna, specificità di cui la società doveva tenere conto. Nel periodo del comunismo primitivo, la tribù rispettava le donne perché erano, da un lato i produttori principali dell'economia della tribù e dall'altro, perché mettevano al mondo i bambini e garantivano così la discendenza della tribù. Ma in seguito, quando gli uomini eseguivano la totalità dei compiti produttivi, la società non aveva più una ragione importante per considerare le donne come uguali a loro, anche se queste continuavano a partorire come in passato. È soltanto quando uomini e donne hanno un lavoro socialmente utile, che la società è pronta a considerare la funzione sociale supplementare della donna, come madre ed educatrice dei bambini, garantendole un certo aiuto e protezione.
Ma le femministe borghesi, nel loro esaltato impegno per i vuoti principi dell'uguaglianza dei diritti, rifiutarono di riconoscere questa realtà. Il loro più grave errore fu di credere che il riconoscimento dei diritti della donna dipendesse dalla totale uguaglianza dell'uomo e della donna. È per questo che le femministe estremiste si vestivano "per principio" e non per comodità come gli uomini, si tagliavano i capelli per somigliare a loro e mostravano gesti e comportamenti maschili.
Quando le femministe appresero che le donne che lavoravano come scaricatori al porto erano costrette a trasportare carichi pesanti, furono estremamente commosse e scrissero, effettivamente, nei loro giornali e nelle loro riviste ciò che segue: "Una nuova vittoria da mettere in conto nella lotta per l'uguaglianza dei diritti della donna. Le donne portuali trasportano fianco a fianco dei loro colleghi maschi, carichi che arrivano fino a 200 kg". Non si rendevano conto che al contrario sarebbe stato necessario scrivere articoli per svelare la rapacità del capitalismo, denunciare questo lavoro inadatto, dannoso per gli organi femminili e pertanto, dannoso per il popolo intero. Le femministe non capivano che la donna, a causa delle sue specifiche proprietà fisiche, si trova sempre in una situazione "a parte" e che, per una data società, il fatto di "rispettare" o di "tenere conto" di queste qualità specifiche non sarebbe affatto pregiudizievole, al contrario. La donna non deve assolutamente fare lo stesso lavoro dell'uomo.
Al fine di garantirgli pari diritti, è sufficiente che svolga un lavoro di pari valore per la comunità. Ma le femministe semplicemente non capivano questa relazione ed è per questo che il loro movimento era così limitato e unilaterale.
Il movimento femminista borghese attraversò naturalmente varie tappe di sviluppo. Le rivendicazioni per l'uguaglianza dei diritti politici, che erano state poste con energia e fermezza in America e in Francia fino al XVIII secolo, cessarono con lo scatenarsi della guerra civile e il consolidamento simultaneo della predominanza della classe borghese. Il movimento femminista all'inizio del XIX secolo si accontentò allora più modestamente di reclamare l'accesso di tutte le donne alla formazione professionale. Questa rivendicazione deriva direttamente dalla prima rivendicazione del movimento, cioè dal diritto al lavoro. All'epoca della Rivoluzione francese, Olympe de Gouges aveva perfettamente ragione quando affermava nel suo manifesto politico che il riconoscimento unilaterale dei diritti politici della donna non avrebbe affatto cambiato la situazione di questa. Era altrettanto importante per le donne lottare per ottenere l'accesso a tutte le professioni.
All'epoca in cui Olympe de Gouges pubblicò il suo manifesto, cominciò la lotta delle donne borghesi per l'accesso senza restrizione agli studi e alle professioni universitarie. All'apogeo del capitalismo, gli artigiani non erano i soli a fare fallimento, né gli operai a domicilio a trasformarsi in operai di fabbrica. L'idillio sentimentale della piccola e della media borghesia fu così considerevolmente minato. Gli uomini di queste ultime categorie sociali diventarono bruscamente incapaci di far fronte al mantenimento delle loro famiglie. Ciò indusse i figli e le figlie delle famiglie svantaggiate a cercare lavoro. Le ragazze delle famiglie borghesi lavoravano come maestre di scuola, scrivevano o traducevano romanzi o tentavano di adoperarsi come funzionari dello Stato per garantirsi un reddito stabile. Tuttavia, l'accesso delle donne alle professioni specificamente universitarie restò loro interdetto come in passato. La società borghese ha dato alla loro energia e intelligenza solo una fiducia limitata e ha aperto loro questa strada soltanto a malincuore. Occorre aggiungere che le donne stesse sottovalutavano le loro facoltà intellettuali rispetto agli uomini.
Normalmente, l'uomo garantiva la sua sussistenza e quella della sua famiglia. La donna borghese aveva, di norma, soltanto "un'occupazione di sostegno", abitava con il marito ed utilizzava le sue entrate per coprire le proprie "spese personali". Ma il numero di donne della piccola e della media borghesia obbligate a soddisfare non soltanto i propri bisogni, ma anche quelli della propria famiglia, aumentava sempre più. I loro stipendi, tuttavia, continuavano a essere calcolati come se il loro lavoro fosse solo supplementare. La loro debole qualificazione professionale fu anche causa del reddito inferiore percepito. Non è perché le donne appartenevano "al sesso debole" che gli imprenditori e i servizi pubblici sbarravano loro l'accesso alle occupazioni d'ufficio o al lavoro d'insegnante. Il loro lavoro rivestiva un valore produttivo inferiore perché le donne non disponevano della formazione professionale corrispondente. I loro concorrenti sul mercato del lavoro, gli uomini, erano ovviamente estremamente insoddisfatti quando perdevano il loro lavoro d'ufficio nel settore privato o in quello pubblico.
Le femministe commisero un grave errore pensando che gli uomini rifiutassero l'accesso delle donne ad alcune professioni soltanto perché erano egoisti e temevano la concorrenza femminile. Il fatto che le donne borghesi avessero allora la scelta tra un numero estremamente ridotto di professioni, era dovuto alla mancanza di formazione professionale. Le donne poterono uscire da questo vicolo cieco soltanto quando riuscirono ad accedere agli studi universitari. È per questo che in alcuni paesi, come in Germania e più tardi anche in Russia, la rivendicazione essenziale del movimento femminista borghese fu la seguente: stesse condizioni per le donne e gli uomini nell'istruzione superiore. Il dibattito su migliori possibilità d'istruzione per le donne è sorto nel XVIII secolo. Lo scrittore francese Fénelon e più tardi, il filosofo e giornalista Condorcet (particolarmente attivo durante i primi anni della Rivoluzione) si sono pronunciati con determinazione per l'istruzione delle donne. In Inghilterra, la questione fu già posta nel XVII secolo da Daniel Defoe e Mary Astell. Ma, poiché erano l'uno e l'altra in una posizione piuttosto isolata, il loro appello non aveva comportato conseguenze pratiche.
Le cose cambiarono tuttavia durante il XIX secolo. Mary Wollstonecraft affrontò nuovamente il problema dell'istruzione della donna nella sua opera Per la difesa dei diritti della donna. In questo libro dà prova del resto di un coraggio e di un'audacia eccezionali e senza dimenticare le grandi figure della Rivoluzione francese. Le sue conclusioni furono particolarmente originali. Rivendicava un miglioramento dell'educazione delle donne e il riconoscimento dei loro diritti, pur mettendo l'accento sul significato spirituale della maternità. Solo una donna libera e cosciente poteva essere una buona madre capace di insegnare ai suoi bambini i loro doveri di cittadini ed un amore autentico per la libertà. Fra tutti i pionieri che lottano per i diritti delle donne, Mary Wollstonecraft fu effettivamente la prima che reclamò l'uguaglianza dei diritti della donna a partite dai doveri della maternità. La sola eccezione è Jean-Jacques Rousseau in Francia. Questo filosofo e rivoluzionario del XVIII secolo spiega l'uguaglianza delle donne a partire dai "diritti naturali dell'umanità". Tuttavia nella sua libera società, in cui l'intelligenza regnava sovrana, rinviava però la donna esclusivamente al suo ruolo di madre, in uno spirito non molto distante da quello della famiglia borghese.
Nonostante il fatto che molti pensatori si fossero pronunciati nella prima metà del XIX secolo per l'eguale diritto dell'uomo e della donna ad un'istruzione superiore, le porte delle università - e anche quelle delle istituzioni di livello inferiore - restarono chiuse alle donne, come in passato. È soltanto al termine di una lunga lotta e dopo avere superato ostacoli innumerevoli che la donna riuscì ad ottenere il suo accesso al lavoro intellettuale, che le fornì le conoscenze scientifiche e tecniche necessarie. Elisabeth e Amelia Blackwell, due militanti del movimento femminile borghese, arrivarono verso il 1840 ad entrare in un'università americana. Amelia fu la prima donna a conseguire il titolo di medico. In quella stessa epoca, la prima giornalista americana, Margareth Fuller, riesce a farsi un nome. Verso il 1860, Mary Mitchell fu la prima donna ad ottenere una cattedra di matematica e astronomia, per altro sempre in America. Negli anni 30, l'inglese Caroline Herschel, sorella del famoso astronomo Herschel, diventò membro della società astronomica.
Ma le università inglesi restarono chiuse alle donne. Così la prima dottoressa inglese, Elisabeth Garrett, fu obbligata a studiare medicina in Svizzera. È soltanto verso la fine del XIX secolo che le donne riuscirono a conquistare, passo dopo passo, il loro accesso alle università.
In Russia, anche il movimento femminista borghese lottò inizialmente per "la libertà d'istruzione". Questo slogan si basava sulla rivendicazione legittima e necessaria del diritto al lavoro. La possibilità di esercitare una libera professione che richiedeva una formazione universitaria era quindi completamente preclusa alle donne.
Il processo di dissoluzione della nobiltà comincia negli anni 1860, in questo caso dopo la liberazione dei contadini ed altri cambiamenti politici intervenuti a favore del capitalismo. La rovina economica dei proprietari terrieri obbligò i loro bambini, ragazzi, come ragazze, a cercare lavoro. Apparve così un nuovo tipo di donne: donne che guadagnavano da vivere esattamente come gli uomini esercitando una libera professione. Parallelamente allo sviluppo del capitalismo, vi è stata la nascita di un apparato statale sempre più complesso, che richiedeva sempre più forza lavoro, in particolare nei settori dell'istruzione e della medicina. Questo stato di cose dispose al meglio i poteri pubblici riguardo le rivendicazioni delle donne per una formazione superiore.
In Russia, la domanda crescente e la mancanza di manodopera qualificata, agevolarono le nostre donne nell'accesso alle libere professioni e agli istituti di istruzione superiore. Naturalmente ciò non avvenne interamente senza lottare. Il principio di inerzia impedisce sempre a una classe di capire che certe riforme possono servire particolarmente ai propri interessi. Ad esempio, Sofia Kovalevskaja, matematica conosciuta, incontrò una resistenza così grande tanto che fu obbligata a completare i suoi studi all'estero. E negli anni 1880 non divenne professoressa in un'università Russa, ma in un'università svedese di Stoccolma. Ricordo ancora molto bene l'immenso prestigio di cui godono le nostre prime due dottoresse russe, Nadeschda Suslova e Rudnova, che ottennero entrambe il loro titolo all'estero.
Al giorno d'oggi - in particolare dalla fine della guerra, ma anche perché la Rivoluzione russa esercita una grande influenza sull'evoluzione di tutti gli altri paesi - la questione intesa ad accertare se la donna avesse o no diritto ad una formazione più accurata fu risolto quasi ovunque in modo soddisfacente. In Asia, in Cina, in India e in Giappone, la questione resta ancora in sospeso, come certe scienze o alcune professioni restano ancora precluse alle donne. Ma, anche in questi paesi, le donne hanno attualmente più facilità ad accedere ad una formazione universitaria e professionale più ampia di quanto non avvenne in Europa e in America per il periodo che qui ci interessa. Quest'evoluzione è dovuta allo sviluppo del capitalismo e alla domanda crescente di un apparato di Stato sempre più complesso, che richiede un numero sempre più importante di maestri, di telegrafisti, di telefonisti, di impiegati, di bibliotecari, ecc.
Nel corso degli anni 1850, le donne borghesi, al posto della rivendicazione all'uguale diritto alla formazione, arrivarono a porre correttamente la rivendicazione "del diritto al lavoro". Il movimento femminista borghese può essere orgoglioso di avere permesso alle donne di conquistare la loro indipendenza economica con il lavoro. Questo movimento non ha tuttavia tenuto conto del fatto essenziale che il movimento delle donne era soltanto un risultato dell'integrazione delle donne nella produzione. Sappiamo, grazie alle conferenze precedenti, che queste rivendicazioni furono già realizzate nella pratica da milioni di proletari e ciò ben prima di essere formulate dalle femministe. E questo processo fu una conseguenza delle condizioni economiche nuove e dell'istituzione definitiva del sistema capitalista.
In effetti, la maggioranza delle borghesi viveva come nel passato, felice ed al riparo nel proprio focolare, a spese del proprio marito o del proprio amante, in breve, non le mancava nulla. In quella stessa epoca, le contadine povere e i proletari obbligati a guadagnarsi la vita realizzarono fin dal XVII e XVIII secolo la parola d'ordine delle femministe della fine del XIX, cioè il diritto al lavoro. Le donne più povere lottavano per questo diritto, mentre le borghesi consideravano come una vergogna il dover lavorare. Ma le donne della classe operaia, accedendo al lavoro produttivo, non seguivano le stesse regole sociali. Il movimento delle donne proletarie sceglie un'altra via, determinandosi come parte integrante del movimento operaio in generale.
Numerosi lavori sono stati scritti in tutte le lingue sul movimento femminista borghese. Ma la storia della lotta delle donne lavoratrici per la difesa dei loro diritti come membri della classe operaia e produttori di uguale valore per l'economia nazionale, assicurando inoltre la riproduzione della specie, questa storia non è stata ancora scritta. Troviamo sparsi qua e là in alcune opere che riferiscono sulla lotta e sulla storia della classe operaia, solo alcuni fatti isolati. Ma queste informazioni bastano a mostrarci come le donne proletarie, lentamente ma inesorabilmente, riuscirono a conquistare un settore lavorativo dopo l'altro e ci forniscono informazioni anche sulla presa di coscienza crescente delle donne, allo stesso tempo come membri di una classe data e come individui. Queste informazioni ci permettono di osservare come le lavoratrici si associarono alla lotta della classe operaia nel suo insieme e come hanno difeso rivendicazioni proprie della loro situazione. Ma il libro che tratta a fondo questo tema e che descrive il difficile cammino percorso dalle donne fino al loro riconoscimento definitivo come membri a pieno titolo del proletariato, non è ancora stato scritto.
Il movimento delle donne proletarie è ovviamente strettamente ed indissolubilmente legato al resto del movimento operaio di cui è una parte costituente e organica. Commetteremmo lo stesso errore delle femministe se continuassimo a negare la differenza tra le donne e gli uomini del proletariato, se affermassimo semplicemente che avendo uno solo e stesso scopo - il comunismo - sarebbero, a causa dei loro interessi di classe comuni, in accordo perfetto e in armonia perfetta. Ma, occorre assolutamente mettere l'accento sulle differenze anatomiche della donna e sulla sua capacità di partorire (quest'ultimo compito sociale continuerà a cadere su di lei, anche quando l'uguaglianza dei diritti sarà definitivamente acquisita). Il fatto che la donna non è soltanto cittadina e forza lavoro, ma il fatto che mette anche bambini al mondo, la metterà sempre in una situazione particolare. È ciò che le femministe rifiutarono di comprendere. Il proletariato non può permettersi di ignorare questa realtà essenziale quando si tratta di elaborare nuovi modi di vita.
Ritorneremo ora al ruolo della donna borghese nei paesi capitalisti e proseguiremo la nostra descrizione dello sviluppo del movimento femminista.
Abbiamo appena evidenziato che il capitalismo riproduce al suo interno numerose contraddizioni e antagonismi. L'attuale situazione della donna è una di queste contraddizioni. Questo vale anche per le donne della classe borghese, anche se la maggior parte di loro continua a giocare alle cortigiane legali e a rifugiarsi "dietro le spalle" del proprio marito. E' tuttavia vero che sono sempre più numerose a invadere il mercato del lavoro e che il complicato meccanismo della produzione capitalista ne ha sempre più bisogno, sia nell'amministrazione pubblica che in quella privata. Questa crescente domanda non è certamente solo dovuta alla competizione tra il prezzo più basso della manodopera femminile rispetto alla manodopera maschile, ma anche perché le donne sono generalmente più flessibili e più coscienziose dei loro colleghi maschi.
Se la produzione attuale nelle grandi imprese non può più assolutamente fare a meno della forza lavoro femminile, la società borghese, che si crogiola sulla proprietà privata, ancor più non può fare a meno dell'istituzione della famiglia. L'espansione del lavoro femminile e l'indipendenza economica crescente della donna contribuiscono alla sua emancipazione. La famiglia non resiste a questo processo e si disgrega inesorabilmente.
La borghesia o più precisamente il capitalismo, attrae le donne fuori dal loro focolare e le integra nella produzione. Ma la legislazione borghese allo stesso tempo rifiuta di tenere conto di questo nuovo fatto. Il diritto borghese continua a basarsi sulla dipendenza della donna, come se fosse sempre sotto il controllo del "sostegno familiare" del marito, responsabile di difendere al massimo i suoi interessi. Questa legislazione non consente mai di considerare la donna come una persona autonoma, che è e rimane un semplice complemento, un'appendice del proprio marito. Una situazione alla fine che è ovviamente intollerabile. Milioni di donne guadagnano la loro sopravvivenza pur non avendo alcuna possibilità di difendere i propri interessi di fronte allo Stato, poiché questi si rifiuta semplicemente di concedere loro la maggior parte dei diritti riservati ai cittadini maschili.
La lotta per il diritto di voto e per l'eleggibilità, fu la rivendicazione principale delle femministe negli anni 60 dell'Ottocento.
Le Americane furono le pioniere di questo movimento. Parteciparono attivamente alla guerra d'Indipendenza degli Stati Uniti e lottarono per l'abolizione della schiavitù. Questa guerra fu una battaglia decisiva tra gli Stati feudali del Sud e gli Stati capitalisti del Nord. I nordisti guadagnarono la vittoria e gli Stati Uniti d'America divennero un paese dove prosperarono il capitalismo e la schiavitù salariata. La schiavitù dei Neri fu abolita per decreto. Come sempre in questi tipi di conflitti sociali, le donne parteciparono in modo particolarmente attivo alla guerra civile. La nuova Costituzione ha esteso i diritti del governo centrale e le donne naturalmente hanno lottato per ottenere la soddisfazione delle loro rivendicazioni. "Se il Nero è riconosciuto come un essere umano libero e indipendente, perché la donna, che ha contribuito all'abolizione della schiavitù, dovrebbe essere l'unica a non godere di tutta la sua autonomia di fronte alla legge?" Tuttavia, il Parlamento borghese del Congresso degli Stati Uniti famoso per il suo "amore per la libertà e la democrazia", si guardò bene di accordare alla donna uguali diritti. Questa era la situazione poco dopo la fine della Guerra d'Indipendenza e oggi non è cambiato molto. Le donne non sono ancora state in grado di ottenere il suffragio a livello di governo centrale. Lo detengono solo a livello degli Stati federali.
Sulla scia degli Stati Uniti, sorse in Inghilterra un formidabile movimento femminista in lotta per il diritto di voto. Le femministe, che ora lavoravano in ogni tipo di libera professione, spostarono l'obiettivo della loro lotta e lo rinviarono principalmente al diritto di eleggibilità. È su questo tema che vennero fondate tutte une serie di organizzazioni femminili. Le femministe in diversi paesi organizzarono azioni congiunte e a partire dal secolo scorso, congressi internazionali delle donne. Hanno bombardato i parlamenti borghesi con petizioni e inondato il mercato letterario con libri, opuscoli e proclami riguardanti il suffragio universale delle donne. Quando questa "tattica pacifica" si rivelò inefficace, le femministe adottarono i metodi delle suffragette. Le militanti femministe borghesi erano ben note nei primi anni di questo secolo e lo furono fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Occorre tuttavia porre l'accento sul fatto che, in diversi paesi, queste stesse femministe che affermavano la rappresentanza della maggioranza delle donne nella loro lotta per i diritti politici, quando ebbero realmente la possibilità di opporsi all'introduzione del sistema elettorale delle tre classi, accettarono quest'ultimo e permisero che le donne proletarie fossero private del loro diritto al suffragio.
Durante la guerra mondiale le attività delle femministe diminuirono. In alcuni paesi, sotto la pressione delle tempeste rivoluzionarie che scuotevano l'Europa dopo la guerra e in particolare a causa della Grande Rivoluzione operaia russa, la borghesia fu costretta a cedere in alcuni settori. È per questo che in Inghilterra, in Svezia e in Germania, la borghesia accordò alle donne il loro diritto di voto così ardentemente desiderato, come pure la possibilità di partecipare agli affari dello Stato. Rivisitarono il codice sul matrimonio e il diritto relativo all'eredità e ciò in modo da garantire gli interessi della donna borghese all'interno della famiglia. Siamo arrivate lì, ma non oltre. Con queste riforme, un grande numero di rivendicazioni che le femministe avevano considerato risolutive della "questione femminile", fu così soddisfatto. Ciò ci mostra chiaramente che il problema non può essere regolato da una semplice applicazione formale dell'uguaglianza di diritti, ma che l'intera faccenda è molto più ampia e complessa.
In molti paesi capitalisti borghesi, la donna usufruisce ora degli stessi diritti politici dell'uomo. Il diritto al lavoro in gran parte è stato conquistato. In tutte le nazioni le donne beneficiano inoltre della possibilità di proseguire negli studi superiori. Le relazioni tra l'uomo e la donna, tra genitori e figli, testimoniano l'importanza dei diritti acquisiti dalla donna. Tuttavia "la questione femminile", rimane irrisolta. Il riconoscimento formale di questi diritti nel capitalismo e nella dittatura borghese non la dispensa affatto di vivere, in realtà, la vita a servizio della propria famiglia, non le garantisce alcuna protezione contro pregiudizi e costumi della società borghese, non la libera dalla dipendenza di suo marito, né in ultima analisi - e questo è determinante - dallo sfruttamento capitalista.
Il movimento femminista borghese è entrato in un vicolo cieco. Le organizzazioni rivoluzionarie del proletariato sono le sole ad indicare la via che possono intraprendere le donne lavoratrici. Ma, inizialmente, le operaie, non più degli operai, non compresero che l'obiettivo finale del movimento operaio portava con sé la risoluzione alla "questione femminile". È soltanto poco a poco e attraverso esperienze faticosamente conquistate, che la classe operaia prese coscienza del fatto che non esistevano nell'ambito del proletariato contraddizioni antagoniste, né conflitti di interessi. Già, grazie alla meccanizzazione del lavoro, le attività che erano rimaste diverse si stavano uniformando, cosicché gli operai e le operaie hanno oggi interessi e obiettivi simili. Il proletariato è un'unità. È una classe che non ha spazio per una guerra tra i sessi e la liberazione delle donne fa parte dei suoi obiettivi a lungo termine.
Il movimento femminista borghese si sviluppò a partire dalla parola d'ordine: "Uguaglianza di diritti". La prima parola d'ordine delle operaie fu: "Diritto al lavoro". Negli anni 1850, le operaie lottarono per le seguenti rivendicazioni:
- Accesso ai sindacati nelle stesse condizioni dei colleghi maschili.
- A lavoro uguale, uguale salario.
- Protezione del lavoro femminile (questa rivendicazione apparve alla fine della XIX secolo.)
- Protezione generale della maternità.
Nessuna di queste rivendicazioni è in contraddizione con gli interessi di classe del proletariato, al contrario, esse sono tipicamente proletarie. La lotta per il diritto al lavoro caratterizzava già le azioni contro le organizzazioni corporative del XVIII secolo, non fu tuttavia condotta esclusivamente da operaie, ma dalla totalità degli operai non qualificati, uomini e donne. È anche del tutto corretto considerare l'affiliazione delle donne nei sindacati come un dovere della classe lavoratrice. La rivendicazione di uguale retribuzione per un lavoro uguale è sempre stata alla base delle lotte salariali della classe operaia e ha determinato la politica salariale. Dovete tuttavia tenere conto del fatto che una classe, poco dopo la sua nascita, riconosce soltanto di rado dove stia il suo vero interesse. L'insufficiente esperienza e le false prospettive conducono naturalmente a commettere gravi errori. Ma, grazie alla propria esperienza di lotta, si acquisisce una coscienza solida e sicura e una maturità di giudizio sul piano politico e sociale. Con lo sviluppo del lavoro femminile, il proletariato incontra anche queste difficoltà, prima di prendere posizione a favore di questi problemi.
La storia del proletariato brulica di aneddoti che mostrano che le lavoratrici, ogni volta che riuscivano ad entrare in un nuovo settore di produzione, incontravano grandi difficoltà ad ottenere dai loro fratelli di classe un comportamento da compagni. Le difficoltà delle operaie erano molto più grandi di quelle delle donne borghesi quando lottavano per il loro accesso agli studi universitari. In innumerevoli settori industriali (ad esempio nell'industria meccanica, la tipografia, ecc., che impiegano una manodopera qualificata), l'arrivo delle operaie nella produzione fu attivamente contrastato dai loro colleghi maschi. Numerosi sindacati sancivano nei loro statuti "l'esclusione della manodopera femminile non qualificata, responsabile del deterioramento dei redditi degli operai". Sindacati potenti forzarono i padroni a rinunciare all'occupazione delle donne. Alcuni gruppi di lavoratori furono ancora più estremisti e vietavano in modo totale che le donne aderissero ai loro sindacati. Dobbiamo tuttavia renderci conto che questa tragica situazione, che naturalmente minacciava l'unità della classe operaia, aveva cause comprensibili. L'insufficienza di formazione professionale impediva alle operaie di accedere ad alcuni settori, come alle donne borghesi di esercitare libere professioni. E le donne continuano ad offrire la loro forza lavoro non qualificata e dunque meno costosa.
Il problema era particolarmente acuto nel settore meccanico. Ma appena si richiedeva una competenza professionale, le donne non avevano più nessuna possibilità. È per questo che il problema della qualificazione professionale rimane in tutto il mondo un terribile handicap per le donne, poiché, da questo punto di vista, le cose non sono cambiate molto da allora.
Gli operai, che temevano la concorrenza del lavoro a buon mercato delle donne, si spinsero fino a richiedere leggi che limitavano il lavoro delle donne. Quando negli anni 1840 apparve un movimento spontaneo in lotta per la protezione del lavoro, la rivendicazione degli operai riguardava soprattutto la regolamentazione indispensabile del lavoro di donne e bambini. La maggior parte di loro naturalmente sosteneva queste rivendicazioni, ma per ragioni che erano tutto, tranne che generose. Speravano in questo modo di potere limitare la concorrenza del lavoro sottopagato delle donne e dei bambini. Le operaie, tuttavia, non hanno mai cercato di escludere le donne sposate dalla produzione.
Ma la dinamica delle forze produttive fu più forte della volontà e dei desideri di individui isolati o anche di intere organizzazioni. Non era più possibile fare a meno del lavoro femminile. Successivamente, gli operai riconobbero che non restava loro diversa soluzione che trasformare questo indesiderato concorrente nel mercato del lavoro in un alleato fedele alla loro lotta contro il capitale. Anziché proibire l'accesso delle donne ai sindacati ed escluderle dalla produzione come era stato, cercarono da quel momento di includerle nelle loro organizzazioni e ottenere la loro adesione. Attualmente, i sindacati in Europa, negli Stati Uniti e in Australia e parzialmente, anche in Asia, raccolgono milioni di aderenti. I sindacati cinesi e indiani restano i soli a dare prova di cattiva volontà nei confronti delle donne. Ma in Giappone, le operaie sono già organizzate con gli uomini.
Finché i sindacati proibivano l'accesso alle donne, queste furono naturalmente obbligate a creare proprie organizzazioni. I sindacati di donne riunirono numerose aderenti, soprattutto in Inghilterra, ma esistevano anche in Francia, in Germania e in America. Tuttavia da quando il movimento operaio ha acquisito una coscienza di classe rivoluzionaria, le barriere tra lavoratori e lavoratrici si sono allontanate e i sindacati di donne si sono fusi al resto del movimento operaio in un flusso potente e unito.
Il proletariato iniziò a riconoscere che la donna aveva diritti uguali come schiavo salariato e membro della totalità della classe operaia. Inoltre, a causa della sua funzione materna, il proletariato era costretto a difendere i diritti delle donne e ciò nell'interesse delle future generazioni. È per questo che attualmente cerca di ottenere una legislazione che garantisca la protezione delle lavoratrici.
Da quando la classe operaia si è raggruppata in un partito e ha iniziato ad adottare una politica autentica di lotta di classe, la necessità delle lavoratrici di elaborare il loro programma di rivendicazioni è scomparsa. "A lavoro uguale, salario uguale" ha trovato una risonanza generale. Anche i partiti socialisti moderati hanno integrato nel loro programma la lotta per la protezione del lavoro delle donne e dei bambini. Siamo costretti a riconoscere tuttavia che la conquista definitiva dell'uguaglianza dei diritti della donna e della sua liberazione non è possibile sotto il capitalismo. Il problema della donna può trovare una soluzione pratica soltanto nel sistema di produzione in cui la donna è interamente riconosciuta come forza di lavoro utile e necessaria, che lavora non solo per migliorare il benessere della propria famiglia, ma per quello dell'intera società.
La liberazione definitiva e totale della donna è possibile solo nel comunismo. Questo è anche il motivo per cui la parte più cosciente del proletariato femminile internazionale è entrata nelle fila del partito comunista. Ora dobbiamo fare i conti con un fatto estremamente importante che non possiamo assolutamente eludere. Mentre la maggioranza del proletariato riconobbe solo tardi la lotta per la liberazione della donna come parte integrante della lotta di classe, l'avanguardia della classe operaia - i socialisti - lo aveva compreso sin dall'inizio. I socialisti utopisti dell'inizio del XIX secolo - Saint-Simon, Fourier e altri seguaci - stavano già discutendo della "questione femminile". Gli utopisti non potevano naturalmente scoprire le vere ragioni dell'oppressione delle donne, cioè erano incapaci di riconoscere che la schiavitù della donna era nata proprio perché aveva cessato di produrre un lavoro utile e produttivo per l'insieme della comunità. Ecco perché non hanno considerato una soluzione alla questione femminile, il suo lavoro obbligatorio per la società. Ai loro occhi, la donna rimaneva moglie o compagna, cioè in un modo o nell'altro "l'amica" dell'uomo e non una forza lavoro produttiva autonoma.
Se il grande merito degli utopisti fu di introdurre il dibattito sull'uguaglianza della donna in modo vigorosamente polemico, non fu però l'unico, poiché non si accontentava di analizzare il ruolo della donna nel lavoro e dinanzi alla legge, ma pose anche la questione della sua situazione nel matrimonio. Claude Henri de Rouvroy conte di Saint-Simon, attaccò vigorosamente "la doppia morale" che imperversava nell'ambito dell'ipocrita società borghese. Le posizioni degli utopisti sull'uguaglianza tra i sessi, l'amore, il matrimonio e libertà di sentimenti" furono riprese da tutta una serie di donne nel corso della XIX secolo. Queste donne rifiutavano in modo costante di partecipare al movimento femminista borghese perché ritenevano che la "questione femminile" fosse un affare molto più vasto e complesso, che non si sarebbe risolto semplicemente con l'accesso delle donne alle università o alle urne. Fra le rappresentanti più affascinanti e combattive per il diritto delle donne "alla libertà di sentimenti", occorre citare George Sand, scrittrice rivoluzionaria francese che partecipò attivamente ai moti del 1848, come pure la prima giornalista americana, Margareth Fuller. Furono del resto contemporanee. È soprattutto grazie alla sua influenza personale che Margareth Fuller ha influenzato in modo decisivo questi aspetti della questione femminile e non tanto per la profondità e la maturità dei suoi scritti.
Robert Owen - utopista senza dubbio, ma in ogni caso molto pratico - riconobbe, come fondatore del movimento comunitario in Inghilterra, l'importanza della collaborazione delle donne. Nella sua prima comunità ci furono molti seguaci femminili. Se vi interessa l'argomento, vi consiglio di leggere sia Dobroliubov o anche il lavoro di Sidney e di Beatrice Webb sui sindacati, dove viene menzionato Robert Owen.
Il Manifesto del partito comunista di Karl Marx e Friedrich Engels (ndt 26) analizza scientificamente la questione femminile sotto l'aspetto della famiglia e del matrimonio. L'opera di Friedrich Engels: L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato (ndt 27), approfondisce e sviluppa le argomentazioni del Manifesto, mentre Karl Marx, nel Capitale, tratta un'altra questione, cioè che l'estensione del lavoro alle donne e lo sfruttamento di quest'ultimo da parte del capitale, sono un prodotto del processo di concentrazione nel sistema capitalista. (ndt 28)
In questo contesto, la "questione femminile" cessò di essere un aspetto puramente pratico della lotta di classe e d'ora in poi ebbe il suo supporto teorico nella lotta di liberazione proletaria.
La Prima Internazionale mise all'ordine del giorno le questioni relative al lavoro delle donne quando elaborò le sue rivendicazioni pratiche. Karl Marx giudicò rigorosamente la proposta dell'ala destra e piccolo-borghese dell'Internazionale che esigeva la limitazione del lavoro delle donne in favore della famiglia. Naturalmente, la vera intenzione alla base di questa proposta era di limitare la concorrenza nel mercato del lavoro. Ma la Prima Internazionale ha riconosciuto che il lavoro delle donne era inevitabile e ha difeso la situazione delle donne come madri chiedendo una riforma delle leggi per la protezione della loro forza lavoro e della loro salute. Poiché la Prima Internazionale riconobbe la necessità sociale del lavoro delle donne, enfatizzando sia l'importanza della liberazione della donna, sia la sua funzione di madre, adottò, sin dall'inizio, una posizione coerente e giusta sulla questione femminile. Possiamo constatare con ciò quanto la classe operaia si separasse profondamente dalle femministe e quanto le loro posizioni sulla questione femminile fossero divergenti. Le femministe si impegnarono esclusivamente per l'ideale egualitario. La classe operaia, d'altro canto, era convinta che la liberazione della donna comportasse in realtà due aspetti e che non erano i diritti astratti qualsiasi che avrebbero migliorato la situazione della donna, al contrario. Si può aggiungere che questi diritti cambieranno totalmente la vita della popolazione attiva. La parità dei diritti e la protezione legale della madre erano le due esigenze essenziali e l'obiettivo a lungo termine dei comunisti, l'avanguardia del proletariato nella "questione femminile".
Negli anni 1870, fu pubblicato il libro di Auguste Bebel: La Donna e il Socialismo (ndt 29) , tradotto successivamente in tutte le lingue, anche in cinese e in giapponese. Solo in Germania ci furono più di cinquanta edizioni. Questo successo è sufficientemente eloquente. Si può persino arrivare al punto di dire che questo libro è diventato per la lavoratrice, la verità del vangelo. Tutto ciò che fino ad allora era stato sfiorato dalle opere di Marx e di Engels e che è sempre stato la politica della Prima Internazionale per quanto riguarda la "questione femminile", Bebel lo formulò in modo non soltanto preciso, popolare e comprensibile, ma sviluppò anche queste tesi sulla base di un materiale storico impressionante. Bebel dimostrò definitivamente che il compito storico della classe operaia è indissolubilmente legato a quella della liberazione della donna. Indicò anche il cammino che conduce a questa liberazione: è la vittoria della classe operaia e la realizzazione del sistema comunista. Bebel affrontò tutti gli aspetti della "questione femminile" e non esitò a mettere il naso nella famiglia borghese e nell'ipocrisia della sua morale sessuale. Spiegò la prostituzione come un fenomeno sociale e provò anche che questo problema era in diretta relazione con la divisione della società in classi e con lo sfruttamento della forza lavoro da parte del capitale. Tuttavia, il suo contributo più importante fu di avere formulato con precisione il doppio compito della classe operaia nel processo che conduce alla liberazione della donna, un doppio compito che si riassume con queste parole: unità di lotta. Unità per le lotte sia a breve termine che a lungo termine e dove designa senza ambiguità i compiti particolari che spettano alla classe operaia riguardo alle madri. Questo movimento di donne proletarie è subordinato alla lotta unitaria del movimento operaio. Le sue rivendicazioni particolari rafforzano e sviluppano il movimento operaio stesso.
Il lavoro di Bebel esercitò una grande influenza e fu particolarmente utile per le donne della Seconda Internazionale che esitavano sul cammino da seguire per il movimento delle donne proletarie.
A partire dagli ultimi dieci anni del secolo scorso, il numero delle aderenti al movimento delle donne proletarie aumentò considerevolmente. Le lavoratrici unirono strettamente le loro lotte a quelle della classe operaia, entrarono nei sindacati e nei partiti socialisti e parteciparono attivamente agli scioperi, ai movimenti di massa, alle manifestazioni e ai congressi mondiali.
All'epoca della Prima Guerra mondiale, il proletariato poteva contare su circa un milione di lavoratori organizzati. Nei partiti socialisti, le donne appartenevano molto spesso alla tendenza di sinistra.
Mentre le idee socialiste si diffondevano e si stabilizzavano, molte donne politicamente attive si unirono all'ambito del movimento operaio. Alcune fra loro diventarono modelli per il movimento socialista, attraverso la loro pratica e attraverso le loro opere teoriche. Conoscete certamente nomi come Louise Michel - organizzatrice e agitatrice entusiasta e disinteressata della lotta di classe nella Comune di Parigi - o anche Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Henriette Roland-Holst e Angelica Balabanov. Il loro impegno nella lotta per il comunismo di allora è ampiamente riconosciuto e i loro nomi, soprattutto grazie alle loro notevoli azioni in relazione alla fondazione della Terza Internazionale, sono passati alla storia.
La recente storia russa è ricca di donne che hanno rotto senza esitare con le tradizioni e i valori borghesi e che furono, a partire dagli anni 1870, audaci attiviste della lotta rivoluzionaria. La storia dei partiti rivoluzionari della Russia e i cui inizi coincidono con la formazione del proletariato russo, testimonia l'esistenza di numerose donne, della loro forza interiore, del loro disinteresse e della loro determinazione rivoluzionaria. Bardina ad esempio, la prima donna socialista della Russia, "andò al popolo" con la ferma intenzione di seminare fra le masse ignoranti e completamente private dei loro diritti, la buona parola dell'avvento della giustizia sociale, vale a dire del socialismo. Fu seguita dalle intrepide sorelle Subbotina, la risoluta Lesjern e l'altruista Liubotovitch. Né la prigione, né l'esilio, né la morte riuscirono a scuotere la ferma convinzione di queste pioniere del socialismo che lottavano per la liberazione del popolo dei lavoratori.
Negli anni 1880, incontriamo degne successori fra le audaci terroriste, tra cui Sofia Perovskaia, donna di grande tenacia. La sua personalità era una felice sintesi tra un'intelligenza maschile e un "io" estremamente femminile; mise tutto il suo calore e tutto il suo ardore al servizio della Rivoluzione. Al suo fianco appare l'operaia Gessie Helfinan, che morì sotto tortura zarista. Vera Figner, Wolkenstein e Vera Zassoulitch sono altre eroine e martiri della Rivoluzione e non furono le sole. (Il gruppo Emancipazione del lavoro, a cui dobbiamo la diffusione del marxismo nella Russia zarista, non comprendeva solo uomini come Pavel B. Axelrod e Georgij Plekhanov fra i suoi fondatori, ma anche una donna, Vera Zassoulitch. Le sue opere scientifiche hanno conservato fino ai nostri giorni il loro valore per la teoria marxista.)
Con la nascita della Terza Internazionale, il movimento delle donne proletarie diventò definitivamente un aspetto della lotta rivoluzionaria organizzata della classe operaia. Fu evidente in modo esplicito in occasione del I Congresso della Terza Internazionale nel 1919.
Mentre si rafforzerà il movimento operaio rivoluzionario e perseguirà obiettivi sempre più elevati, il movimento delle donne prospererà nel suo ambito e sarà altrettanto capace, nel periodo della dittatura proletaria, di risolvere il nodo gordiano della "questione femminile" e riuscire dove la società borghese è così penosamente fallita. Mentre ci avviciniamo alla vittoria della classe operaia e al trionfo del sistema comunista, il futuro della donna si schiarisce. La prossimità di questo futuro e l'emancipazione definitiva dipende solo dalla donna stessa, dal grado della sua coscienza politica e della sua attività rivoluzionaria. (ndt 30)
Ma prima di terminare la nostra conferenza di oggi, certamente più lunga del previsto, ci chiederemo un'ultima volta se è possibile che la donna possa tornare di nuovo ai suoi fornelli e alla ristretta cerchia familiare. Oltre al fatto che i lavori domestici tradizionali scompaiono e diventano completamente superflui, c'è un'altra ragione importante perché una simile sviluppo sia diventato completamente impossibile: l'evoluzione costante delle forze produttive. Poiché con essa aumenta incessantemente la domanda di nuova forza lavoro. L'evoluzione della tecnica e ogni nuova invenzione comportano inevitabilmente un aumento della domanda di forza lavoro e ciò in tutti i settori della sua applicazione.
Le tendenze dello sviluppo economico sono tali che, a prima vista, non può esistere una forza lavoro in eccesso. L'umanità è ancora molto distante dal regno del superfluo. Resta a un livello relativamente basso del suo sviluppo e le innovazioni nelle aree della cultura sono accessibili sempre e soltanto ad una infima minoranza.
Finché il fabbisogno di forza lavoro umana aumenterà, la domanda di manodopera femminile non farà che aumentare. Il lavoro delle donne è oggi già una necessità nell'economia nazionale. Vi sarà facile immaginare la catastrofe economica che deriverebbe dal ritiro - artificiale - di settanta milioni di donne europee e americane dalla produzione. Ciò comporterebbe naturalmente il caos più totale in tutto il mondo e la rovina e la scomparsa di settori interi della produzione.
Nel XX secolo il lavoro delle donne è arrivato a rappresentare una parte importante della produzione e non c'è nessuna argomentazione convincente capace di spiegare il perché i fattori che hanno innescato la crescita del lavoro femminile dovrebbero essere respinti. Con il passaggio alla dittatura del proletariato e alla produzione comunista, il lavoro delle donne si è definitivamente imposto nell'economia nazionale. L'esempio della Russia ce lo dimostra con tutta la chiarezza auspicata: "Chi non vuole lavorare non deve neppure mangiare", dice la principale parola d'ordine comunista. Nella repubblica operaia, il lavoro diventa dunque un dovere civico. Alle condizioni attuali, il ritorno della donna nella stretta cerchia della famiglia e la sua regressione a uno status precedente senza diritti è diventato completamente impossibile.
La situazione della donna, il suo significato e i suoi diritti sociali sono dunque determinati dal suo ruolo economico. È il filo rosso conduttore che attraversa tutte le nostre conferenze.
Possiamo dunque concludere con certezza che i giorni dell'assenza di diritti, della dipendenza e dell'oppressione ormai sono contati. Il comunismo, che libera la produzione sotto la condizione del lavoro diffuso, libererà definitivamente le donne.
* * *
ndt:
26) Per capire si legga: Il Manifesto del partito comunista di Karl Marx e Friedrich Engels - Testo messo a disposizione da Edizioni La Città del Sole - conversione in html a cura del CCDP su Resistenze.org
27) Per approfondire si legga: Friedrich Engels - L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato - A 110 anni dalla scomparsa di Friedrich Engels - trascrizione e conversione in html a cura del CCDP su Resistenze.org
28) Per approfondire si legga: Karl Marx, Il capitale, Editori Riuniti, Roma, 1974 - Libro Primo - Capitolo tredicesimo Macchine e grande industria, 413 - 3. Effetti immediati dell'industria meccanica sull'operaio, 437 a) Appropriazione di forze-lavoro addizionali da parte del capitale. Lavoro delle donne e dei fanciulli, 437 - Su Resistenze.org Le opere complete di Marx-Engels nella biblioteca digitale Mels
29) Indispensabile leggere: Bebel, La Donna e il Socialismo - Biblioteca digitale Mels - resistenze.org
30) per approfondire l'argomento: "Il processo «bloccato» di emancipazione femminile nella pratica sovietica" di Cristina Carpinelli pubblicato su Resistenze.org
Nona conferenza - Il lavoro delle donne durante la guerra
Oggi analizzeremo il lavoro delle donne durante la dittatura del proletariato. Possiamo, grazie alla visibile esperienza della Grande Rivoluzione russa, convincerci che ogni passo verso il comunismo avvicina effettivamente le donne alla loro totale e universale liberazione. Ma prima di affrontare la situazione delle donne nella repubblica proletaria dei soviet, dobbiamo ancora analizzare brevemente il periodo della Grande Guerra mondiale imperialista, un periodo che ha preparato il terreno alla dittatura del proletariato.
La guerra del 14-18 era stata fino a quel momento la guerra più sanguinosa nella storia dell'umanità. Vi parteciparono i maggiori Stati d'Europa e d'America. La società borghese capitalista venne scossa nelle sue fondamenta e la produzione capitalistica completamente destabilizzata. Milioni di lavoratori furono strappati dai loro luoghi di lavoro e gettati nei campi di battaglia. Ciò nonostante non doveva in alcun modo avvenire una limitazione della produzione. Al contrario.
Il carattere della produzione si modificò notevolmente. Al posto dei beni di consumo ordinari, l'industria si mise a produrre macchine da guerra e di morte. Ogni paese aveva bisogno, per vincere, di un'industria di armamenti in espansione che garantisse la produzione di esplosivi, di cannoni eccetera. L'esito della guerra sarebbe potuto essere favorevole solo se vi fosse stato un legame organico continuo tra fronte e retroguardia. Questo perchè il destino degli eserciti non si decideva solo sul campo di battaglia. La corsa agli armamenti tra i vari paesi era almeno altrettanto importante. L'ampliamento della produzione presupponeva un potenziale sufficientemente ampio in termini di forza lavoro. Poiché l'industria bellica era un ramo della produzione della grande industria capitalista, essa impiegava anche manodopera non qualificata. Così dopo la mobilitazione generale, le donne, le figlie, le sorelle e le madri dei soldati occuparono i posti rimasti vacanti nelle officine. Abbandonate da coloro che "sostenevano economicamente la famiglia", le donne si affrettarono a provvedere al proprio mantenimento. I padroni accolsero a braccia aperte questa manodopera a buon mercato, da un lato perché le donne sostituivano perfettamente gli uomini che erano in fondo alle trincee, dall'altro perché aumentavano i profitti. In questo periodo, tra la dichiarazione di guerra e la smobilitazione, registriamo un aumento costante del lavoro femminile. Lo stesso vale per i paesi neutrali per i quali la Prima Guerra mondiale è stata un ottimo affare. Per questo motivo essi integrarono naturalmente tutta la forza lavoro disponibile, uomini e donne, nella produzione.
La situazione della donna nella società si modificò in modo prodigioso. La società borghese, che fino ad allora aveva insistito sul fatto che le donne occupassero il loro giusto posto in casa, esaltava adesso il «patriottismo» delle donne pronte a diventare «soldati nelle retrovie» e a svolgere un lavoro nell'interesse dell'economia e dello Stato. E intellettuali, politici e abili giornalisti fecero coro unanime con i membri della classe dominante per chiedere alla donna di "compiere i suoi doveri civici" e raccomandarle di non indugiare troppo "in cucina" o "con i figli", in quanto era meglio per lei servire la patria, il che significava chiaramente che era meglio per lei vendere al ribasso la propria forza lavoro ai trust delle armi. Il lavoro delle donne si è imposto in tutti i settori dell'industria. Era soprattutto il più diffuso nell'industria metallurgica, nella produzione di esplosivi, uniformi e conserve alimentari, prodotte direttamente per il fronte. Ma anche altri ambiti furono invasi dalle donne, settori che fino ad allora erano stati loro completamente vietati. Basti ricordare come, durante la guerra, le vediamo comparire nei ruoli di conducenti di tram e di treni, nonché autisti di taxi, facchini, guardiani, scaricatori e camionisti femminili. Molte donne lavoravano nelle miniere o nei cantieri edili e svolgevano lavori faticosi e dannosi per l'organismo femminile. Il numero delle impiegate nei servizi pubblici, come ad esempio le poste, si moltiplicò all'infinito. Le donne svolgevano i loro compiti con tutta la coscienza e la serietà dei neofiti, ossia il meglio possibile. Tra il 1914 e il 1918 il lavoro delle donne aumentò tra il 70 e il 400 per cento nei vari settori. Nell'industria metallurgica tedesca tale percentuale è stata addirittura del 408%. In Francia il numero delle donne in questi ambiti è raddoppiato. In Russia, spesso, le donne rappresentavano la maggior parte della forza lavoro di molte professioni. Anche nelle compagnie ferroviarie russe, dove le donne erano tollerate prima della guerra solo come operatrici di pulizia o casellanti il numero delle donne raggiunse il 35% del personale. Anche in Francia milioni di donne dovevano lavorare nella produzione. In Inghilterra il numero delle operaie aumentò di un milione e mezzo e in Germania di due milioni. Nel complesso, il numero delle donne che lavoravano in Europa e in America aumentò di circa dieci milioni.
Le cause di questo sviluppo sono evidenti: da un lato, la mancanza di manodopera e dall'altro il basso prezzo di questa. L'incremento artificiale dei beni di consumo e la partecipazione degli uomini alla guerra hanno fatto precipitare le donne nel mercato del lavoro. Lo stipendio del marito non era più sufficiente per il mantenimento della famiglia. Non solo le donne sole - vedove di guerra, mogli di soldati richiamati e donne nubili, ma anche donne i cui uomini non erano ancora partiti in guerra - dovevano cercare un lavoro di complemento, dato che il denaro della famiglia non bastava a coprire i bisogni. Ora, in tutti i paesi e in tutti i settori dell'industria, i salari delle donne erano inferiori a quelli degli uomini. In generale, i salari delle donne nei quattro anni di guerra possono essere stimati a un terzo o a metà dei salari degli uomini. La miseria nera ha fatto precipitare le donne nelle fabbriche, nei laboratori, negli uffici e nei trasporti pubblici. Per aumentare i profitti i padroni non avevano scrupoli a sfruttare le lavoratrici. Il "sacro dovere della donna", la maternità e altre belle parole, la debolezza della donna rispetto all'uomo e quindi il fatto che fosse inammissibile che la donna lavorasse in mestieri maschili, tutto questo era stato completamente dimenticato. In ogni caso, se i padroni avessero mai avuto questo tipo di idee sulle proprietà particolari del "sesso debole", la loro rapacità e il richiamo del profitto avrebbero fatto in modo di dimenticarle presto. Ora erano fermamente decisi a trarre il massimo profitto da queste rappresentanti del sesso debole.
Le donne erano meno preparate degli uomini a difendere i propri interessi di classe. Erano meno coscienti e più inesperte. Mentre i padroni si riempivano le tasche, le donne erano convinte di lavorare per la patria. I padroni sfruttavano queste illusioni senza vergogna e assegnavano alle loro operaie solo una parte di ciò che gli operai avrebbero ricevuto per lo stesso lavoro. Se un operaio, ad esempio, veniva pagato 42 marchi a settimana, all'operaia ne toccavano solo 8. Se le donne lavoravano a cottimo, raramente i loro stipendi superavano un terzo di quelli dei loro colleghi maschi. Forse le donne si applicavano meno o lavoravano meno coscienziosamente? Assolutamente no. I padroni e i loro ideologi affermavano, d'altronde, che la produttività non aveva affatto sofferto del fatto che i lavoratori erano stati sostituiti dalle operaie. La minore produttività del lavoro femminile in alcuni settori è stata in gran parte compensata da una maggiore produttività in altri. Questa realtà è stata statisticamente dimostrata. In alcuni paesi, ad esempio in Italia, i padroni amavano assumere donne non solo perché non disponevano di manodopera maschile in quantità sufficiente, ma semplicemente perché le donne avevano la reputazione di essere "più docili e più accomodanti degli uomini" e perché ritenevano che fossero particolarmente adatte per lavori che necessitavano coscienza professionale, meticolosità e tenacia. Il re del cannone in Germania, Gustav von Bohlen und Halbach, disse senza mezzi termini: il "lavoro delle donne è la melodia del futuro". In molti luoghi i padroni organizzarono officine che occupavano solo donne e in cui la fabbricazione dei prodotti richiedeva una particolare abilità. I giornali borghesi destinati ai tecnici hanno intonato innumerevoli lodi sulla forza lavoro femminile, ponendo l'accento su un aspetto in particolare, sul fatto che le donne erano più adatte all'apprendimento degli uomini. Un ingegnere di nome Stern, ad esempio, scrisse: "Le donne sono molto più obbedienti, moderate e più desiderose di apprendere che i loro colleghi maschi." La stampa borghese ha persino richiesto durante la guerra il servizio di lavoro obbligatorio, una sorta di mobilitazione organizzata dei "soldati delle retrovie" e una formazione tecnica speciale per i settori bellici. Purtroppo, i padroni non furono gli unici a fare questo discorso, anche le femministe borghesi e i patrioti lo ripresero in coro, con in testa Lily Braun che reclamava l'introduzione di un servizio patriottico di guerra per le donne. All'epoca, nelle organizzazioni femminili borghesi si affermava: "È assolutamente urgente e necessario realizzare la mobilitazione di tutta la popolazione maschile e femminile." Le donne social-patriottiche della Germania e della Francia sostenevano senza riserve i capitalisti nei loro sforzi di sfruttamento della forza lavoro femminile. Il social-patriota francese, Albert Thomas, suggerì addirittura di trarre un vantaggio maggiore da questa forza lavoro. Ed è esattamente quello che è successo in Russia e in tutti i paesi vinti dalla guerra omicida..
Il fatto che le donne siano state integrate nella vita economica non è stato di per sé dannoso, né reazionario. Al contrario, è così che sono state migliorate le condizioni per la futura liberazione della donna. Non è stato il lavoro delle donne in sé, ma lo sfruttamento di quest'ultimo ad essere dannoso. Se i padroni realizzavano profitti sui bassi salari delle donne, sapevano anche usare abilmente il loro lavoro contro le organizzazioni e il lavoro maschile meglio pagato. Inoltre, essi aumentavano ulteriormente i loro profitti sfruttando le operaie al limite delle loro possibilità. Il lavoro notturno e gli straordinari erano la regola. Quasi tutte le leggi sulla protezione del lavoro femminile furono abrogate. Senza scrupoli, i padroni imponevano alle donne i lavori più dolorosi e dannosi per la loro salute. Fu allora che venne alla luce la natura deleteria e ripugnante del capitalismo. Nella sua insaziabile ricerca del profitto, non si preoccupava nemmeno di nascondere il proprio volto dietro buone intenzioni liberali. In Inghilterra le ore di lavoro straordinario sono state rese obbligatorie per le donne. Le giornate di lavoro hanno raggiunto le 12-15 ore. Il lavoro notturno era in quel momento la regola. La borghesia cessò di essere ipocritamente indignata per le conseguenze dannose del lavoro notturno, responsabile in particolar modo della "dissoluzione dei costumi familiari". Persino le poche leggi, così difficilmente conquistate dalla classe operaia per la protezione delle lavoratrici, furono annullate.
Nel tentativo di far abrogare queste leggi, i padroni della Russia zarista si mostrarono particolarmente cinici, mentre queste leggi non riuscivano già prima a frenare l'enorme appetito di questi signori. Il Congresso del comitato di guerra si pronunciò apertamente a favore di un maggior reclutamento di manodopera femminile, questo perché veniva privilegiata la manodopera meno costosa. Questi signori Gulschkow, Konowalow e Rjabuschinskij cominciarono chiedendo per "la durata della guerra" la rapida abolizione del controllo legale del lavoro di donne e bambini. In molte fabbriche della Russia lavoravano ragazze molto giovani di 12 e 13 anni. I padroni stranieri seguirono l'esempio della Russia. L'unica differenza era che il nostro profittatore russo non si nascondeva dietro le parole e riconosceva apertamente che aveva bisogno delle lavoratrici poco costose per "abbattere il lavoro" e non perché mancava manodopera maschile.
In altri paesi, invece, i magnati dell'industria nascondevano i loro "calcoli" dietro discorsi patriottici nebulosi. Le donne dovevano, da Giovanna d'Arco in poi, salvare la patria e impegnarsi al fronte come soldati, non a cavallo e con l'arma al pugno, ma in fabbrica, dietro una macchina, mentre i profittatori si riempivano le tasche.
Il lavoro delle donne è stato quindi considerato assolutamente inevitabile ovunque. Mentre erano nuove nel mercato del lavoro, le donne, durante la guerra, furono assunte in tutti i settori produttivi in cui si affermarono con decisione.
Ma, in realtà, cosa ne risultò per le stesse operaie? La loro situazione sociale era diversa? Avevano una vita migliore? Sappiamo già che il ruolo della donna nella società è determinato dal suo lavoro nella produzione.
Questa tesi è stata confermata durante la Prima guerra mondiale? Dobbiamo ricordare una volta per tutte che, sotto il dominio del capitalismo, non è il lavoro salariato che conta, ma solo il lavoro dell'"organizzatore", quindi del padrone. Ciò ci permetterà di capire che, nonostante il crescente numero di lavoratrici salariate, la situazione della donna nella società borghese non può in alcun modo migliorare. Al contrario, la situazione della donna lavoratrice durante la guerra è stata insopportabile. Gli orari di lavoro estremamente difficili e avendo cessato di essere limitati per legge, portarono ovunque a un peggioramento dello stato di salute e come è stato dimostrato statisticamente, ad un aumento della mortalità delle donne. La società borghese fu certamente preoccupata per la diffusione della tubercolosi e di tutta una serie di altre malattie, conseguenze dell'esaurimento generale, ma, eccitata dai profitti che realizzava grazie alla guerra, preferì allontanare lo sguardo da questi fatti sgradevoli qualificandoli come "inevitabili tributi di guerra". Le condizioni di vita delle operaie peggiorarono di giorno in giorno. L'intensificazione del lavoro, i ritmi infernali, le giornate interminabili e soprattutto l'inflazione permanente, abbassarono ancora il tenore di vita della classe operaia. Lo stile di vita borghese, da parte sua, non si modificò affatto. La famiglia tradizionale continuò ad esistere e le donne dovettero svolgere i compiti domestici loro assegnati come in passato. Quando finalmente, dopo una lunga ed estenuante giornata di lavoro, le operaie, impiegate, telefoniste o conducenti tornavano a casa, dovevano uscire immediatamente e prendere posto nelle code interminabili per comprare il cibo, la legna o il petrolio necessari per il pasto della famiglia. In ogni caso, le code davanti ai negozi erano la regola sia a Londra, che a Parigi, Berlino, Mosca o San Pietroburgo, insomma, assolutamente ovunque nel mondo. Il che costringeva le persone a lunghe e noiose ore di attesa. Molte donne si ammalarono e persero il controllo dei loro nervi. Le nevrosi e le malattie mentali si moltiplicarono, mentre l'inflazione provocava una denutrizione permanente. I neonati venivano al mondo privi di pelle, ciechi o rachitici. Morivano prima ancora di aver potuto distinguere la notte dal giorno. Le loro madri erano troppo stanche. E aggiunto a tutte queste privazioni fisiche, nascosto nell'ombra come una minaccia sorda, l'angoscia permanente per i propri cari - coniugi, figli o fratelli - partiti al fronte. E' stato uno spettacolo unico di desolazione: sangue e orrore al fronte; privazioni e lacrime in casa.
Ma cosa ha fatto la borghesia dopo aver pubblicamente espresso le sue lodi sulle "donne patriote"? La società borghese ha proposto, ad esempio, di alleviare la situazione delle lavoratrici in questi terribili anni? Dopotutto, il lavoro delle donne nelle retrovie aveva aumentato in modo decisivo le possibilità di successo della guerra. Se la borghesia avesse rifiutato di riconoscere i diritti della donna, avrebbe dovuto logicamente essere indotta almeno a proteggere le lavoratrici dal "doppio onere" che loro incombeva. Ma questo problema non è riuscito nemmeno a sfiorare le classi possidenti. Per tutta la durata della guerra, la borghesia non ha fatto praticamente nulla per alleviare la vita delle donne, né per liberarle dal peso dei loro compiti domestici. (Per i figli delle operaie l'unico aiuto si limitava alle opere private di beneficenza.) "Prima la guerra, poi faremo in modo di rimettere tutto in ordine. "
Tuttavia, il governo borghese offrì un'assistenza alle vittime di guerra, che migliorò in qualche misura le condizioni di vita delle donne dei soldati. Quindi vedove di guerra e orfani ottennero dallo Stato un aiuto regolare e godettero di alcuni diritti; per esempio, non pagavano l'affitto per la loro abitazione. Ma questa regolamentazione non interveniva tanto a favore delle donne, ma piuttosto per «sollevare il morale delle truppe». Nonostante la rendita che gli era concessa, la situazione della moglie di un soldato era ancora pessima. In Russia, questa rendita era ridicolmente bassa. Nell'aprile del 1917 - durante il governo provvisorio di Kerenski - mentre il minimo vitale era di diverse centinaia di rubli, le donne dei soldati non arrivavano a più di 79 rubli al mese.
La crescente mortalità infantile costrinse i governi inglese, francese e tedesco a concedere un certo aiuto alle madri sole. Ma questa attenzione era assolutamente insufficiente. Perché, in realtà, anche le madri di famiglia il cui marito era andato al fronte, vivevano in condizioni peggiori di un tempo. La borghesia non si occupava delle madri e dei loro figli in tenera età. Per questo motivo era altrettanto naturale che durante tutto il periodo della guerra le donne fossero particolarmente agitate. A partire dalla primavera del 1915, le operaie di Berlino organizzarono una massiccia manifestazione in direzione del Reichstag, dove cospirarono Karl Liebknecht e Philipp Scheidemann (ndt 31). Nella maggior parte dei paesi scoppiarono violente rivolte contro la guerra e l'inflazione. A Parigi, nel 1916, le donne assaltarono i negozi e saccheggiarono i depositi di carbone. Nel giugno del 1916, l'Austria conobbe una vera e propria insurrezione di tre giorni durante la quale le donne hanno protestato contro la guerra e l'inflazione. Dopo la dichiarazione di guerra e durante la mobilitazione, le donne si sdraiarono sulle rotaie per ritardare, anche solo di poche ore, la partenza dei soldati verso l'inferno della guerra e della morte.
In Russia, nel 1915, le donne sono state le istigatrici di disordini che si sparsero come una scia di polvere da sparo da San Pietroburgo e da Mosca in tutto il paese. Nello stesso periodo in cui i padroni avidi di profitti esaltavano il "patriottismo femminile" e impiegavano le donne nelle loro fabbriche, le operaie partecipavano attivamente ai movimenti per lo sciopero. La guerra non portò alle donne che un aumento di pene e di preoccupazioni, causa della loro "agitazione". Il 23 febbraio 1917 (l'8 marzo del vecchio calendario), le donne proletarie, in particolare le operaie del tessile di San Pietroburgo, si fecero avanti sulla scena storica ed espressero la collera crescente della classe operaia. Questa insurrezione fu il segnale di partenza per la grande Rivoluzione russa.(32 ndt)
Il 26 marzo 1915, a Berna, alcune donne socialiste si incontrarono - mi riferisco qui all'internazionalismo e non al nazionalsciovinismo - al Congresso internazionale delle donne, per cercare di spiegare insieme la rivolta delle lavoratrici contro la guerra e di trovare le linee di forza per la loro lotta contro la Guerra mondiale. Fu infatti il primo congresso internazionale dall'inizio della guerra. Permise di delineare due linee principali. La frazione maggioritaria condannò effettivamente la guerra, ma per questo si separò dai social-sciovinisti. La frazione minoritaria, i nostri bolscevichi russi, chiese la condanna dei traditori alla solidarietà internazionale del proletariato e si oppose inequivocabilmente alla guerra imperialista invocando la guerra civile.
Il fatto che si sia svolto il Congresso internazionale delle donne socialiste non è stato un caso. Basti ricordare la situazione sociale sempre più insopportabile delle lavoratrici durante la guerra.
Senza dubbio il lavoro della donna aumentava continuamente durante la guerra, ma in condizioni tali che, lungi dal migliorare la situazione delle lavoratrici, esse contribuirono ancor più ad aggravarla. Solo le donne degli speculatori e dei padroni e le donne appartenenti ai ceti sociali benestanti erano le uniche a beneficiare della guerra. In definitiva, furono gli strati parassitari della società ad accontentarsi di consumare e di lapidare il reddito nazionale e non di produrre, a trarre profitto dalla guerra.
Ora, i mali e le sofferenze del popolo operaio assunsero proporzioni sconosciute; la congiuntura della guerra favorì una rapida ridistribuzione di alcuni settori dell'industria e diede origine a massicce interferenze dove la meccanizzazione della produzione era estremamente sviluppata. Questo processo facilitò l'afflusso di lavoratrici non qualificate nella produzione. Il lavoro delle donne divenne così un fattore importante per l'economia nazionale, ormai bisognava fare i conti con esso e le organizzazioni economiche (sindacati padronali e operaie) riconobbero senza riserve l'importanza della manodopera femminile. Il lavoro delle donne occupava una nuova posizione. L'antica fraseologia sui doveri della donna «come moglie e casalinga» cessò anch'essa di avere corso.
Con la smobilitazione e il passaggio a un'economia di pace, nei paesi capitalisti si manifestano evidenti tendenze a respingere le donne dalla produzione. La disoccupazione femminile conosce una recrudescenza. Il fatto è che tutti i paesi avendo partecipato alla guerra furono colpiti negli anni 1918 e 1919 da una grave crisi economica. La smobilitazione degli eserciti e la transizione dalla produzione di armamenti a una produzione di pace hanno fatalmente provocato tutti i fenomeni patologici che accompagnano un crollo economico. Questo blocco economico è stato ovviamente ulteriormente aggravato dalla rovina finanziaria delle grandi potenze, dall'indebitamento reciproco, dalla mancanza di materie prime e dalla miseria stridente della popolazione. La crisi che conobbero Inghilterra, Francia, Germania e altri paesi europei nel periodo 1918-1919 comportò un arresto della produzione in moltissimi settori industriali, la chiusura di diverse fabbriche e il licenziamento di numerosi operai.
Le donne persero in modo massiccio il loro posto di lavoro. Ma la gravità della crisi che ha colpito tutti i lavoratori non è stata da sola responsabile della crescente disoccupazione femminile. Anche nei settori industriali che continuavano a funzionare normalmente, i padroni cominciarono a respingere le donne in strada. Se prima un datore di lavoro aveva la possibilità di scegliere sul mercato del lavoro tra un rimpatriato dal fronte e un'operaia, sceglieva di preferenza quest'ultima. Può sembrare paradossale, ma alla fine gli operai erano poco cooperativi, richiedevano salari più elevati ed erano effettivamente meglio retribuiti. In altre condizioni sociali, i padroni avrebbero ovviamente privilegiato la manodopera femminile più a buon mercato, ma non dobbiamo dimenticare che la smobilitazione avvenne in un momento in cui la popolazione era di umore rivoluzionario.
Da quando la classe operaia russa ha aperto la strada alla rivoluzione d'Ottobre, regnò tra le classi lavoratrici degli altri paesi un clima di crescente tensione e opposizione. Coloro che erano tornati a casa erano nervosi ed esasperati, sapevano usare un fucile e si erano abituati a guardare la morte in faccia. Se i padroni avessero osato rifiutare il lavoro a questi uomini impazienti e amareggiati, il sistema borghese avrebbe certamente rischiato una minaccia mortale. I padroni si resero conto di questa situazione e accettarono di rinunciare ad una parte dei profitti che avevano ottenuto fino a quel momento dal lavoro più economico delle donne. Furono costretti a difendere il loro predominio di fronte alla minaccia bolscevica. Le precauzioni politiche allora prevalsero sui calcoli economici. Così in Germania, Inghilterra, Francia e Italia, le donne patriottiche, le "eroine del lavoro" e i "soldati delle retrovie" di ieri dovevano cedere il loro posto ai soldati rimpatriati di oggi.
La lenta normalizzazione della produzione e il ridimensionamento della crisi del dopo guerra ci permettono di registrare una nuova riduzione della disoccupazione femminile. Ciò non significa affatto che il problema del lavoro delle donne sia a questo punto risolto. Al contrario, data l'attuale fase di sviluppo della produzione mondiale capitalistica, caratterizzata dal processo di concentrazione nella grande industria tecnicamente altamente sviluppata, questo problema rimane invariato. Naturalmente non si tratta di una nuova retrocessione della donna tra le quattro mura della sua casa. Certo, le capacità produttive stanno registrando uno sviluppo irregolare richiesto dall'industria bellica, ma le industrie dei beni di consumo corrente hanno comunque ricominciato a funzionare negli ultimi anni. Ecco perché si assiste di nuovo a una crescente domanda di manodopera e come in passato, il capitalismo è favorevole alla manodopera a buon mercato. Il lavoro delle donne riprende quindi nelle fabbriche.
Tuttavia, lo sviluppo economico negli Stati capitalisti incontra alcune difficoltà: dall'esistenza del lavoro salariato al fatto che gran parte del plusvalore scorre come sempre nelle tasche dei padroni, all'assenza di una pianificazione economica globale (ad esempio una visione d'insieme statistica e un uso razionale di tutte le forze di lavoro disponibili), nonché della sproporzione tra produzione e consumo. Questi fattori limitano in modo insormontabile lo spiegamento delle forze produttive nel quadro del sistema capitalista.
Il sistema di produzione capitalista ha semplicemente raggiunto uno stadio in cui non è più possibile uno sviluppo illimitato delle forze produttive. Lo sviluppo per crisi dell'economia mondiale capitalista da un lato e la vittoria della Rivoluzione socialista in Russia dall'altro, hanno scosso il fondamento del sistema capitalista e l'hanno reso ancora più sensibile alle crisi. Le forze produttive nei paesi capitalisti possono svilupparsi solo in modo rigido e per scosse successive. La curva della congiuntura economica sarà sempre più accidentata. L'alternanza tipica per il capitalismo tra una congiuntura ascendente, un'economia stagnante e la crisi metterà il sistema di produzione capitalista in una situazione sempre più insostenibile. Non c'è alcuna speranza che lo sviluppo delle forze produttive sotto il capitalismo avvenga senza crisi, vale a dire che dobbiamo prepararci in futuro a terribili crisi economiche con conseguenti licenziamenti di massa dei lavoratori. A prescindere dal pericolo permanente della guerra che, finchè dura la politica imperialista, resta sempre attuale. Ma quali prospettive si aprono per il lavoro delle donne nei paesi in cui la classe operaia non è riuscita a rovesciare il sistema capitalista, nei paesi che sono costantemente soggetti a uno sviluppo irregolare e mutevole?
Un ulteriore sviluppo della congiuntura economica a livello sia locale che nazionale comporta un aumento del numero delle donne nella produzione. L'estensione del lavoro delle donne è dovuto, da un lato ai bassi salari delle donne e dall'altro alla crescente domanda di manodopera nei settori dell'industria in espansione. Ad ogni congiuntura ascendente segue inevitabilmente un periodo di stagnazione economica. Risultato: meno offerte di lavoro legali e licenziamenti. I padroni, per ragioni di ordine politico, cercheranno piuttosto di conservare la loro manodopera maschile e licenzieranno le lavoratrici, dato che, per esperienza, creano meno problemi. La relazione che ho appena descritto è nel complesso tipica del capitalismo. Nell'attuale situazione mondiale, questa dialettica (la contraddizione tra il carattere sociale della produzione e l'appropriazione capitalista privata) appare in una forma particolarmente critica. Ogni nuova crisi provoca sconvolgimenti sempre più violenti nell'intera economia nazionale, assume proporzioni sempre più enormi e si estende a ceti sociali sempre più ampi. Finché il capitalismo non sarà eliminato, il problema del lavoro delle donne, che è parte integrante della problematica generale del rapporto tra lavoro e capitale, rimarrà invariato. Le lavoratrici dei paesi capitalisti non potranno contare su un miglioramento della loro situazione finché il capitale regnerà sul lavoro e la proprietà privata ostacolerà la pianificazione della produzione, del consumo e dell'esportazione. Compagni, dovete rendervi conto che il problema del lavoro delle donne non sarà risolto fintanto che sarà accompagnato dallo spettro della disoccupazione delle donne lavoratrici. Finché ciò non avverrà, un problema così complesso come la "questione delle donne" non potrà essere risolto nella sua totalità.
A dire il vero alcuni Stati borghesi sono stati costretti dalla fine della guerra a realizzare tutta una serie di riforme, anche per quanto riguarda la situazione della donna, ma questi compromessi, per i quali le suffragette del secolo scorso avevano combattuto bombe alla mano e che le femministe borghesi, nettamente più pacifiste, avevano invano difeso attraverso innumerevoli petizioni, finirono per essere strappate alla borghesia essenzialmente per due ragioni: grazie all'esempio intimidatorio della Rivoluzione russa da un lato e alla tendenza democratica ampiamente diffusa tra le masse, dall'altro. E per ridurre questa tendenza rivoluzionaria generale e dimostrare ai lavoratori che una rivoluzione sociale non era superflua, che vi erano in realtà altre possibilità per arrivare al potere, la borghesia distribuì elemosine, come la riforma elettorale (compreso il diritto di voto per le donne).
Personaggi come David George Lloyd, Hjalmar, Karl Brandling, Philipp Scheidemann e Gustav Noske "si preoccuparano della felicità e del benessere dei lavoratori" e affermarono di aver conquistato per loro non la totalità del potere politico, ma "una giusta parte" di questo.
In Inghilterra, Germania, Svezia e Austria, se le donne ottennero il diritto di voto dopo la guerra fu per ragioni politiche precise e non come ricompensa per i loro "servizi patriottici".
Ma il diritto formale non apportò alcun cambiamento alla situazione reale delle donne nella società borghese. La donna si ritrovò sempre nello stesso ruolo sociale dopo la guerra, come prima. In tutti i paesi borghesi rimane sempre la serva della famiglia e della società. La riforma della legislazione borghese a favore della donna e le poche leggi volte a parificare la situazione dei coniugi hanno apportato solo modifiche minori. In fondo, nulla è stato veramente cambiato; i vecchi rapporti e la vecchia discriminazione sono stati mantenuti nella loro essenza.
Nei paesi borghesi la questione delle donne non è certo risolta. Al contrario, essa si aggrava sempre più e ciò in funzione della situazione sociale delle donne.
Come possono le donne conciliare la loro vita professionale con quella di moglie e di casalinga?
Come potranno le donne liberarsi del fardello del lavoro domestico che consuma inutilmente la loro energia? Esse potrebbero veramente farne un uso migliore dedicandosi, ad esempio, a lavori scientifici o mettendosi al servizio di un'idea.
I problemi irrisolti - la maternità, l'aborto, la tutela della salute, l'educazione dei bambini - sono ulteriormente rafforzati dal capitalismo. Le donne non sono in grado di spezzare questo circolo vizioso. L'inviolabilità della proprietà privata, il mantenimento del nucleo familiare isolato, la sopravvivenza tenace delle abitudini individualiste, le tradizioni e l'assenza di esperienze sociali collettive hanno incrinato irrimediabilmente la "questione delle donne" all'interno del capitalismo. Persino gli uomini ben intenzionati nei loro confronti saranno impotenti nel risolvere la loro oppressione finché il potere del capitale non sarà spezzato.
Solo con l'avvento e la vittoria del proletariato questo circolo vizioso potrà essere spezzato. L'esperienza della Russia in questi ultimi quattro anni mostra a voi e al proletariato mondiale e in particolare alle donne proletarie, come uscire da questa impasse e come le donne possano liberarsi non in modo formale e superficiale, ma in modo reale e profondo.
Esamineremo come raggiungere questo obiettivo nella nostra prossima conferenza.
* * *
ndt:
31) si legga in proposito "L'inasprimento dei contrasti interni dei paesi belligeranti" - Accademia delle Scienze dell'URSS, Storia universale vol. VII, Teti Editore, Milano, 1975, Capitolo XXVII, Parte prima - su Resistenze.org
32) Interessante leggere: "Le donne combattenti nei giorni della Grande Rivoluzione d'Ottobre", Aleksandra Kollontaj, Zhensky Zhurnal (The Women's Journal), N. 11, Novembre, 1927, pp. 2-3 - Traduzione per Resistenze.org a cura del Centro di Cultura e Documentazione Popolare
Decima conferenza - La dittatura del proletariato: l'organizzazione del lavoro
La Guerra mondiale ha creato tutte le condizioni oggettive per la liberazione delle donne. Il loro lavoro è oggi un fattore importante dell'economia nazionale. La maggior parte delle donne in età lavorativa svolge un lavoro socialmente utile. Malgrado ciò all'interno del sistema capitalista borghese non è stato finora possibile realizzare la liberazione della donna.
Abbandoneremo ora l'universo del capitalismo e i suoi complessi problemi sociali, per studiare una forma statale finora sconosciuta, cioè la dittatura del proletariato. Nel nostro paese, la classe operaia si è levata e si è impadronita del potere. Ci occuperemo quindi della prima repubblica operaia.
Nella Russia rivoluzionaria, il potere dello Stato è nelle mani dei lavoratori. Per la prima volta nella storia, la classe operaia e contadina riesce ad abbattere la borghesia. Quest'ultima ha perso la sua autorità e i suoi privilegi.
In seno ai Consigli (Soviet) (ndt 33), la borghesia non ha diritto di voto, perché non c'è più posto per i fannulloni e i briganti nella nostra repubblica operaia. La proprietà privata dei mezzi di produzione è stata eliminata, così come il commercio privato e l'accumulazione del capitale. Siamo riusciti a porre fine allo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo.
Il Partito comunista di Russia, PCR(b) (ndt 34), avanguardia della classe operaia, ha proclamato la repubblica dei Soviet. La vita è stata profondamente modificata, il fondamento della classe borghese è stato scosso, il vecchio regime, distrutto e al suo posto costruiamo qualcosa di completamente nuovo.
Nei primi tre anni della nostra Rivoluzione abbiamo creato le condizioni per un nuovo modo di produzione. Il sistema economico socialista sostituisce il capitalismo, la proprietà privata e lo sfruttamento del lavoro salariato.
La grande industria, le miniere, i trasporti, le terre sono d'ora in poi di proprietà del popolo, amministrati in modo centrale dall'apparato dello Stato. Certo, il lavoro salariato esiste ancora, ma il plusvalore cessa di cadere nelle tasche di qualche imprenditore privato e viene ormai utilizzato per soddisfare le esigenze sociali: per lo sviluppo della produzione, la realizzazione di una nuova coscienza sociale e il rifornimento dell'Armata Rossa, di cui è impossibile fare a meno durante il periodo della dittatura rivoluzionaria del proletariato.
In seno ai propri organi amministrativi, il proletariato decide egli stesso della condotta da adottare per l'economia, pianifica la produzione e lo scambio e organizza la distribuzione dei beni di uso corrente secondo i bisogni del proletariato. Tutte queste grandiose iniziative sono ancora al primo stadio.
Finora nulla ha assunto una forma definitiva. In tutti i settori stiamo vivendo uno sviluppo accelerato. Attraverso la pratica rivoluzionaria, riusciamo ovunque a fare nuove esperienze e assistiamo costantemente al fiorire di nuove idee.
La classe operaia getta le fondamenta di un nuovo modo di produzione e si adopera per superare, distruggere gli ostacoli e le possibilità di sopravvivenza della società borghese, che potrebbero compromettere lo sviluppo delle forze produttive. Il compito principale di questa recente società è quello di spianare la strada a questo inedito modo di produzione. Naturalmente si tratta di un compito difficile e con pesanti responsabilità. Sotto gli occhi dell'intera umanità un'immensa collettività intraprende l'impresa di concentrare i propri sforzi e la propria volontà su un unico obiettivo: scuotere il capitalismo fin dalle sue fondamenta. Il sacrosanto principio della proprietà privata è ridotto in polvere. La borghesia si spaventa e si esilia precipitosamente all'estero per organizzare l'invasione armata contro gli schiavi ribelli e disubbidienti. La minaccia di guerra è permanente. Si segnalano quotidianamente sanguinosi incidenti alle frontiere. Al frastuono contrariato degli antichi possidenti risponde il grido vendicatore della nostra giovane generazione, che difende coraggiosamente il futuro.
Il mondo è inquieto. Il «pericolo rosso» si aggira. Il futuro è tinto di rosso: minaccioso per gli uni, liberatore per gli altri.
Il nuovo sistema economico della Russia è caratterizzato dalla pianificazione statale centralizzata della produzione e del consumo. Tutte le ricchezze della nazione sono quantificate statisticamente e ogni cittadino russo è registrato nella sua funzione di produttore e di consumatore. Il nostro modo di produzione non sopporta alcun tipo di disordine economico. Ignora la concorrenza, le crisi economiche e la disoccupazione, che prima era prevalsa allo stato endemico e ora, dal terzo anno della Rivoluzione, scompare. Non esiste già più manodopera disponibile, sarebbe più corretto parlare di penuria di manodopera.
Con l'eliminazione della proprietà privata dei mezzi di produzione, ci siamo «sbarazzati» della classe dei parassiti che non producevano alcun lavoro utile per l'economia nazionale, ma si accontentavano di consumare. Ecco perché nella Russia sovietica operiamo secondo il principio: «Chi rifiuta di lavorare non deve neppure mangiare».
I proprietari che percepiscono un reddito senza lavorare o i disertori che abbandonano il lavoro, sono perseguiti secondo le leggi della nostra repubblica (Commissione straordinaria di lotta contro la controrivoluzione, la speculazione e il sabotaggio) (ndt 35). Lo Stato dei Soviet chiede a tutta la popolazione di compiere uno sforzo per soddisfare i bisogni più pressanti della nostra società. L'industria, totalmente distrutta dalla guerra e dalla cattiva amministrazione degli impiegati zaristi, deve essere rilevata. Inoltre, dobbiamo sostenere l'Armata Rossa, che difende la nostra Rivoluzione.
Naturalmente, nella nostra nuova società non c'è spazio neppure per i parassiti femminili - cioè le donne mantenute dal marito o dal loro amante o le prostitute di mestiere -, perché «Chi rifiuta di lavorare non deve neppure mangiare». Anche per questo la distribuzione dei beni di consumo è severamente regolamentata, soprattutto nelle città. Le razioni vengono distribuite solo a chi lavora. Grazie a questa politica economica (Nuova Economia politica), il rapporto tra i sessi è destinato a cambiare completamente. La donna non coccola più come un tempo suo marito, sostegno della famiglia e cessa di sottomettersi ai suoi desideri. È indipendente, si reca al lavoro, ha il suo libretto di lavoro personale e la sua carta di rifornimento (per approvvigionarsi delle razioni dei viveri e degli oggetti di uso corrente). L'uomo ha cessato di essere il capo famiglia, signore e padrone di casa. E come potrebbe essere altrimenti, se la donna possiede la sua carta di approvvigionamento, sulla quale i bambini sono menzionati?
La donna non dipende più da un padrone. Nella Russia sovietica, l'unico dirigente delle lavoratrici e dei lavoratori è l'Unione Sovietica. La partecipazione delle donne ai lavori di ricostruzione ha un significato essenziale per il nostro popolo, significato impossibile da raggiungere in una società capitalista borghese. Il sistema economico borghese si basa proprio sull'esistenza di cellule familiari private smembrate e sull'oppressione e la mancata emancipazione delle donne.
L'atto rivoluzionario più importante è l'introduzione del lavoro obbligatorio per uomini e donne adulti. Questa legge ha portato un cambiamento senza precedenti nella vita della donna. Ha modificato il ruolo della donna nella società, nello Stato e nella famiglia, in modo molto più importante di tutti gli altri decreti dalla rivoluzione di Ottobre, che accordavano alla donna l'uguaglianza politica e civica. Per esempio il diritto di eleggibilità delle donne in seno ai Consigli operai e alle altre rappresentanze nazionali o ancora il nuovo diritto matrimoniale del 18 e 19 dicembre 1917, dove si dice che il matrimonio è un'associazione tra due persone uguali. Questa norma di diritto significa, in ultima analisi, soltanto l'uguaglianza formale di fronte alla legge: in realtà, la donna, a causa della sopravvivenza delle tradizioni borghesi, continua ad essere discriminata e non emancipata, come in passato. Parliamo ora dei livelli di coscienza, delle tradizioni, delle abitudini e della morale. Solo con l'introduzione del lavoro obbligatorio per tutti il ruolo della donna cambia nell'economia nazionale. Ora è generalmente accettata come partecipante a un lavoro socialmente utile per la collettività.
Le conclusioni che possiamo trarre da questa evoluzione sono che l'uguaglianza della donna in tutti gli altri settori non tarderà a realizzarsi. Sappiamo infatti che il ruolo della donna nella società e la relazione tra i sessi dipendono dalla sua funzione nella produzione. (ndt 36)
Ecco perché non dobbiamo perdere di vista l'importanza rivoluzionaria dell'introduzione del lavoro obbligatorio per la liberazione della donna. Il nuovo modo di produzione in Russia presuppone tre condizioni:
1. Una valutazione esatta e un uso oculato di tutte le forze di lavoro disponibili, compresa quella delle donne.
2. Il passaggio dall'economia familiare individuale e dai consumi familiari privati alla pianificazione sociale dell'economia e al consumo collettivo.
3. L'applicazione di un piano economico omogeneo.
L'interminabile guerra, prima la guerra imperialista, poi la guerra di liberazione rivoluzionaria, ha rovinato l'economia del paese, distrutto i mezzi di trasporto e bloccato lo sviluppo tecnico. L'appropriazione privata delle ricchezze sociali è cessata, ma la repubblica operaia ha ormai il compito gravoso di ricostruire l'economia e di accelerare lo sviluppo delle forze produttive.
Anche i paesi capitalisti stanno vivendo un periodo di incertezza economica e di collasso interno. L'intera economia capitalista sta vacillando verso una crisi economica inevitabile e generalizzata. Oggi il proletariato russo ha la certezza che le forze produttive possono prosperare anche in avvenire.
Negli Stati borghesi, nello stesso periodo, i capitalisti e i magnati della finanza tentano spesso e volentieri di rilanciare la produzione. I paesi capitalisti dopo un breve periodo di crescita economica si trovano in piena crisi, molte imprese ricominciano a chiudere i battenti e l'intera economia si avvia verso la catastrofe. La classe operaia ha capito che esiste un solo trattamento efficace contro il collasso e la distruzione dell'economia nazionale: l'introduzione di un nuovo modo di produzione come unica soluzione per impedire all'umanità di cadere di nuovo nella barbarie. E l'Unione Sovietica sta instaurando questo nuovo modo di produzione.
Ma finché la classe operaia in Unione sovietica continuerà a dipendere dalla tecnica ereditata dal capitalismo, lo sviluppo delle forze produttive non sarà veramente privo di intoppi, dato che non potremo contare, a causa della situazione politica caotica degli stati capitalisti, su un aiuto economico da parte dei nuovi governi operai in Europa. Siamo quindi obbligati a perseguire da soli, attraverso un'organizzazione pianificata della forza lavoro vivente, il necessario sviluppo delle forze produttive. Attualmente la popolazione dell'Unione sovietica ha il compito di aumentare la produttività di ogni lavoratore e di ogni lavoratrice. Non è ancora possibile parlare di una profonda riforma delle condizioni generali di vita, poiché la maggioranza della classe operaia continua a vivere in condizioni ereditate dal passato borghese. Le energie delle lavoratrici continuano ad essere parzialmente impiegate nei compiti improduttivi al servizio della famiglia e che rimangono perse per sempre per la produzione di valori sociali e beni di consumo correnti. Le lavoratrici impiegano quindi solo parzialmente la loro energia nel processo di produzione. Di conseguenza, spesso svolgono un lavoro non qualificato e inoltre, la qualità del loro lavoro lascia spesso a desiderare.
Le donne semplicemente non hanno il tempo di continuare a perfezionarsi professionalmente. È evidente che la qualità del loro lavoro nella produzione si deteriora in funzione dell'intensità dell'uso della loro forza lavoro al di fuori del processo di produzione sociale. L'operaia madre di famiglia, costretta a vegliare per intere notti al capezzale del suo neonato e a consacrarsi nel tempo libero alla famiglia e alla cura della stessa, è naturalmente molto meno attenta nel suo lavoro dell'uomo, che può dormire la notte senza essere disturbato e che, peraltro, è dispensato dalle faccende domestiche.
Se vogliamo migliorare la produttività del lavoro della classe operaia e in particolare della donna lavoratrice, dobbiamo prima cercare di cambiarne le condizioni di vita. Dobbiamo passo dopo passo, ma consapevoli dell'obiettivo da raggiungere, gettare le basi di uno stile di vita collettivo, ciò significa che dobbiamo iniziare col creare una vasta rete di asili nido e giardini d'infanzia, nonché di centri di produzione completamente nuovi. Le commissioni di pianificazione e i sindacati potranno aspettarsi dalle donne un miglioramento della loro produttività del lavoro conforme alle norme di rendimento solo a questa condizione. Essi potranno permettersi di criticare le lavoratrici per la loro negligenza o il loro lavoro trascurato, solo quando questo obiettivo sarà raggiunto.
Ma questo sarà raggiunto solo quando tutte le lavoratrici - e sono numerose - troveranno al di fuori del loro luogo di lavoro condizioni di vita che evitino di utilizzare le loro forze per attività economiche familiari e private. È necessario porre fine allo spreco di forza lavoro femminile ed è veramente importante limitare finalmente le enormi perdite per la nostra economia socialista causate dalle attuali condizioni di vita. Non possiamo aumentare la produttività del lavoro semplicemente aumentando il numero dei lavoratori. Altrettanto importante è adoperarsi per cambiare le condizioni di vita in cui si trova la nostra classe operaia. Per questo motivo dobbiamo gradualmente sostituire l'economia familiare individuale con un'economia domestica veramente comunitaria. In effetti, sarà l'unico modo per risparmiare la forza lavoro della donna.
Ma oggi la produttività del lavoro in Unione sovietica dipende largamente dal numero dei lavoratori, ecco perché il Consiglio per il lavoro e la difesa cerca di ridurre il numero dei parassiti che vivono a spese della classe operaia senza contribuire alla prosperità della società. Da quando la proprietà privata dei mezzi di produzione è stata eliminata nella nostra repubblica operaia, le condizioni per lo spiegamento delle forze produttive sono nettamente migliorate. D'ora in poi il plusvalore sociale così ottenuto viene utilizzato per lo sviluppo delle forze produttive o per il soddisfacimento di bisogni fino ad allora insoddisfatti. Il plusvalore sociale così prodotto è ora destinato all'intero popolo e non più al consumo privato di una classe dominante. Nella società borghese solo una parte della società, la classe operaia, produceva il plusvalore sociale. Ma le classi che non lo producevano direttamente avevano dato vita ad un nuovo strato sociale, di persone occupate in lavori totalmente improduttivi atti a soddisfare le esigenze di consumo e le fantasie delle classi possidenti: la servitù, i produttori di beni di lusso, gli artisti da salotto, gli pseudo-artisti e gli pseudo-scienziati, nonché un numero crescente di cocottes e prostitute.
I capitalisti stavano dilapidando una parte sempre più importante della ricchezza sociale, per i loro miserabili divertimenti.
Se la parte improduttiva della popolazione nei paesi capitalisti borghesi era così grande, è anche perché molte donne si lasciavano mantenere dai loro mariti. Fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale, più della metà delle donne era a carico del marito o del padre. Tali anomalie sono una conseguenza della struttura sociale capitalista e hanno frenato il dispiegarsi delle forze produttive insieme alla necessaria lotta contro la situazione caotica in questi paesi.
Il sistema economico comunista, invece, funziona in modo completamente differente.
La base dell'economia sociale è un'amministrazione pianificata di tutto il processo economico, che non si orienta più verso le esigenze di un piccolo gruppo di profittatori, ma verso le esigenze dell'intera popolazione. La produzione di merci di tipo capitalista, storicamente superata, scompare e le forze produttive, sotto il socialismo, conoscono uno sviluppo prodigioso.
In primo luogo, abbiamo bisogno di uno studio statistico che indichi il numero di forza lavoro disponibile, solo allora potremo distribuire queste forze in modo pianificato. A causa della libera concorrenza regna il disordine sul mercato del lavoro capitalista. È così che un'impresa può essere vinta dalla disoccupazione e soffrire di un eccesso di forza lavoro, mentre nell'impresa vicina e nello stesso periodo, è proprio la forza lavoro che manca.
In alcuni settori industriali, gli operai si ammalano a causa di un lavoro troppo intensivo, mentre in altri il processo di produzione è rallentato e la sua organizzazione è irrazionale perché la meccanizzazione e il basso livello dei salari garantiscono tuttavia ai capitalisti un profitto sufficientemente elevato. È solo attraverso il censimento e la distribuzione pianificata della forza lavoro, che lavoratori e lavoratrici possono sfuggire allo spettro della disoccupazione. Nell'Unione sovietica, la disoccupazione è oggi del tutto scomparsa. Ciò rappresenta per la classe operaia un notevole miglioramento.
Un passo importante nell'Unione sovietica per aumentare la produttività del lavoro è il passaggio immediato alla distribuzione comunista. L'enorme dilapidazione della forza lavoro femminile, prevalente fino ad allora (le donne sono in fin dei conti più numerose in Russia, che gli uomini) è una conseguenza dell'economia familiare individuale estremamente poco redditizia. Questa dilapidazione cesserà solo con la comparsa dell'economia comunitaria pubblica.
I giardini d'infanzia, gli asili nido, le mense e le case di riposo installate dai Soviet risparmiano alle donne il lavoro improduttivo. Solo quando la donna sarà liberata dai monotoni compiti domestici e da altri doveri familiari, potrà utilizzare l'intera forza lavoro per un lavoro produttivo. Solo un profondo cambiamento e una profonda riforma delle condizioni e delle abitudini di vita secondo i principi socialisti consentiranno di introdurre con successo il lavoro obbligatorio per tutti.
Infatti, se l'introduzione del lavoro obbligatorio non è collegata simultaneamente ad un cambiamento delle condizioni e delle abitudini di vita, ciò significa per le donne un aumento del lavoro, che porta fatalmente ad un reale sovraccarico di lavoro, che mette in pericolo la loro salute e la loro vita. Ecco perché l'introduzione del lavoro obbligatorio per tutti nelle società capitaliste, che comporta un "doppio fardello" per la donna, può essere considerato un'evoluzione estremamente reazionaria. Nelle repubbliche operaie socialiste, invece, l'introduzione del lavoro obbligatorio e la creazione parallela di nuove condizioni di vita, come lo sviluppo dell'economia pubblica comunitaria, significano l'edificazione di una solida base per la futura liberazione della donna.
Ma la sopravvivenza delle tradizioni borghesi subentra sempre nei nostri usi e costumi per una parte importante, in particolare nelle tradizioni della classe contadina.
Queste tradizioni rendono la vita delle donne molto più difficile di quella degli uomini e anche nelle famiglie dei lavoratori la moglie, la madre o la sorella devono sopportare le ripercussioni di queste tradizioni. Questo doppio carico di lavoro comporta naturalmente gravi conseguenze per le donne. Perché le donne devono rischiare la loro salute?
È quindi necessario riorganizzare la vita quotidiana nell'interesse delle lavoratrici. E poiché le donne sono casalinghe abili ed esperte, hanno dato prova di grandi capacità di iniziativa personale quando si trattava di riorganizzare la vita quotidiana. Non abbiamo quindi altro da fare che sostenere la loro iniziativa e aprir loro un campo sufficientemente ampio per la sua applicazione. La proletaria è abituata a costruire una «casa a partire dal nulla» e ad amministrare una famiglia con mezzi materiali irrisori. Per questo motivo è anche importante coinvolgere le donne in una forma di organizzazione collettiva che consenta di prendere in considerazione una riorganizzazione della vita quotidiana. Ciò sarebbe estremamente vantaggioso per l'intera popolazione.
Non dobbiamo tuttavia soffermarci unilateralmente sul cambiamento delle condizioni di vita. Le donne devono anche acquisire una maggiore consapevolezza di se stesse e del proprio valore. Dobbiamo quindi continuare a lottare incessantemente per la partecipazione delle donne a tutti i settori locali di auto-governo, se vogliamo veramente ottenere un cambiamento nelle condizioni di vita della classe operaia.
Ma senza questi profondi cambiamenti delle condizioni generali di vita, ogni tentativo di aumentare la produttività del lavoro sarà un buco nell'acqua. I servizi di pianificazione economica superiori hanno tutto l'interesse a dedicarsi al cambiamento delle condizioni generali di vita all'interno della fabbrica e a prendere in considerazione, ad esempio, l'installazione di una mensa e di un asilo per bambini, ecc. Le ore di lavoro impiegate dai lavoratori all'insediamento di queste istituzioni comuniste dovranno allora essere contate come ore di lavoro effettive. Solo a queste condizioni possiamo sperare in un cambiamento delle condizioni generali di vita.
Le sezioni femminili, in collaborazione con le sezioni sindacali di fabbrica, devono creare nuovi modelli che garantiscano al tempo stesso un utilizzo produttivo della mano d'opera femminile e la tutela delle lavoratrici contro il sovraccarico di lavoro. Si tratta di prevedere l'orario di lavoro e i periodi di riposo.
La pianificazione della vita quotidiana comunista è importante quanto la pianificazione della produzione. Se vogliamo veramente ottenere un dispiegamento totale delle forze produttive, non possiamo permetterci di trascurare il lavoro preliminare. Nella pianificazione e nell'organizzazione della produzione vanno presi in considerazione tutti i fattori che alleggeriscono la vita quotidiana e mettono fine all'assurdo spreco della forza lavoro femminile.
Ripeto ancora una volta: il cambiamento delle condizioni di vita deve andare di pari passo con l'introduzione del lavoro obbligatorio per tutti. Ciò significa un'intensificazione delle iniziative, applicate essenzialmente all'economia comunitaria pubblica. Se raggiungiamo questo obiettivo, il sistema economico socialista, che si sviluppa attualmente sotto la dittatura del proletariato e che è sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la popolazione alla produzione, porterà ad un cambiamento finora sconosciuto nella storia dell'umanità: l'emancipazione della donna nella società.
In Unione sovietica, tutte le donne tra i 16 e i 40 anni devono attualmente svolgere un lavoro (nella misura in cui non sono impiegate a tempo pieno nella produzione o nell'amministrazione statale). Dopo il caos generale, la produzione deve essere rilanciata. Questo lavoro obbligatorio non vale solo per le città, ma anche per le campagne. Le contadine, come i contadini, devono svolgere questo lavoro per la società per periodi fissi e ripetuti. Le contadine e i contadini contribuiscono come guidatori, trasportano il legname, partecipano alla costruzione di strade o coltivano vivai. Le contadine confezionano le divise per i soldati dell'Armata Rossa. Questo lavoro obbligatorio rappresenta indubbiamente un onere supplementare per la contadina, dato che le condizioni di vita nelle campagne sono rimaste invariate.
Non esistono asili nido o mense aziendali, il che significa naturalmente che le contadine continuano a sopportare da sole il peso dei compiti domestici. Tuttavia, il fatto che la società riconosca le contadine come forza lavoro produttiva porterà a lungo termine il cambiamento nella loro vita e ad elevare il proprio status sociale. Lo stesso contadino finirà per dire: «Se anche lo Stato accetta la mia buona moglie come forza lavoro utile, è perchè è davvero buona a qualcosa.»
La sottovalutazione tradizionale senza limiti delle «buone donne» nella campagna deve regredire a favore delle nuove concezioni. Certo, esiste già un certo spostamento dei rapporti di forza tra uomo e donna, ma non è ancora possibile parlare di rispetto dell'uomo nei confronti della donna.
Nelle città l'obbligo del lavoro riguarda tutte le donne che non possiedono un libretto di lavoro, cioè che non sono impiegate né in fabbrica, né in officina o che non lavorano per il partito. Queste donne lavorano per gli organismi sanitari, in ospedale o spalano la neve. Altre donne distribuiscono il legno razionato o spazzano le strade della città. Questo lavoro, che è obbligatorio per tutti, ha finora contribuito ad accelerare il processo di liberazione sociale delle donne. Tutta la loro vita è stata cambiata, di solito influenzando anche la relazione tra uomo e donna. Sarebbe tuttavia ingenuo credere che l'introduzione del lavoro obbligatorio sia stata sufficiente a gettare le basi per un'autentica liberazione della donna. Non dobbiamo dimenticare le diverse funzioni della donna nella società, come forza lavoro produttiva per l'economia nazionale, da un lato e come madre delle generazioni future, dall'altro. Nessuno Stato operaio può evitare di prendere in considerazione questo compito particolarmente importante della donna.
Il nostro partito, su iniziativa delle sezioni femminili e in stretta collaborazione con esse, ha elaborato una normativa che garantisce la protezione della salute e della forza lavoro della donna. Con questa regolamentazione giuridica teniamo conto, in particolare, delle condizioni di vita proprie dell'attuale periodo di transizione. Poiché tutti i cittadini dell'Unione sovietica sono tenuti a svolgere un lavoro produttivo per la società, il nostro interesse si rivolge in particolare alle madri e alle casalinghe che beneficeranno d'ora in poi di una regolamentazione speciale.
Tutti gli uomini tra i 16 e i 50 anni devono svolgere un lavoro obbligatorio; per le donne, il limite di età è a quarant'anni. I lavoratori in grado di dimostrare che la loro salute è compromessa sono dispensati dal lavoro obbligatorio; questa normativa è applicabile anche alle donne che hanno perso il 45% della loro capacità lavorativa. Naturalmente le donne incinte sono dispensate da qualsiasi lavoro, otto settimane prima e otto settimane dopo la nascita.
Inoltre, la regolamentazione prevede che una madre con figli di età inferiore agli otto anni non debba lavorare se un altro familiare non rimane a casa ad occuparsi del bambino. Anche le donne che devono occuparsi di una famiglia di più di cinque persone sono esentate dal lavoro obbligatorio. Il Consiglio per il lavoro e la difesa precisa inoltre, che queste donne devono essere impiegate soltanto per lavori facili. Tutte le donne delle città con figli al di sotto dei 14 anni e tutte quelle delle campagne con figli al di sotto dei 12 anni sono dispensate dal lavoro obbligatorio al di fuori della loro località.
Tutte le questioni che abbiamo sollevato oggi, non hanno assolutamente nulla a che vedere con i principi astratti della parità tra i sessi, così come posta dalle femministe borghesi! Nella nostra Repubblica Sovietica noi rappresentiamo la seguente concezione: uguaglianza di diritti, protezione materna e diritti speciali.
Questo lavoro obbligatorio entra per una parte importante nel nostro nuovo ordine sociale e apporta, peraltro, una soluzione radicale alla "questione delle donne". Tuttavia, questa tendenza deve essere sostenuta da una maggiore protezione della madre, in modo da poter garantire sia la forza lavoro che la salute delle generazioni future. Solo quando la classe operaia avrà assunto il potere nello Stato e le donne svolgeranno un lavoro socialmente utile, si potrà porre fine una volta per tutte alla situazione, ormai millenaria, della donna. Il cammino verso la totale liberazione della donna passa per la dittatura del proletariato.
* * *
ndt:
33) Per nozione di soviet consulta Dizionario enciclopedico marxista su Resistenze.org
34) Sull'argomento si legga il Saggio di Paolo Selmi tratto dal fascicolo "Il nostro Ottobre" - a cura del Centro studi sui problemi della transizione al socialismo per il 90° anniversario della rivoluzione, La Città del Sole, Napoli, 2007 - pubblicazione in occasione del 94° anniversario della Rivoluzione d'Ottobre su Resistenze.org
35) Ceka. In proposito si consulti "L'etica della Ceka" - Stralci tratti dall'introduzione di Adriana Chiaia e dalle pagine del libro A. V. TiŠkov, Dzerzinskij il «giacobino proletario» di Lenin. Una vita per il comunismo, Zambon Editore. 2012 - su Resistenze.org
36) Per approfondire l'argomento si legga: 1917-2017 Donne e famiglia nella russia bolscevica di Cristina Carpinelli novembre 2017 - da gramscioggi.org, pubblicato su Resistenze.org
Undicesima conferenza - La dittatura del proletariato: condizioni di lavoro e disposizioni sulla protezione del lavoro
In occasione dell'ultima conferenza abbiamo delineato il nuovo modo di produzione che sta nascendo sotto la dittatura del proletariato. Dopo aver analizzato il ruolo che occupa il lavoro obbligatorio nell'ambito del processo di liberazione della donna nella nostra repubblica operaia, oggi ci concentriamo in maggior misura sul lavoro delle donne. Poi esamineremo nel dettaglio le nuove condizioni di vita, quando l'economia individuale familiare sarà sostituita dalle mense pubbliche, l'istruzione diventata statale e quando saranno applicate le leggi sulla protezione materna.
In Russia, prima della Rivoluzione, vivevano circa cinque milioni di donne che svolgevano un'attività lavorativa. Tale cifra sembra elevata; tuttavia, rappresenta solo l'8% della popolazione femminile russa dell'epoca.
Durante la Prima Guerra mondiale, il numero delle lavoratrici è cresciuto rapidamente. Già nel 1914 la partecipazione delle donne all'industria è salita al 32%, raggiungendo il 40% nel 1918. Nel 1918, il 40% della popolazione attiva - operai e lavoratori salariati - era costituito da donne. Una statistica assolutamente incompleta del Consiglio centrale dei sindacati di tutta la Russia fa supporre che alla fine del 1921 ci saranno circa due milioni di donne impiegate nell'industria e nei trasporti. (La statistica prende in considerazione le operaie agricole, ma ignora le contadine indipendenti). In sei settori professionali e nei relativi sindacati, le donne detengono la maggioranza. Le mense pubbliche danno lavoro al 74,5% di donne, i laboratori di sartoria al 74,2%, l'industria del tabacco al 73,5%, i settori "artistici" al 71,4 %, la sanità pubblica al 62,6 % e l'industria tessile al 58,8 %. Nel commercio e nei privati, le giovani costituiscono il 53,2% del personale. La maggior parte delle donne lavora quindi nelle industrie tessili, nella sanità e nei trasporti pubblici, nei laboratori di sartoria, nell'amministrazione pubblica, nell'industria metallurgica, nelle professioni artistiche, nelle scuole e nei comitati di propaganda.
In sei settori di produzione le donne sono oggi più presenti degli uomini e in altri dieci settori la partecipazione delle donne è del 25-50% del personale totale. Il lavoro delle donne ha quindi cessato di essere un'eccezione ma, nonostante ciò, bisogna riconoscere che la partecipazione delle donne nell'amministrazione economica, nei comitati aziendali e nei consigli economici di Stato resta comunque particolarmente ridotta.
A quanto pare, la coscienza e i costumi tradizionali non stanno al passo degli enormi cambiamenti a cui oggi assistiamo. Il lavoro delle donne è ormai diventato parte integrante dell'economia nazionale. Solo con la partecipazione delle donne possiamo pensare ad un aumento della produzione. Non devono più esserci parassiti, è questo il principio su cui costruiamo tutto il nostro sistema sociale. Tra questi parassiti ci sono le donne mantenute, legalmente come le mogli o illegali come le prostitute. Ma il pregiudizio sull'inferiorità della donna è rimasto così saldamente radicato nelle menti, che anche nell'Unione sovietica dove è stata realizzata l'uguaglianza giuridica di uomo e donna, dove le donne sono attivamente coinvolte in tutti i settori sociali, dove combattono insieme all'Armata Rossa, continua ancora a essere minata l'autostima della donna. Lo illustrerò con la seguente tabella:
Partecipazione delle donne a tutti gli organi sindacali e partecipazione delle donne ai comitati di Fabbrica
| Sindacato |
% donne nel sindacato |
% donne nei comitati di fabbrica |
| Alimentazione (mense) |
73.5 % |
30.9 % |
| Stampa |
33,3 % |
9.6 % |
| Cucito-sartoria |
69,1 % |
25,7 % |
| Giornalismo |
32,5 % |
13.2 % |
| Tabacco |
67,8 % |
36,6 % |
| Kolchozy |
22,5 % |
8,1 %, |
| Educazione sociale |
65.2 % |
37,7 % |
| Operai agricoli e forestali |
19,8 % |
6,2 % |
| Tessile |
60.1 % |
9,3 % |
| Industria alimentare |
18.3 % |
4,3 % |
| Medicina e salute |
52,7 % |
20,2 % |
| Metallurgia |
16,6 % |
1,8 % |
| Mestieri d'arte |
39,3 % |
9,2 % |
| Industria del legno |
16,4 % |
5.5 % |
| Chimica |
35.6 % |
3,6 % |
| Trasporti |
14,5 % |
5,0 % |
| Cartiere |
34,3 % |
10.1 % |
| Industria del cuoio |
13,8 % |
2.7 % |
| Servizi Pubblici (Soviet) |
34,3 % |
11,4 % |
| Edilizia |
11,8 % |
2,90% |
Ciò è risultato vero soprattutto dopo l'istituzione degli ispettori aziendali responsabili. La collaborazione di una donna all'interno di un'amministrazione principale o centrale rimane del tutto inusuale. Durante VIII Congresso del Partito Comunista Russo, nel marzo 1919, la sezione femminile del Comitato centrale adottò una risoluzione nella quale chiedeva che le operaie e le contadine partecipassero a tutti i consigli dell'economia nazionale, ossia in tutti i settori produttivi. La risoluzione si dovette scontrare con forti resistenze nei confronti delle delegate del Congresso ed è stata adottata solo dopo l'intervento paziente, ma energico, della compagna Konkordiia Samoilova e mio.
Francamente, siamo in parte tutti responsabili se oggi le donne sono così poco rappresentate nelle amministrazioni centrali e principali. Nei primi tempi della Rivoluzione, le sezioni femminili concentrarono il loro lavoro principalmente sulla partecipazione delle donne ai consigli locali. A quel tempo eravamo particolarmente attratte dai consigli che creavano le condizioni per la liberazione della donna e alleggerivano la nostra vita quotidiana. Soprattutto nei settori dell'istruzione, delle mense pubbliche e della protezione materna. Dall'autunno del 1920 il centro di gravità della nostra lotta si è spostato. Siamo ottimiste e a ragione, perché le nostre sezioni femminili hanno incentrato la loro propaganda su una maggiore partecipazione delle donne alla ricostruzione dell'industria e siamo fermamente convinte che la partecipazione attiva delle operaie e delle contadine alla costruzione del nuovo modo di produzione aumenterà rapidamente. Tuttavia, torneremo oggi a parlare dei problemi sorti con il lavoro delle donne nell'Unione sovietica. E per finire, quali sono le condizioni di lavoro nella Prima Repubblica operaia della storia dell'umanità, in questo campo sperimentale dove inizia a crescere il seme della futura società comunista?
Anche se la donna, proprio come l'uomo, è stata costretta dal Medioevo a trovare un'occupazione nel mercato del lavoro, era molto meno pagata dell'uomo. Per questo ci occuperemo ora della questione dei salari delle donne. Dalla metà del XIX secolo, femministe borghesi e proletarie coscienti della lotta di classe sostenevano la stessa rivendicazione: "Parità di salario, per lavoro di pari valore", ma questa pretesa non poteva avere successo in una società di tipo capitalistico.
Tale sviluppo può essere inteso come segue: la classe operaia organizzata era certamente in grado di imporre questa rivendicazione a settori di produzione specifici, ma nello stesso tempo una nuova forza lavoro femminile e sindacalmente disorganizzata affluì ininterrottamente nel mercato del lavoro. Questo fatto, in generale, ha portato a un calo relativo dei salari delle donne in tutto il paese. Questa disparità, che non è possibile appianare sotto il capitalismo, è stata eliminata nella Repubblica dei Soviet immediatamente dopo la Rivoluzione. Di conseguenza, l'appartenenza a un determinato sesso non ha dovuto più incidere sull'ammontare dei salari. In tutti i settori della produzione, nei trasporti, nell'agricoltura o nei servizi pubblici, gli accordi salariali vengono conclusi tra il sindacato locale e il consiglio centrale dei sindacati di tutte le Russia. L'importo del salario dipende quindi dal tipo di lavoro svolto e i criteri per le diverse categorie di lavoro sono, ad esempio, la formazione professionale acquisita, i gradi di rischio di infortunio, di difficoltà, ecc.
In tal modo, l'offerta e la domanda cessano di determinare l'importo dei salari. Il salario non è più il risultato di lotte salariali, di sindacati contro imprenditori. Oggi ha smesso di essere una lotteria ed è stabilito dagli stessi lavoratori. Le tariffe accettate dal Consiglio centrale dei sindacati di tutta la Russia, sono applicabili a tutte le fabbriche dei settori interessati e ciò in tutta la repubblica operaia.
Da un'indagine condotta tra i lavoratori a Mosca emerge che il reddito medio delle giovani lavoratrici al di sotto dei diciotto anni raggiunge o supera in diversi settori il reddito medio dei giovani lavoratori al di sotto dei diciotto anni.
La tabella seguente mostra i salari medi regolamentati dagli accordi salariali suddivisi per diversi settori di produzione:
| Settore di produzione |
Lavoratori |
Lavoratrici |
| Industria chimica |
6,2 |
7,1 |
| Industrie del tabacco |
4,3 |
5,7 |
| Kolkhozes |
6,3 |
5,0 |
| Santé publique |
2,8 |
5,1 |
| Industrie textile |
3,7 |
4,1 |
| Cantines publiques |
3,5 |
3,2 |
Se confrontiamo le tariffe dei salari dei lavoratori e delle lavoratrici, abbiamo l'impressione che siano le lavoratrici a prevalere. Tuttavia, la stessa ricerca dimostra anche che il salario medio di tutte le donne è pari alla metà del salario medio dei lavoratori maschi. Questa disparità salariale è dovuta al fatto che nella nostra repubblica dei Soviet il contingente delle lavoratrici non qualificate è più elevato di quello degli operai non qualificati. Finché continuiamo a trascurare la formazione delle donne, il buon principio della nostra repubblica operaia: "A parità di lavoro, pari salario" rimarrà lettera morta.
Dopo la rivoluzione di Ottobre, il Consiglio superiore dell'economia nazionale ha cercato di pagare i salari non in denaro, ma in natura. Oltre al salario regolato principalmente in denaro, il lavoratore non riceveva soltanto la razione alimentare normale cui ogni cittadino sovietico aveva diritto grazie al proprio libretto di lavoro, ma anche supplementi in natura sotto forma di legna da ardere, petrolio, abbigliamento da lavoro, mensa e alloggio. Per questi supplementi, di solito non aveva nulla da pagare o pagavo un prezzo fissato dal soviet locale.
Dopo un nuovo cambiamento di orientamento del Consiglio per il lavoro e la difesa e una nuova organizzazione economica, passeremo anche a un altro sistema salariale. Ma mi fermerò prima alla remunerazione in natura, come è stata praticata nei primi anni dopo la Rivoluzione. Questa economia naturale è stata un importante tentativo di collegare organicamente il settore produttivo al settore del consumo, colmando così la lacuna che era stata aperta tra questi dal sistema capitalista. Se questa economia naturale avesse potuto proseguire, il commercio, come conquista capitalista, sarebbe diventato superfluo e condannato a scomparire. Purtroppo, non possiamo più continuare quest'ardita e storica esperienza. La nostra grande povertà, la crisi della nostra industria e il nostro completo isolamento dal mercato mondiale ci obbligano oggi a rinunciare e a riorganizzare la base della nostra economia nazionale. Ma la retribuzione in natura, come la gestione delle mense, è un modo di remunerazione che, in linea di principio, è anche ipotizzabile in un sistema di economia capitalista. Se queste forme di pagamento possono temporaneamente aumentare la produttività del lavoro, non possono però da sole condurre alla costruzione di un nuovo modo di produzione.
I tassi salariali attualmente in vigore sono soddisfacenti per le lavoratrici? Certo che no. L'approvvigionamento della popolazione nella Russia sovietica lascia ancora a desiderare. Le forniture in natura arrivano sempre in quantità insufficienti o in ritardo. Certo, non mancano i prodotti tessili e la legna da ardere e il petrolio sono spesso assegnati più rapidamente ai singoli consumatori che alle fabbriche. Ma i lavoratori sono ancora costretti ad acquistare beni al mercato nero. E i prezzi in costante aumento li mettono in una situazione difficile. Le difficoltà che i lavoratori incontrano ancora nella realtà, oscurano loro le impressionanti conquiste della Rivoluzione. D'altra parte, queste conquiste non sono messe in discussione dalla classe operaia. Se si proponesse ai lavoratori un ritorno al capitalismo, pochissimi sarebbero senza dubbio disposti ad abbandonare il futuro e reintegrare il passato borghese.
Per avere un'idea generale della situazione delle donne sotto la dittatura del proletariato, ora analizzeremo le normative generali sulla protezione del lavoro nella Russia sovietica. La conquista più importante della Rivoluzione per i lavoratori e le lavoratrici è stata naturalmente la giornata di otto ore. Qualora lo sviluppo delle forze produttive non consenta l'introduzione del sistema dei 3 x 8 (in cui tre squadre lavorano a turni ogni 8 ore), la durata della settimana lavorativa non deve tuttavia superare le 48 ore. Nei settori particolarmente insalubri, ad esempio nell'industria del tabacco e in alcuni stabilimenti chimici, la durata giornaliera del lavoro viene ridotta al massimo a sei o sette ore. Il lavoro notturno è vietato alle donne ed è limitato a sette ore per gli uomini. Il lavoro d'ufficio per gli impiegati e gli intellettuali è fissato a sei ore al giorno. La pausa di mezzogiorno deve avere una durata da mezz'ora a due ore. Ogni lavoratore ha diritto a un riposo settimanale di almeno 42 ore senza interruzione. Il congedo annuale è di quattro settimane per un anno, di due settimane per sei mesi. L'occupazione dei giovani al di sotto dei 16 anni è vietata e coloro che hanno tra i 16 e i 18 anni non devono lavorare più di sei ore al giorno.
In pratica queste istruzioni non sono purtroppo sempre rispettate. Durante gli anni febbrili della guerra civile, spesso ci si è visti costretti a derogare. In molti casi è stato necessario svolgere intensi lavori necessari alla difesa. La durata del congedo per i lavoratori di sesso maschile è stata ridotta a due settimane invece di quattro, il numero delle ore di lavoro straordinario e il lavoro notturno sono aumentati costantemente e i giovani di età compresa tra i 14 e i 16 anni sono stati autorizzati a lavorare quattro ore al giorno. Il 4 ottobre 1919, l'ufficio del commissario del Lavoro ordinò una regolamentazione speciale che stabilisce che il lavoro notturno può essere autorizzato alle donne in taluni settori dell'industria, previo accordo tra il sindacato e la commissione per la protezione del lavoro. Ma alle donne incinte e che allattano i loro figli, il lavoro notturno resta vietato.
Le leggi sul lavoro sovietiche proteggono le donne. Sono vietate ore straordinarie, lavoro notturno e lavoro femminile nelle miniere. Ma, a causa della significativa carenza di manodopera e della necessità di utilizzare tutte le forze disponibili nel processo di produzione, queste prescrizioni non sono generalmente rispettate.
Regolamenti speciali stabiliscono che le donne non devono eseguire lavori "al di sopra delle loro forze" o lavori dannosi per la loro salute in determinati settori produttivi. Ad esempio, una di queste norme vieta alle donne l'accesso a lavori in cui è necessario sollevare carichi superiori a dieci libbre. Ma tutte queste istruzioni di lavoro per i nostri uomini e le nostre donne sono per lo più lettera morta. Inizialmente i nostri delegati operai e contadini garantivano l'applicazione rigorosa di tali istruzioni. Tuttavia, la situazione caotica della nostra economia nazionale e la carenza di manodopera non hanno reso possibile l'attuazione di questa strategia. Mentre negli Stati capitalisti regna una disoccupazione endemica, la nostra repubblica operaia soffre costantemente di mancanza di manodopera.
Una protezione del lavoro adeguata e applicata richiederebbe nelle nostre fabbriche e nelle nostre officine, impianti sanitari adeguati. Ad esempio, l'installazione di dispositivi di ventilazione, di riscaldamento centralizzato e condotte che richiedono una manodopera qualificata, materiali da costruzione e una conoscenza tecnica che attualmente mancano alla nostra povera repubblica operaia. E' estremamente difficile aumentare l'intensità del lavoro in condizioni igieniche insostenibili e al contempo proteggere efficacemente la vita e la salute dei proletari. La nostra repubblica operaia non può ancora vantare una protezione generale del lavoro soddisfacente, ma può essere fiera della sua legislazione sociale nel settore della protezione materna e dell'assistenza ai neonati.
In questo settore, non solo abbiamo ampiamente superato i paesi finora più progressisti, ma siamo anche andati oltre le richieste più radicali dei socialisti. La risoluzione completa e programmata sulla base delle leggi sulla protezione materna è stata adottata al 1° Congresso delle lavoratrici di tutta la Russia, nel novembre 1919 (ndt 37). L'idea di base di questa legge è che solo le donne che sono impegnate in un'attività professionale hanno il diritto alla protezione materna dallo Stato, le donne, quindi, che non vivono dello sfruttamento di altra forza lavoro. Lo Stato garantisce 16 settimane di congedo di maternità a tutte le donne che svolgono un lavoro manuale. Le donne con un impiego burocratico o intellettuale hanno 12 settimane di congedo di maternità. L'importo del premio per il congedo di maternità è calcolato in base alla retribuzione complessiva, compresi i premi salariali e le ore di lavoro straordinario. Naturalmente anche le mogli dei lavoratori ricevono un premio dallo Stato, calcolato in funzione del reddito locale medio. Nel novembre 1920, l'ufficio del commissario del Lavoro emanò anche un decreto che equiparava i lavoratori che svolgevano un lavoro particolarmente faticoso alla categoria delle operaie dell'industria. Anche le telefoniste, le stenografe, le dottoresse, le infermiere, ecc. hanno diritto alle sedici settimane di congedo di maternità retribuite. Un successivo decreto del novembre 1920 garantisce alle donne incinte e alle madri la conservazione delle loro razioni di viveri e di legna da ardere durante il congedo.
Le madri che allattano il loro bambino ricevono un'indennità finanziaria supplementare nei primi nove mesi dalla nascita. La sovvenzione per l'allattamento corrisponde alla metà del salario minimo locale. Inoltre, ogni madre ha diritto ad articoli per i suoi bambini e a circa 10 metri di stoffa. Nonostante la grande carenza, la repubblica operaia si preoccupa delle madri e dei neonati. Recentemente la sezione per la protezione materna e l'assistenza ai lattanti ha distribuito alle madri vestiti per bambini. La legge sulla protezione del lavoro stabilisce che le madri che allattano non sono obbligate a lavorare in una località situata a più di due miglia dal proprio domicilio.
Abbiamo stabilito una razione unica per tutti i lavoratori. Questo significa che le sezioni armate dei lavoratori requisiscono forniture alimentari in campagna e poi queste vengono distribuite ai lavoratori secondo il sistema delle tessere di rifornimento.
Nel 1920 il costo della protezione materna ammontava a oltre 34 miliardi di rubli. Il compagno Lebedev ha giustamente osservato che tale assistenza da parte dello Stato è possibile solo sotto la dittatura del proletariato, perché la classe operaia è naturalmente interessata alla felicità delle generazioni future e questo già semplicemente perché queste generazioni si impegneranno a costruire la futura società comunista.
La protezione della maternità è, sul piano sociale, la più grande conquista della Rivoluzione. Questa iniziativa non solo facilita l'accesso delle donne alla collettività, ma facilita anche il compito naturale della donna nella società, ossia la maternità.
Concludiamo qui la nostra presentazione delle leggi generali sulla protezione del lavoro delle donne nella nostra attuale repubblica operaia. Riassumiamo un'ultima volta. Con l'introduzione del lavoro obbligatorio per tutti, il lavoro delle donne nella Repubblica dei Soviet ha acquisito una posizione decisiva a lungo termine. Oggi il lavoro delle donne nell'industria svolge un ruolo determinante. Sono due milioni di operaie su sei milioni di operai. Costituiscono quindi un terzo della forza lavoro dell'industria, dei trasporti, delle comunità agricole, dei kolchozy e dei servizi pubblici (uffici locali sovietici). Il governo sovietico ha realizzato il principio: "uguale lavoro, uguale salario", ma la mancanza di qualifiche professionali delle lavoratrici ha purtroppo portato al fatto che la maggioranza delle donne nella nostra repubblica continua, nei primi anni dopo la Rivoluzione, ad eseguire lavori non qualificati e mal pagati. Questa esperienza deve ora essere utilizzata dai partiti comunisti degli Stati capitalisti, in particolare dalle loro organizzazioni giovanili.
La questione della qualificazione professionale della gioventù operaia, sia maschile che femminile, deve essere attentamente presa in considerazione dal partito. Infatti, nel periodo della dittatura del proletariato, un'elevata formazione professionale va a vantaggio sia delle lavoratrici, che dell'economia socialista nazionale. Nella Russia sovietica la protezione giuridica del lavoro non è soddisfacente, ma noi garantiamo in modo importante la protezione del lavoro delle donne e la protezione materna. Il tentativo di pagare in natura fu rivoluzionario; tuttavia, abbiamo dovuto interrompere questa esperienza. Ma, grazie alle esperienze dei primi anni della Rivoluzione, siamo convinti che una simile iniziativa politica ed economica in condizioni diverse, possa essere perfettamente realizzabile.
E' così che concluderemo oggi la nostra conferenza.
* * *
ndt:
37) Si legga in proposito: "La Rivoluzione d'Ottobre e i diritti delle donne" di Margarida Botelho - omilitante.pcp.pt su Resistenze.org
Dodicesima conferenza - La dittatura del proletariato: il cambiamento rivoluzionario della vita quotidiana
Nelle due ultime conferenze abbiamo familiarizzato con le condizioni oggettive che fungono da punto di partenza per il sistema economico che il proletariato della Russia ha elaborato dalla sua presa di potere. Il lavoro obbligatorio per tutti è una componente molto importante di questo nuovo modo di produzione e abbiamo anche già dimostrato come la situazione della donna si sia profondamente modificata. Oggi, analizzeremo il ruolo che ha svolto il nuovo sistema economico sulla vita quotidiana, nelle abitudini, nella coscienza e nelle speranze delle persone ed analizzeremo anche le idee che sottendono a questo sistema economico che getta le basi per una società comunista.
Chiunque sappia vedere ed osservare riconosce che la vita quotidiana si è profondamente modificata. Nel corso degli ultimi quattro anni, la nostra repubblica operaia ha estirpato le radici stesse dell'asservimento secolare della donna. Il nostro governo sovietico mobilita le donne alla produzione e si sforza di riorganizzare la loro vita su basi interamente nuove. Si assiste ovunque alla nascita di comportamenti, di tradizioni, di punti di vista e di concezioni collettivistiche che preparano alla futura società comunista.
Una delle basi del sistema di produzione comunista è la riorganizzazione del consumo. La regolamentazione del settore del consumo, secondo i principi comunisti, non deve limitarsi a soddisfare i bisogni dei consumatori o ripartire in modo uniforme le ricchezze del paese (ndt 38). Fin dall'autunno del 1918 abbiamo adottato in tutte le città il principio delle mense pubbliche. Le mense comunali e i pasti gratuiti per i bambini e gli adolescenti hanno soppiantato l'economia familiare. Lo sviluppo e l'applicazione delle nostre mense pubbliche all'intera società sono rallentate purtroppo dalla nostra povertà e dalla mancanza di prodotti alimentari. Ma il principio del sistema di alimentazione collettiva è ormai entrato nella pratica e i centri di rifornimento vengono pianificati, anche se ci mancano ancora i viveri sufficienti per organizzare una distribuzione più razionale, programmata e centralizzata.
Gli Stati imperialisti hanno imposto al nostro paese impoverito un blocco ostinato ed efficace, impedendo la consegna dei prodotti da parte di altri popoli, prodotti di cui abbiamo bisogno e che assicurerebbero la distribuzione collettiva. Ora, a dispetto di queste difficoltà, le mense pubbliche sono diventate indispensabili nella vita quotidiana della popolazione delle città e questo nonostante l'insufficienza e la cattiva qualità dei pasti. I prodotti alimentari non solo sono insufficienti, ma in questo modo sono anche mal utilizzati. Tuttavia, durante gli anni 1919-1920, quasi il 90% della popolazione di San Pietroburgo e il 60% degli abitanti di Mosca frequentavano regolarmente le mense. Nel 1920 dodici milioni di cittadini, bambini compresi, hanno pranzato nelle mense pubbliche.
Va da sé che già solo questo fatto ha comportato un notevole cambiamento nella "vita quotidiana" delle donne. La cucina, che ancor più asserviva la donna con figli, ha cessato di essere una condizione necessaria all'esistenza della famiglia. Senza dubbio la cellula familiare privata svolge ancora un ruolo importante durante questo periodo di transizione e sarà così finché il comunismo resterà un obiettivo distante, fino a quando le norme di comportamento borghese non saranno eliminate completamente e le basi dell'economia nazionale non saranno modificate radicalmente. Ma anche in questo periodo transitorio, il focolare domestico comincia a perdere il suo posto d'onore. Appena saremo riusciti a soffocare la nostra povertà e la nostra fame e avremo fermato il collasso generale delle forze produttive, lavoreremo per migliorare la qualità delle mense pubbliche e la cucina casalinga sarà ridotta a un mero supporto, un complemento della cucina collettiva. Infatti l'operaia comincia già a rendersi conto del tempo che risparmia grazie ai pasti preparati dalla mensa e se si lamenta ancora delle mense lo fa contro l'insufficienza e il basso valore nutritivo dei pasti che vi sono attualmente distribuiti. Ed è per questo, volente o nolente, che è costretta a cucinare dei pasti supplementari. Se la qualità dei pasti fosse superiore, poche donne tornerebbero ai loro fornelli.
Nella società borghese, la donna utilizzava la sua arte culinaria per offrire il pranzo al suo sposo, per nutrirlo, perché egli era il suo nucleo familiare. Nello Stato operaio la donna è riconosciuta come persona indipendente e cittadina ed è difficile immaginare che esistano da noi donne che si prestino ad affaccendarsi ai fornelli per ore, per far piacere a loro marito. Dobbiamo prodigarci a rieducare gli uomini in modo tale che imparino ad amare e ad apprezzare la loro donna non per i suoi talenti culinari, ma per la sua personalità e le sue qualità umane. Nella storia della donna la "separazione della cucina dal matrimonio" è una grande riforma, non meno importante della separazione della Chiesa dallo Stato.
Tuttavia, nella pratica, questa separazione è ancora da venire (ndt 39), ma fin dai primi mesi dopo la Rivoluzione, la nostra repubblica operaia ha cominciato ad organizzare le mense pubbliche. Queste mense, contrariamente all'economia domestica familiare e privata, sono un impianto economico e razionale, che necessita di meno fatica, meno combustibile e meno prodotti alimentari. Queste esperienze pratiche sono per noi estremamente importanti e ci permettono di elaborare la linea direttrice di sviluppo del nostro futuro politico economico. D'altra parte l'aggravamento della situazione economica ha reso sempre più pressante la necessità di organizzarle.
Le condizioni di vita e il grado della coscienza delle donne sono naturalmente anche influenzate dalle nuove condizioni degli alloggi. In nessuno paese ci sono tante case comunitarie come nella nostra Repubblica operaia. L'alloggio comunitario, la casa collettiva per famiglie e anche per donne sole, sono largamente diffuse da noi. Chiunque del resto, aspira a sistemarsi in una casa comune.
Non per "principio"ovviamente, non per convinzione, come i fourieristi della prima metà del XIX° secolo che, sotto l'influenza delle idee socialiste di Fourier, organizzavano il falansterio , ma semplicemente perché è molto più facile e più comodo vivere in una casa comune, piuttosto che in un alloggio privato. Le comuni hanno legna ed elettricità a sufficienza; nella maggior parte di esse, esiste una cucina comunitaria e una caldaia per l'acqua. I lavori di pulizia sono effettuati dalle donne delle pulizie salariate. In certe comunità, c'è una lavanderia centrale, un asilo nido, una scuola materna. Mentre la crisi generale dell'economia nazionale si fa sentire appena il combustibile diminuisce e l'acqua rischia il razionamento, ci sono sempre più persone che si aggregano ad una casa comune. Le liste di attesa per le "residenze comunitarie" aumentano incessantemente e gli abitanti di queste sono invidiati dagli abitanti degli alloggi privati.
Certo, le case comunitarie sono ancora lungi dall'avere soppiantato gli alloggi privati e la grande maggioranza dei cittadini deve continuare a vivere sotto il regime dell'economia domestica e nelle cellule familiari isolate. Ma noi abbiamo intrapreso il percorso per il superamento delle norme sociali della vita della famiglia tradizionale. Se è sotto la pressione delle condizioni economiche difficili che non solo individui, ma anche famiglie desiderano stabilirsi nelle "residenze comunitarie", ci preme che queste diventino fin d'ora la preferenza degli abitanti delle città per molteplici ragioni. Inoltre appena la produzione avrà preso a svilupparsi e le "comuni" saranno migliorate, sosterranno senza problemi la concorrenza con l'economia familiare privata, dove le forze del lavoro femminile sono dilapidate.
Man mano sempre più donne sono coscienti dei vantaggi che presenta la vita in comunità, soprattutto coloro su cui pesa di più il doppio carico del lavoro e della famiglia. E' proprio precisamente alle donne che esercitano un'attività lavorativa, che la vita in comunità porta aiuto e sollievo senza paragoni. La cucina comune, la lavanderia centrale, l'approvvigionamento assicurato del combustibile, acqua calda ed elettricità, così come il lavoro delle donne delle pulizie salariate, risparmia a queste donne le molteplici faccende domestiche. Ogni donna che lavora non dovrebbe augurarsi altro che una cosa sola: che le case comunitarie si moltiplichino, per porre fine così al lavoro domestico estenuante e improduttivo a cui è stata fin'ora confinata.
Resta beninteso ancora l'esistenza di donne che continuano ad aggrapparsi ostinatamente al passato. Come chi vuole dedicare allo "sposo" l'esistenza intera esclusivamente ai fornelli. Anche nelle case comuni queste specie di prigioniere - spesso anche mogli di operai- trovano il modo di dedicare la loro vita all'arte culinaria. Ma con l'instaurarsi definitivo del modo di produzione comunista, questi esseri sfruttati saranno condannati storicamente a sparire. L'esperienza di questi ultimi anni della Rivoluzione conferma che le case comuni rappresentano non solo la soluzione più razionale alla questione della casa, ma facilitano innegabilmente la vita delle donne che lavorano. Anche nel periodo di transizione attuale, le donne che vivono in comune dispongono già di più tempo per occuparsi della loro famiglia e del loro mestiere.
L'economia familiare individuale sparirà necessariamente, come aumenterà il numero delle "residenze comunitarie" che dispongono di unità individuali sistemate secondo il gusto di ciascuno. E a questa scomparsa corrisponderà quella della famiglia borghese. Avendo smesso di essere un'unità economica della società capitalista, la famiglia non potrà esistere più sotto la sua attuale forma. Questa affermazione tuttavia, non minaccia ancora i troppi partigiani della famiglia borghese, né la sua economia individuale e ripiegata su se stessa. In questo periodo di transizione dal capitalismo al comunismo, nell'epoca dunque della dittatura del proletariato, una lotta violenta ed aspra è cominciata tra il consumo collettivo e l'economia familiare privata. Resta purtroppo molto da fare in questo campo. Le forme di economia collettiva riusciranno ad imporsi soltanto se la parte della popolazione più direttamente interessata - le nostre donne lavoratrici - parteciperà attivamente al cambiamento. (ndt 40)
Benchè i dati statistici della nostra repubblica siano ancora scarsi riguardo agli alloggi, le informazioni di cui disponiamo su Mosca bastano ampiamente per permetterci di affermare l'importanza del ruolo sociale delle case comuni nelle grandi città. Così, nel 1920 a Mosca, su 23.000 case si contavano quasi 9.000 comuni o case comuni, intorno al 40%. Fin dai primi anni della sua esistenza la repubblica dei Soviet ha creato le condizioni necessarie per liberare, lentamente, ma in modo certo, la donna dai compiti domestici.
La riduzione del lavoro improduttivo della donna nell'economia domestica è soltanto un aspetto della problematica generale, poiché la donna è anche responsabile dell'educazione e della cura dei bambini. Anche questo compito impegnativo inchioda la donna alla casa e l'asservisce alla famiglia. Ma, per sua politica, il governo dei Soviet protegge la funzione sociale della maternità e alleggerisce notevolmente la donna dal fardello dell'educazione dei bambini, riconducendolo alla collettività.
Nella sua ricerca di nuovi stili di vita proletari, la Repubblica sovietica ha commesso degli errori inevitabili e ha dovuto più di una volta modificare e correggere la sua linea politica. Ma nel campo della protezione materna e della protezione del lavoro delle donne, la nostra repubblica operaia ha scelto una sola via. Ed è proprio in questo campo che si avvera oggi una grande e profonda rivoluzione delle tradizioni e delle opinioni perché, da un lato, abbiamo eliminato la proprietà privata dei mezzi di produzione e dall'altro, abbiamo costruito politiche familiari in funzione dell'industrializzazione del nostro paese. Siamo riusciti senza dubbio a risolvere il problema più importante che era rimasto senza soluzione nella società capitalista.
Così abbiamo affrontato il problema della tutela della maternità in stretta connessione con le attività economiche più importanti: lo sviluppo delle forze produttive del paese, la riconversione e l'espansione della produzione. Per realizzare questa ricostruzione economica occorre liberare le forze di lavoro potenziali dalla loro fatica improduttiva e utilizzare razionalmente le riserve di manodopera disponibili. Questo anche perché dobbiamo badare particolarmente alle generazioni future per garantire l'esistenza della nostra repubblica operaia. Il governo apre attualmente delle prospettive assolutamente nuove. Se le accettiamo, dobbiamo ammettere che i problemi dell'emancipazione della donna e della maternità si risolveranno da soli.
La cura e l'educazione delle future generazioni non sono più compiti privati e familiari, sono ricondotti d'ora in poi allo Stato e alla società. La protezione della maternità deve essere assicurata non solo in riferimento alla donna, ma anche perché dovendo lo Stato operaio risolvere in questo periodo di transizione dei compiti economici importanti, deve liberare le donne dai compiti domestici improduttivi al servizio della famiglia affinché possano lavorare in modo efficace - anche nell'interesse della famiglia stessa. La salute delle donne deve essere oggetto di attenzioni particolari perché è il solo modo per garantire la crescita normale della nostra repubblica operaia.
Nella società borghese l'antagonismo di classe, il frazionamento della società in cellule familiari private e naturalmente anche il modo di produzione capitalista impediscono di dare soluzioni al problema della protezione della maternità. Al contrario, nella repubblica dei Soviet nella quale l'economia familiare privata è subordinata all'economia collettiva pubblica, la soluzione del problema della protezione materna è dettata dalle dinamiche sociali, dalla necessità e dalla vita stessa. D'altra parte la Repubblica Sovietica considera la donna come una forza lavoro viva, potenziale e attuale. La maternità dunque ha cessato di essere da noi un affare privato, familiare; la funzione materna è una funzione importante sebbene sia complementare, ma è soprattutto una funzione sociale della donna. La compagna Vera P. Lebedjeva dice su questo argomento: "La madre e il bambino sono un elemento della nostra politica di inclusione delle donne nel processo del lavoro"
Ma se vogliamo dare alle donne la possibilità di partecipare alla produzione, la collettività deve scaricarle dal pesante fardello legato alla maternità ed evitare così lo sfruttamento di questa funzione naturale da parte della società stessa. Lavoro e maternità sono compatibili a partire dal momento in cui l'educazione dei bambini smette di essere un compito familiare privato per diventare un'istituzione sociale, un affare dello Stato. Il nostro governo dei Soviet si preoccupa della cura e dell'educazione dei bambini. La sezione di protezione della maternità e dell'infanzia, sotto la direzione di Vera P. Lebedjeva, così come il settore dell'educazione sociale, ha assunto questo compito.
La madre deve essere scaricata dal fardello della maternità e deve potere approfittare pienamente della relazione col suo bambino.
Questo obiettivo è, beninteso, ancora lontano dall'essere raggiunto. Nella realizzazione dei nuovi stili di vita proletari che devono liberare le donne dai loro compiti familiari, urtiamo ancora sempre contro lo stesso ostacolo: la povertà economica. Tuttavia, abbiamo predisposto le basi necessarie alla soluzione del problema della maternità e abbiamo indicato la via da seguire. Non ci resta adesso che impegnarci risolutamente.
Nell'ultima conferenza, ho presentato le misure sociali e politiche prese a riguardo delle madri. Ma la repubblica operaia non si limita a garantire una protezione materiale e finanziaria della maternità. Cerca innanzitutto di cambiare le condizioni di esistenza delle donne in modo tale che siano pienamente in grado di assumere la loro maternità e per altro protegge i bambini prodigando loro le cure necessarie alla salute e allo sviluppo. Questo perché, fin dall'inizio della Rivoluzione, la nostra dittatura del proletariato ha intrapreso la decisione di organizzare tutto il paese in una stretta rete di organismi di protezione materna e di educazione sociale. Quando fui nominata commissario del popolo all'Assistenza pubblica (ndt 41), la mia prima preoccupazione è stata di lavorare all'elaborazione del decreto sulla protezione materna.
E' per questo motivo e grazie al commissariato del popolo alla Salute che creava una sezione incaricata della protezione delle madri e dei bambini e fondava il "palazzo della maternità, sotto la direzione energica del compagna Véra P. Lebedjeva, che il sistema di protezione materna ha messo radici ed è sbocciato. Nella Russia zarista, c'erano in tutto sei consultori per le donne incinte e le balie. Oggi, se ne contano già più di 200, così come 138 centri per l'allattamento.
La maternità non consiste necessariamente nel lavare i pannolini per il proprio bambino, fargli il bagno, cambiarlo ed essere inchiodata alla sua culla. Il nostro principale compito è di sgravare la donna che lavora dalle cure da dare ai bambini, dunque: la funzione sociale della maternità consiste innanzitutto nel mettere al mondo dei bambini. Questo anche perché la nostra società proletaria garantisce alle donne incinte le condizioni più favorevoli al parto. La donna, da parte sua, deve osservare le regole di igiene prescritte e deve ricordarsi che durante i nove mesi di gravidanza smette in un certo modo di appartenersi. È insomma al servizio della collettività e il suo corpo "produce" un nuovo membro per la repubblica operaia. Un altro dovere della donna che consegue alla funzione sociale della maternità è di allattare il suo bambino. Solo la donna che ha nutrito il suo bambino al seno ha assolto verso questi il suo dovere sociale. Le altre cure che richiede la maternità possono allora essere date in carico dalla collettività. Tuttavia, l'istinto materno non deve essere represso. Ma perché la madre dovrebbe dispensare unicamente le sue cure e il suo amore al proprio bambino? Non varrebbe la pena che le madri utilizzassero questo prezioso istinto in modo più intelligente, rivolgendolo, per esempio, a tutti i bambini che hanno bisogno di amore e di tenerezza?
La parola d'ordine: "Sii madre non solo per il tuo bambino, ma per tutti i bambini degli operai e dei contadini" deve insegnare alle donne lavoratrici un nuovo modo di vedere la maternità. Si può accettare, per esempio, che una madre, forse anche comunista, rifiuti il suo seno ad un bambino che non ha latte di cui nutrirsi? L'umanità futura, con sentimenti e concezioni comuniste, sarà un giorno completamente estranea al comportamento egoista e antisociale, come lo siamo noi quando leggiamo di donne delle tribù primitive che, pur amando i propri bambini, sono capaci di uccidere i bambini di una tribù straniera.
Altra anomalia, possiamo ammettere che una madre privi semplicemente il proprio bambino del latte del suo seno perché la maternità è per lei un carico troppo pesante?
In Unione sovietica, ahimè!, il numero dei bambini abbandonati dai loro genitori non smette di crescere. Questi fenomeni ci obbligano a risolvere in modo soddisfacente il problema della maternità. Ma ancora non ci siamo arrivati. Nel difficile periodo di transizione che viviamo, centinaia di migliaia di donne sono afflitte da un doppio fardello: il lavoro salariato e la maternità. Non ci sono abbastanza asili nido, giardini d'infanzia, scuole materne e i sussidi attribuiti alle madri, non stanno al passo con la crescita dei prezzi del mercato libero. Queste condizioni conducono le donne lavoratrici a temere il fardello della maternità e ad "abbandonare" i loro bambini allo Stato. Ma l'incremento del numero dei bambini abbandonati significa anche che le donne non sempre hanno compreso che la maternità non è solamente un affare privato, ma che è innanzitutto un dovere sociale.
Si dovrà lavorare con le donne e si dovrà prestare particolare attenzione a questo problema spiegando alle operaie delle fabbriche, alle contadine e alle braccianti quali sono i doveri che comporta la maternità nella nostra repubblica. Parallelamente, bisognerà rinforzare la rete per la protezione materna e migliorare il sistema di educazione sociale. Più le madri potranno conciliare facilmente il lavoro e la maternità, meno ci saranno bambini abbandonati.
Precisamente abbiamo appena detto che la maternità non significa affatto che il bambino debba restare costantemente vicino a sua madre, né che questa sia l'unica a dedicarsi alla sua educazione fisica e morale. Ma, d'altra parte, il dovere della madre verso il bambino è anche di procurare le migliori condizioni alla sua crescita e al suo sviluppo.
In quale classe della società borghese si trovano bambini più sani e più svegli? Nelle classi più avvantaggiate si, ma in nessun caso nella classe povera. A che cosa è dovuto ciò? Al fatto che le madri borghesi si dedicano interamente all'educazione dei loro bambini? Assolutamente no. Le madri borghesi scaricano volentieri la cura dei loro bambini su quelle salariate: nutrici, governanti. Solamente nelle famiglie povere le madri sono le uniche a sopportare tutto il peso della maternità. La maggior parte del tempo i loro bambini sono affidati a loro stessi e alla strada che diventa il loro unico educatore. Nella classe operaia e in generale, negli strati poveri della popolazione dei paesi borghesi i bambini restano vicino alla loro madre, ma muoiono come le mosche; quanto a un'educazione che merita questo nome, non se ne parla nemmeno. Anche nella società borghese una madre cosciente e progressista cerca di spostare una parte dei suoi compiti educatrici alla società: manda il suo bambino all'asilo nido, alla scuola, in colonia estiva. Una madre cosciente comprende naturalmente che l'educazione sociale può portare al bambino qualche cosa che non può essere sostituito dal solo amore materno. (ndt 42)
Nella società borghese le classi abbienti accordano un grande valore all'educazione dei loro bambini che affidano alle bambinaie, alle maestre da asilo, ai medici e pedagoghi specializzati. Persone salariate hanno sostituito la madre nelle cure fisiche e nell'educazione morale. Queste madri hanno conservato in realtà solamente l'obbligo naturale ed inevitabile, mettere i loro bambini al mondo.
Beninteso, la Repubblica sovietica non strappa con la forza i bambini alla loro madre, come i paesi borghesi affermano nella loro propaganda per descrivere gli orrori del "regime bolscevico". Ma si sforza di creare delle istituzioni nelle quali non solo i bambini delle donne ricche, ma anche i bambini di tutte le donne possano crescere in condizioni normali e sane. Mentre le donne borghesi riversano la cura dei loro bambini sulle forza lavoro salariata, la repubblica dei Soviet vuole raggiungere quello che ogni madre, operaia o contadina, aspira: poter andare al proprio lavoro a cuor leggero, sapendo che i suoi bambini sono in buone mani al nido, all'asilo o a scuola. Queste istituzioni sociali aperte a tutti i bambini sotto i sedici anni sono le condizioni necessarie per l'avvento dell'uomo nuovo. In queste situazioni pedagoghi e medici si prendono cura dei bambini spesso aiutati dalle loro stesse madri (è obbligatoria nei nidi una presenza materna). Fin dalla loro prima infanzia, i bambini cresciuti nei nidi e nelle scuole materne sviluppano caratteri e abitudini necessarie all'avvento del comunismo. I bambini che crescono in queste istituzioni saranno molto più attivi nel vivere in una comunità di lavoratori di quelli in cui l'infanzia è trascorsa nella stretta sfera familiare.
Vedete voi stessi i bambini che, fin dai primi anni della Rivoluzione, hanno frequentato i nidi e le case dei bambini. Questi sono bambini che hanno beneficiato di un'educazione amorevole e ricca di sollecitazioni della propria classe. Questi bambini hanno acquisito un comportamento di "gruppo", pensano ed agiscono in modo collettivo. Piccola scena abituale in una casa di bambini: un ultimo arrivato non vuole prendere parte alle attività del suo gruppo. Gli altri bambini si radunano intorno a lui e tentano di convincerlo. L'ambiente è particolarmente agitato. "Non puoi davvero aiutare a pulire e a sistemare quando il nostro gruppo è di servizio? Non vuoi davvero andare in passeggiata, quando tutto il nostro gruppo l'ha deciso? Sei obbligato veramente a fare tutto questo rumore, quando tutto il nostro gruppo si riposa? Nei bambini, il senso della proprietà non esiste: "Da noi, non c'è tuo e mio, tutto è per tutti", spiega con un'aria seria un ragazzino di quattro anni ad una bambina della stessa età. Un'altra regola fondamentale della vita di questi bambini è quella di proteggere gli oggetti che appartengono al gruppo ed essi sono pronti ad intervenire appena viene distrutto un "nostro" bene della casa dei bambini.
Ma ritorniamo ancora una volta al ruolo dalle madri. La Repubblica sovietica ha creato case materne ovunque il bisogno si faceva sentire e ciò per proteggere la salute delle donne in quanto madri delle generazioni future. Nel 1921, c'erano 135 asili che permettevano alle ragazze madri di trovare un rifugio nel periodo più difficile della loro vita. Ma queste case sono anche aperte alle donne sposate che possono così sfuggire alla vita di famiglia e alle sue innumerevoli preoccupazioni durante gli ultimi mesi della loro gravidanza e i primi mesi della vita del loro bambino. Durante le prime settimane dopo la nascita - le più importanti - la madre si potrà così occupare esclusivamente della cura del proprio bambino e contemporaneamente riposare. Più tardi, la presenza costante della madre vicino al bambino conterà molto meno. Ma sembra che, durante le prime settimane dopo la nascita, esista un tipo di legame fisiologico estremamente forte tra madre e bambino per il quale sarebbe nocivo dividerli.
Non siete probabilmente a conoscenza del fatto che questi asili per donne, case materne, sono prese da assalto dalle donne celibi e dalle stesse donne sposate per la semplice ragione che qui vengono curate correttamente e trovano il riposo necessario. Non è dunque assolutamente indispensabile fare propaganda presso le donne delle case materne. La nostra povertà materiale e il caos attuale in cui si trova immersa la Russia non ci permette, ahimè! di costruire altre case di questo tipo coprendo così tutta la repubblica operaia di queste vere "stazioni di soccorso" per donne lavoratrici. Praticamente nelle campagne non c'è nessuna casa materna. Le contadine sono lasciate in generale al loro destino, niente è stato organizzato praticamente ancora per esse, eccetto i giardini estivi per i bambini. Questi ultimi permettono alle contadine di partecipare ai lavori dei campi senza che i bambini possano patirne. Nel 1921 sono stati realizzati 689 giardini estivi per 32.180 bambini.
Nelle città ci sono a disposizione delle operaie e delle impiegate nidi ed asili sul luogo di lavoro e ancora nidi ed asili di quartiere. Inutile sottolineare che queste istituzioni portano alle donne che lavorano un sollievo considerevole. La nostra più grande preoccupazione è che non ce ne siano abbastanza. Riusciamo attualmente appena a coprire il 10% dei bisogni reali. Per sgravare efficacemente le madri dalle preoccupazioni opprimenti legate alla maternità, la rete di educazione sociale dovrebbe comprendere altri nidi e scuole materne, scuole per i bambini da tre a sette anni e per gli altri bambini in età scolare, circoli di bambini, case della gioventù e colonie estive. In queste istituzioni, i bambini sono nutriti gratuitamente. La compagna Vera Veletchkina fu una pioniera particolarmente attiva in questo campo e vi dedicò la vita. La sua azione, all'epoca dei duri anni della guerra civile, ci ha aiutato a salvare numerosi bambini di proletari dall'inedia e dalla morte. Questi bambini ricevevano delle razioni di latte supplementare e i più bisognosi, vestiti e scarpe.
Ma queste istituzioni sociali sono insufficienti e noi non siamo riusciti che a raggiungere una piccola parte dalla popolazione. Tuttavia, non ci si può rimproverare di avere scelto una via sbagliata, perché è giusto alleggerire i genitori del pesante compito di educare i bambini. La nostra maggiore incapacità viene piuttosto della nostra grande povertà che non ci permette di applicare interamente il programma del governo dei Soviet. Ma la direzione che abbiamo intrapreso per risolvere il problema della maternità è giusta e solo lo stato delle nostre risorse è l'ostacolo alla sua realizzazione. Per il momento i nostri tentativi sono stati modesti. Tuttavia sono stati coronati già dal successo, perché hanno rivoluzionato lo stile di vita familiare e portato un cambiamento radicale nelle relazioni tra i sessi. Ritorneremo su questo tema nella nostra prossima conferenza.
La repubblica dei Soviet deve fare in modo che la forza lavoro della donna non sia assorbita da un lavoro improduttivo, come la cura della casa e la cura dei bambini, ma che sia adoperata in modo giusto per la produzione delle nostre ricchezze sociali. In più, la società deve proteggere gli interessi e la salute delle madri e dei bambini, per permettere alle donne di conciliare maternità e vita lavorativa. Il governo dei Soviet si sforza anche di procurare rifugi sicuri alle donne che vogliono separarsi dal loro marito e non sanno dove andare coi loro bambini. Non appartengono ai filantropi e alla loro carità umiliante, ma allo Stato operaio a cui compete venire in aiuto alle donne in difficoltà e ai loro bambini. Sono i propri compagni di classe che lavorano per l'edificazione del socialismo, gli operai e i contadini che devono sforzarsi di alleggerire la donna dal fardello della maternità. Poiché la donna che lavora uguale all'uomo per il ristabilirsi dell'economia e che ha partecipato alla guerra civile, è legittimata a esigere dalla collettività la presa in carico, nel momento in cui lo mette al mondo, di un futuro membro della società.
Nel periodo attuale di transizione, la donna si trova collocata in una situazione particolarmente difficile, perché non esistono ancora nella Russia Sovietica che 524 istituzioni materne. Queste istituzioni sociali sono evidentemente insufficienti. E' per questo che il partito ed il governo dei Soviet devono prestare una doppia attenzione al problema della maternità e ai mezzi per risolverlo. La sua risoluzione pratica porterà beneficio non solo alle donne, ma anche a tutta la nostra produzione e all'insieme dell'economia nazionale.
Alla fine di questa conferenza aggiungiamo alcune parole su un argomento strettamente legato al problema della maternità: l'atteggiamento del repubblica Sovietica rispetto all'aborto. Con la legge del 18 novembre 1920, l'interruzione di gravidanza è stata legalizzata. Soffriamo naturalmente in Russia, di una penuria di forza di lavoro, che manca. Il nostro paese non è un paese sovrappopolato, ma sotto-popolato e la nostra forza lavoro è contata. Come abbiamo allora potuto legalizzare l'aborto in tali condizioni? Perché il proletariato non ama praticare una politica di menzogna e di ipocrisia. Finchè le condizioni di vita resteranno precarie, le donne continueranno ad abortire. (Lasciamo da parte le donne borghesi che hanno generalmente altre ragioni per abortire: per evitare di dividere l'eredità, per timore delle sofferenze della maternità, per non rovinare la propria linea, per incapacità a rinunciare ad una vita di piacere, in breve, per comodità e per egoismo.)
L'aborto esiste in tutti i paesi e nessuna legge fino ad oggi è riuscita ad estirparlo. Le donne trovano sempre una via d'uscita, ma il ricorso alla clandestinità distrugge la loro salute, le mette in condizione di essere a carico dello Stato e diminuisce, in fin dei conti, il serbatoio di forza lavoro. Un aborto fatto da un chirurgo in condizioni normali è molto meno pericoloso per la donna e lei può reintegrare più velocemente la produzione. Il governo sovietico è cosciente che l'aborto sparirà solamente quando la Russia disporrà di una vasta rete di istituzioni di protezione materna e di educazione sociale. È anche cosciente che la maternità è un dovere sociale. Ecco perché abbiamo legalizzato la pratica dell'aborto che si svolge d'ora in poi negli ospedali e in buone condizioni igieniche.
Un altro compito della repubblica operaia è di rinforzare nelle donne l'istinto materno - da una parte creando delle istituzioni di protezione materna e dall'altra rendendo la maternità compatibile col lavoro per la collettività - eliminando così la necessità dell'aborto. Questo è il modo in cui abbiamo affrontato la soluzione di questo problema, che ancora si pone, in tutta la sua ampiezza, alle donne degli Stati borghesi.
Le donne degli Stati borghesi lottano con accanimento contro il doppio sfruttamento conseguenza di questo terribile periodo di dopoguerra: il lavoro salariato e la maternità al servizio del capitale. Nello Stato operaio, al contrario, le operaie e le contadine hanno eliminato i vecchi stili di vita che avevano ridotto le donne alla schiavitù.
Le donne, con la loro partecipazione al Partito comunista, hanno contribuito ad edificare le basi di una vita interamente nuova. Ma il problema potrà essere risolto definitivamente solamente quando il lavoro delle donne sarà stato integrato completamente nella nostra economia nazionale. Nella società borghese, in compenso, dove l'economia domestica compressa all'interno dello stretto ambito famigliare completa il sistema economico capitalista, le donne non hanno alcuna possibilità.
La liberazione della donna può compiersi soltanto con una trasformazione radicale della vita quotidiana. E la vita quotidiana stessa potrà essere modificata unicamente da una modificazione profonda di tutta la produzione, edificata sulle basi dell'economia comunista. Noi siamo oggi testimoni di questa rivoluzione nella vita quotidiana ed è per questo che liberazione pratica delle donne è diventata parte integrante della nostra vita.
* * *
ndt:
38) per approfondire l'argomento: "Caratteristiche del sistema tributario sovietico" di Mario Luna - novembre 1951 - Rinascita, anno VIII, n.12, 1951 - Trascrizione a cura del Centro di Cultura e Documentazione Popolare
39) per approfondire l'argomento: "Donne e famiglia nella Russia Sovietica dagli anni Venti agli anni Quaranta" di Cristina Carpinelli - Centro Culturale La Città del Sole - Convegno - Napoli, 21-23 novembre 2003: I problemi della transizione al socialismo in URSS - su Resistenze.org
40) Si consiglia la lettura: Corso a dispense di Economia Politicadi Renato Ceccarello Prima parte: economia politica marxista - Il mercato e la divisione del lavoro su Resistenze.org - materiali resistenti in linea - formazione
41) da ottobre 1917 a marzo 1918
42) per approfondire: "Consigli ai genitori" Anton Makarenko La città del sole, 2005 Consulta il libro nella Biblioteca digitale Mels
Tredicesima conferenza - La dittatura del proletariato: la rivoluzione dei costumi
Nella nostra precedente conferenza abbiamo parlato della rivoluzione nella vita di tutti i giorni con la dittatura del proletariato. Questo processo, ovviamente, non si limita alla nascita delle mense pubbliche e degli asili nido, né solo all'introduzione della protezione materna e dell'educazione sociale. L'attuale cambiamento nella società è molto più profondo e più ampio; raggiunge quasi ogni area della nostra vita e la sua influenza è particolarmente forte sulla morale e sulla mentalità. In futuro, gli storici studieranno con interesse il nostro tempo, che rompe con il passato in maniera considerevole. Il nuovo ordine sociale ed economico che stiamo costruendo crea differenti fondamenta di relazioni tra le persone. E tutto questo sta andando estremamente veloce, troppo veloce per noi che non siamo in grado di vedere cosa sarà o non sarà importante per il futuro. Non possiamo ancora discernere tra i campi di battaglia della Guerra Civile i giovani germogli del futuro comunista, coperti dai detriti, dal sangue e dalle lacrime del passato. Ma la polvere dei secoli è stata sollevata come in un tornado dalla feroce mischia di due mondi ostili e poi finalmente spazzata via. Il ghiaccio si è rotto e i raggi del sole riscaldano la terra ammorbidita e purificata dai corsi d'acqua primaverili.
Guardatevi intorno: è la stessa Russia di soli cinque anni fa? Sono le stesse operaie, le stesse contadine, anche le stesse piccolo borghesi che abbiamo conosciuto durante la dittatura dello zarismo? I loro pensieri, sentimenti, il contenuto del loro lavoro sono cambiati. Nell'Unione sovietica c'è un'atmosfera completamente diversa. Quando uno di noi torna in un paese capitalista borghese, si sente come se vivesse nuovamente in un altro secolo. Siamo stati spinti bruscamente verso il futuro ed è da lì che giudichiamo la realtà di questi paesi arretrati da un punto di vista rivoluzionario. È attraverso la nostra esperienza che siamo venuti a conoscere concretamente il futuro e i nostri fratelli dei paesi capitalisti borghesi possono capirlo solo con il pensiero e non con la loro stessa pratica. La Rivoluzione che ci ha permesso questa enorme esperienza, ci ha portato via dal passato molto vicino e ancora attuale e contemporaneamente ci ha avvicinato al futuro. È quindi più facile per noi guardare avanti, che indietro. Abbiamo raggiunto un notevole vantaggio sui nostri compagni che non hanno vissuto questi anni di lotta rivoluzionaria. La nostra esperienza febbrile e la nostra ricerca della "via più breve" al comunismo ci hanno insegnato a cogliere i problemi molto più velocemente di prima della Rivoluzione. E anche se abbiamo commesso molti errori, la nostra esperienza rivoluzionaria rimane il più audace tentativo da parte di una comunità di milioni di persone di cambiare le condizioni di vita e cercare di padroneggiare le leggi cieche dell'economia capitalista. La rivoluzione operaia in Russia ha aperto un nuovo capitolo nella storia dell'umanità e sebbene la strada per il comunismo rimanga lunga e difficile, abbiamo almeno gettato le basi per un'organizzazione comunista della società. E il proletariato, fiducioso di se stesso e dell'importanza del suo ruolo storico, marcerà senza errori verso il suo fine ultimo. Questo obiettivo ha già cessato di essere un sogno vuoto; la classe operaia, raggiungendo il futuro, può già sentire la realtà comunista sulla punta delle dita.
I cambiamenti sociali che si sono verificati a seguito della Rivoluzione d'Ottobre si riflettono soprattutto nella mentalità del lavoratore e nel suo nuovo modo di pensare alla vita. Parlate con le operaie! Erano così prima della Rivoluzione? Prima della Rivoluzione, gli operai mancavano di fiducia in loro stessi. Erano spesso schiavi sottomessi, schiacciati dalla miseria, impotenti e amareggiati. E le leggi ingiuste che li opprimevano e li umiliavano apparivano loro come immutabili. Se gli fosse stato detto: "Potete prendere il potere, è sufficiente che milioni di proletari lo vogliano", avrebbero annuito, increduli.
E oggi? È vero, la vita è ancora difficile per il proletario, soffre ancora della carenza di cibo, vestiti e scarpe. La classe operaia soffre ancora di numerose privazioni e di sacrifici incalcolabili, ma ha fiducia in se stessa e nelle proprie forze. Il suo più grande risultato è aver capito che l'intera società può essere cambiata sotto la sua guida, a condizione che non ci si accontenti di semplici riforme legislative senza cambiare le relazioni umane. La dittatura degli zar, degli industriali e dei proprietari terrieri è completamente diversa dalla dittatura del proletariato (ndt 43). Questa è maestra del suo destino ed edificatrice di una nuova società. E anche se la classe operaia non è ancora molto abile, l'essenziale per il momento è di essere riuscita ad appropriarsi del potere nello Stato. La sua vittoria più importante nella storia dell'umanità è quella di essere riuscita a padroneggiare collettivamente le leggi dell'evoluzione economica e di aver messo fine all'accumulazione capitalistica.
Approfondiremo questo processo prendendo come esempio l'operaia, per la quale la mutazione è ancora più tangibile che per l'operaio. Per la maggior parte delle nostre donne e grazie al lavoro per la collettività, il fatto più caratteristico è lo sviluppo di una consapevolezza sociale e di un vero senso di solidarietà sociale. Questo è particolarmente nuovo e rivoluzionario per la donna, che è stata educata per secoli a rendere la sua famiglia l'unica attenzione e preoccupazione. L'operaia o la moglie dell'operaio è ora certa di essere una cittadina a pieno titolo. Anche se non tutte le donne sono ancora impegnate nel lavoro sociale, sentono comunque il bisogno di essere valorizzate agli occhi della società. Si lamentano del pesante onere che i lavori domestici e l'educazione dei bambini rappresentano per loro e criticano l'insufficienza degli istituti per bambini e la scarsa qualità dei pasti distribuiti nelle mense. Perché, se tutto va bene, anche loro potrebbero lavorare in una sezione femminile del partito o partecipare alle riunioni di un sindacato.
La rivoluzione non solo ha liberato la donna dall'atmosfera soffocante della famiglia permettendole di accedere all'ambito sociale, ma ha anche instillato con sorprendente rapidità un sentimento di solidarietà verso la collettività. Il successo del movimento subbotnik [sabato comunista] durante la guerra civile ne è un esempio lampante. Le operaie, organizzate e disorganizzate, le lavoratrici e i contadini hanno partecipato volontariamente ai nostri sabati comunisti. Nel 1920 per sedici Province vi furono 150.000 partecipanti. Questo testimonia naturalmente l'evoluzione della coscienza sociale della donna che si rende conto che solo uno sforzo collettivo può superare disorganizzazioni, epidemie, freddo e fame. Il lavoro volontario per la collettività ha completato il lavoro obbligatorio e questo lavoro ha cessato di essere solo una costrizione, come nei giorni in cui i lavoratori erano ancora schiavi salariati. Ora è vissuto come un dovere sociale, paragonabile a quello svolto, in un remoto periodo dell'umanità, da ogni membro della tribù per l'intera collettività. Guardate come le nostre lavoratrici, che non appartengono al partito, si affrettano ad arrivare in tempo ai sabati comunisti! Lì, scaricano legna, sgomberano la neve, cuciono uniformi dei soldati, puliscono ospedali, caserme, ecc. tuttavia, molte di loro hanno la loro famiglia a carico e tornando a casa, devono rimettersi al lavoro. Ma queste donne hanno già preso coscienza che è meglio trascurare per un po' la loro piccola famiglia e svolgere compiti più urgenti socialmente.
Probabilmente state per dirmi: "Sì, ma queste operaie e contadine che non sono iscritte al partito sono ancora solo una minoranza!". E avete assolutamente ragione. Non ce ne sono ancora molte. Ma il loro numero è in costante aumento, il che è significativo, oltre al fatto che è estremamente importante che non solo i comunisti agiscano in questo modo, ma anche le donne che non sono iscritte al partito. L'azione di questa minoranza contribuisce a educare la maggior parte delle donne. Vedete con quale passione, a volte anche con quale furia, l'operaia che non partecipa ai subbotnik difende il suo diritto a trascurare il lavoro sociale. Lei vi fornirà innumerevoli motivi per dimostrare che lei ha il diritto morale di sottrarsi a questo lavoro. Negli ultimi anni, la consapevolezza del legame tra la ricostruzione della nostra economia nazionale e la soddisfazione dei bisogni personali è così tanto rafforzata tra le donne che è difficile per loro eludere la questione. C'è carenza di legna da ardere, per esempio, mentre i vagoni col legname sono parcheggiati presso la stazione locale. È quindi necessario ricorrere a un subbotnik per scaricare i carri. Un altro esempio: scoppia un'epidemia, organizziamo un subbotnik per ripulire le strade della città. In tale emergenza, la classe operaia giudica duramente coloro che non sono disposti a contribuire al bene comune. Si vede così l'elaborarsi del codice di una nuova etica, i fondamenti di una moralità diversa all'interno della classe operaia e in particolare, la nozione di disertore del lavoro .
La società borghese condannava i lavoratori pigri e negligenti. Ma, nella concezione borghese, il lavoro rimaneva una questione privata. Lavora se vuoi, muori di fame se preferisci o cerca di costringere gli altri a lavorare per te. Quest'ultima concezione, il famoso "spirito d'impresa", è stato particolarmente apprezzato e giudicato degno di rispetto. Se la borghesia condannava i pigri, era solo nella misura in cui lavoravano non per se stessi, ma per conto di un padrone capitalista. E se, nel suo lavoro, non apportava tutta l'energia di cui era capace, "ingannava" il suo padrone, secondo la concezione borghese e gli faceva perdere una parte del suo profitto. È per questo motivo che la borghesia condannava la pigrizia e la negligenza dell'operaio. Ma il figlio del borghese o dell'aristocratico, che doveva il suo lavoro solo al suo rango o ai suoi titoli, poteva essere il buono a nulla o il fannullone più inveterato, non rischiava di subire una predica. Perché, secondo il punto di vista della borghesia, l'uomo può decidere da solo se vuole o meno lavorare, sono affari suoi, spetta a lui solo. Notate che, se un contadino proprietario lasciava la sua azienda all'abbandono o se un piccolo imprenditore precipitava con la sua impresa nel fallimento, la società borghese non li criticava per il danno che causavano all'insieme dell'economia, ma per la loro incapacità di prendersi cura dei propri interessi.
Il modo di produzione nella nostra repubblica operaia si distingue radicalmente da quello della società borghese. La pratica del nuovo modo di produzione socialista inculca ai lavoratori un altro spirito, costringendoli a pensare e sentire diversamente che in passato, e questa nuova concezione esige dai lavoratori una grande autodisciplina. Inoltre, ha portato a sviluppare nuove relazioni tra le persone e a ridefinire i rapporti dell'individuo e della collettività.
Queste nuove norme di comportamento sono l'opposto di quelle della società borghese, che regolava solo le relazioni tra gli individui, quello dell'individuo verso la comunità aveva solo un significato secondario. Nell'Impero zarista c'erano molto meno regole che definivano gli obblighi dell'uomo verso la società che regole destinate a regolare i rapporti tra le persone. Tra i doveri dell'individuo in relazione alla società borghese, c'era la difesa della patria e l'obbligo di servire lo zar. La legge, "non uccidere", era rispettata in modo molto relativo, secondo le circostanze del momento. Ma la lista dei comandamenti generati dalla necessità di difendere la proprietà privata e gli interessi particolari era di gran lunga superiore: "non ruberai; non sarai pigro; non ruberai una moglie legittima; non imbroglierai negli affari; sarai parsimonioso, ecc.»
Sotto la dittatura del proletariato, invece, le regole di condotta rimandano agli interessi della collettività: "se la tua condotta non danneggia la comunità, non riguarda nessuno." Inoltre, nella Repubblica operaia, i comportamenti che sono stati considerati nella società borghese come rispettabili sono unanimemente condannati. Qual'era, ad esempio, la moralità borghese nei confronti di un commerciante? Finché i suoi libri contabili erano in ordine, non aveva fatto bancarotta fraudolenta, non aveva apertamente ingannato i suoi clienti, il mercante era riconosciuto dalla società borghese come un "cittadino onesto" o "uomo onesto".
Durante il periodo rivoluzionario, abbiamo avuto un atteggiamento completamente diverso nei confronti dei commercianti, che poi sono diventati semplici "speculatori". Erano per noi tutt'altro che "cittadini onesti" e più spesso, venivano consegnati alla Ceka che li internava nei campi di lavoro. E perché lo facciamo? Perché sapevamo perfettamente che potevamo costruire il comunismo solo se tutti i cittadini adulti avessero svolto un lavoro produttivo. Chiunque cerchi di ottenere reddito diverso dal lavoro e che si arricchisca a spese degli altri è considerato dannoso per lo Stato e la società ed è per questo che la polizia perseguita anche azionisti, grossisti e altri trafficanti, cioè tutti gli individui che vivono come parassiti del lavoro altrui. La nostra Repubblica operaia condanna severamente questi "elementi oziosi" della società.
Il nuovo modo di produzione ha anche fatto nascere nuovi costumi. Ovviamente, non è in tre, quattro o anche dieci anni che potremo fare di tutti gli uomini degli autentici comunisti. Ma possiamo già renderci conto che nella maggior parte delle persone si manifesta una nuova coscienza, una nuova mentalità. Questa evoluzione è molto importante e non ci si può che stupire della rapidità con cui il nostro modo di pensare e di sentire si adatta alle nuove condizioni sociali (ndt 44).
Ma è nei rapporti tra i sessi che questa evoluzione è più sensibile. La stabilità della cellula familiare fu scossa durante la Prima Guerra mondiale, non solo in Russia, ma anche in altri paesi. Inizialmente, la partecipazione delle donne alla produzione è aumentata in modo significativo. Ciò ha permesso loro di ottenere una maggiore indipendenza economica e contemporaneamente ha portato ad un aumento delle nascite illegittime. Due esseri che si amavano si univano senza tener conto dei pregiudizi della società borghese, né dei precetti della Chiesa. L'aumento del numero dei figli illegittimi è divenuto un fenomeno sociale talmente diffuso che i governi borghesi hanno dovuto accordare gli stessi sostegni finanziari sia ai figli illegittimi, che ai figli legittimi.
Nell'Unione Sovietica, il matrimonio sta perdendo sempre più il suo significato. Fin dai primi mesi della Rivoluzione, il matrimonio religioso è stato abolito, come tutte le differenze legali tra figli legittimi e illegittimi. Queste misure, insieme al lavoro obbligatorio per tutti, hanno contribuito al riconoscimento delle donne come unità indipendente nella nostra società. Nella società borghese, il matrimonio è un contratto reciproco tra uomo e donna, firmato davanti a testimoni e dichiarato indissolubile e indistruttibile grazie alla benedizione divina. L'uomo si impegna a proteggere la moglie e a sostenerla; la donna, da parte sua, si impegna a preservare e difendere la ricchezza del marito, a servire lui e i suoi figli - gli eredi della sua ricchezza -, ad essergli fedele per non ingombrare la famiglia di figli illegittimi. Perché l'adulterio della donna potrebbe sbilanciare l'economia familiare. È quindi del tutto logico che la legislazione borghese perseguiti senza pietà la donna adultera, mentre il marito adultero gode di una sorprendente libertà. In definitiva, l'infedeltà del marito non danneggia gli interessi dell'economia familiare privata. Perché, allora, la società borghese perseguita la madre nubile a tal punto? La risposta è semplice. Chi si prenderà cura del bambino se una storia d'amore non è legalizzata, se non c'è stato "matrimonio"? Sia i genitori della ragazza che ha "sbagliato", il che non giova agli interessi della sua famiglia, sia le istituzioni dello Stato che devono provvedere al mantenimento del figlio. Questo è contro gli interessi dello Stato borghese, che non ama intraprendere compiti di assistenza sociale.
Inoltre, la situazione si è enormemente evoluta nella seconda metà del IX secolo, quando le donne hanno acquisito una maggiore indipendenza economica e finanziaria attraverso il loro lavoro. E' in questo periodo che l'atteggiamento della società borghese cambiò gradualmente verso la figlia-madre. Tutta una serie di romanzi e lavori scientifici ora si occupano del "diritto delle donne alla maternità" e difendono le madri nubili.
Nella nostra Repubblica operaia -almeno nelle città- oggi c'è la tendenza a sostituire l'economia familiare privata con nuove forme di vita sociale, nuove forme di consumo, come le case comuni, le mense pubbliche, ecc. La donna che lavora ottiene la propria carta alimentare e nasce una fitta rete di istituzioni sociali. Di conseguenza, il carattere del matrimonio è cambiato, l'uomo e la donna non sono più uniti dall'interesse, ma dall'inclinazione reciproca. (Ci sono ovviamente ancora eccezioni a questa regola, su cui tornerò più tardi.) Questo è il motivo per cui non è più così necessario che una coppia si sposi, dal momento che ognuno ha il diritto alla casa, al carburante, al cibo e ai vestiti, grazie ai buoni di razionamento distribuiti dalla fabbrica. L'importanza delle razioni si basa sul rendimento effettuato. Il matrimonio quindi non migliora in alcun modo la situazione dei partner.
Nella campagna, in cui la Repubblica sovietica non è ancora in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei lavoratori o di attuare il proprio programma nella pratica, la popolazione è ancora obbligata a utilizzare il libero mercato per procurarsi i beni di prima necessità. Ciò significa che l'economia familiare privata continua ad esistere come in passato. Il matrimonio continua ad essere un'impresa economica e una donna può sposare un uomo non per amore, ma per una stanza in una casa in comune. O un uomo sposare una donna perché, con una doppia razione di riscaldamento è più facile passare l'inverno! Tali fatti sono indegni e deplorevoli. Ma fino a quando la nostra Repubblica operaia non sarà riuscita ad emergere dal caos economico, non sarà possibile eliminare completamente queste sopravvivenze del passato. Tuttavia, attualmente c'è un costante calo del numero di matrimoni e un costante aumento dell'amore libero.
È vero che il decreto "sul matrimonio civile" stabilisce che in caso di incapacità al lavoro i coniugi devono provvedere al mantenimento reciproco, ma questa misura si applica ancora al periodo transitorio in cui la Repubblica operaia non è ancora in grado di estendere il tenore di vita collettivo o di prendersi cura delle persone che sono inabili al lavoro. Ma non appena la vita economica sarà riorganizzata, le istituzioni sociali funzioneranno normalmente, questa situazione regredirà da sola e il decreto a cui abbiamo appena fatto riferimento, non avrà più alcun significato nella pratica. In effetti, cosa significa "sostenere il coniuge in caso di incapacità al lavoro" quando ogni coniuge riceve la propria razione? Inoltre, in una situazione sociale normalizzata, i coniugi si rivolgerebbero all'istituzione sociale che potrebbe prendersi cura della persona malata: ospedale, sanatorio, casa per anziani o invalidi. E nessuno biasimerebbe il coniuge sano per aver messo la sua "cara metà" in un'istituzione, anche se il decreto ingiunge ai coniugi di aiutarsi a vicenda in caso di invalidità. Sembra naturale che, in una tale situazione, la società liberi uno dei coniugi dalla preoccupazione del suo partner e si prende cura di uno dei suoi membri non appena cessa di essere in grado di lavorare. Perché, mentre lavorava, ha contribuito a creare la ricchezza - le riserve - che devono essere utilizzare anche per il suo mantenimento quando è malato, anziano o invalido.
Grandi cambiamenti hanno avuto luogo davanti ai nostri occhi rispetto al matrimonio. La cosa più notevole da segnalare è che questo nuovo modo di vivere, questi diversi costumi si riflettono già in molte famiglie borghesi. Dal momento infatti in cui le donne borghesi - queste ex parassite-partecipano al lavoro sociale e si guadagnano da vivere, acquisiscono anche una posizione più indipendente nei confronti del marito. Accade anche spesso che la donna guadagni più del suo coniuge e in una situazione del genere, la moglie premurosa e sottomessa di un tempo si ritrova improvvisamente a capo della famiglia. Parte per il lavoro, mentre il marito rimane a casa, spacca la legna, accende il fuoco e va a fare il mercato. C'era un tempo in cui queste signore si innervosivano se il loro marito non le pagava il nuovo cappello o il nuovo paio di scarpe che desideravano. Ma oggi, queste donne sanno che non hanno nulla da aspettarsi dai loro mariti, motivo per cui preferiscono rivolgersi al loro capo ufficio o al direttore del rifornimento di carburante per buoni o razioni aggiuntive.
Tuttavia, per essere onesti, va aggiunto che le donne che una volta appartenevano alla classe borghese a volte hanno sopportato con più coraggio degli uomini le privazioni del periodo di transizione. Hanno imparato a conciliare il loro lavoro e la loro famiglia e hanno affrontato coraggiosamente le difficoltà della vita. In queste famiglie borghesi, si può anche notare l'emergere della razionalizzazione dei compiti domestici e la tendenza a fare uso di strutture collettive, come l'invio dei figli agli asili pubblici. In breve, stiamo anche assistendo a un allentamento dei legami familiari. Questa evoluzione può essere accentuata solo in futuro, portando con sé alla scomparsa della famiglia borghese. Al suo posto nascerà e crescerà una nuova famiglia, la comunità lavorativa. La parentela del sangue non sarà più sufficiente per saldare gli individui, saranno d'ora in poi uniti da interessi e doveri comuni.
Il nostro nuovo sistema economico e le nuove condizioni di produzione generano uno stile di vita diverso, che a sua volta crea nuove persone, veri comunisti, per spirito e volontà. Nella misura in cui il matrimonio cessa di portare benefici materiali, perde la sua stabilità. I coniugi sono separati oggi molto più facilmente che in passato. Non appena non c'è più amore o attaccamento reciproco, le persone non cercano più di stare insieme a tutti i costi o di preservare le apparenze per mantenere la coesione della famiglia. Non sono più vincolati, come in passato, da interessi domestici comuni o dai doveri dei genitori nei confronti dei bambini. Anche il rito religioso del matrimonio è sempre meno rispettato. Naturalmente, questo fenomeno non è ancora generale, questa concezione è ancora tutt'altro che diffusa ovunque, ma molte persone l'hanno già messa in pratica e continuerà a svilupparsi mentre creiamo nuovi modi di vita comunisti. Il comunismo purificherà il matrimonio da qualsiasi sopravvivenza materiale. Grazie alle mense pubbliche, la nostra Repubblica operaia ha già cercato di separare "la cucina dal matrimonio". L'intensità delle relazioni della coppia non dipendono più dalla capacità di "mettere su famiglia". In precedenza, se un uomo voleva sposarsi, doveva prima pensare se poteva permettersi un tale lusso, se poteva davvero mantenere una donna. Quindi calcolava l'entità della dote della sposa. Era solo dopo una "matura riflessione"che i due partner pianificarono di "mettere su famiglia", i più ricchi poi si comprarono una casa, i più poveri si accontentarono di un samovar. Gli sposi erano ora costretti a vivere insieme. A volte, ma raramente, l'incomprensione separava la coppia. Oggi, d'altra parte, ci sono molte coppie che si amano, tuttavia vivono separatamente.
Spesso queste coppie vengono all'anagrafe per registrare il loro matrimonio secondo il decreto del 18 dicembre 1917 e questo nonostante il fatto che i partner non vivano insieme: la moglie ad un'estremità della città, l'uomo dall'altra; la moglie a Mosca, il marito a Tashkent. Se registrano il loro matrimonio, è perché hanno bisogno di dimostrare l'un l'altro che si tratta di una "questione seria" e di giurare fedeltà eterna come tutti gli amanti. D'altra parte, si vedono solo di volta in volta, perché sia il lavoro che i compiti sociali hanno la precedenza sulla privacy. Questo tipo di matrimonio si trova soprattutto tra i membri del partito, perché, tra i comunisti, il senso del dovere sociale è già fortemente sviluppato. Ricordate che erano soprattutto le donne che una volta aspiravano a trovare una casa, perché non potevano immaginare una vita lontana dai loro focolari. Oggi, al contrario, è l'uomo che pensa che sarebbe bello avere una casa propria e una donna che sta lì e preparare i pasti. Ma le donne e naturalmente, soprattutto le operaie, non vogliono più sentire parlare della vita familiare: "non c'è modo di finire con una casa a carico, la vita familiare e tutto ciò che segue. Preferirei separarmi da lui. Perché ora posso finalmente lavorare per la società. Non c'è modo di lasciarsi ingannare. No. Meglio dividerci". Gli uomini devono accontentarsi dell'idea di essere privati della loro casa accogliente. Non tutti riescono ad accettare volentieri il cambiamento delle loro mogli e ci sono stati anche casi in cui gli uomini hanno bruciato la tessera del partito delle loro mogli, incapaci di sopportare di vederle più occupate dalle sezioni femminili che dalle loro dimore. Ma questi sono comportamenti eccezionali.
Considerando questi fatti nel processo della loro evoluzione, diventa chiaro che ora la tendenza è verso la dissoluzione della famiglia. Il nostro sviluppo economico e sociale permetterà alla comunità operaia di liberarsi gradualmente dell'ex famiglia borghese.
Il nuovo atteggiamento della società nei confronti della madre nubile è un altro fenomeno caratteristico a causa del cambiamento delle condizioni economiche e naturalmente, del fatto che le donne sono pienamente riconosciute oggi come forza autonoma. Qual è l'uomo che rifiuterebbe di sposare la donna che ama semplicemente perché questa donna non è più vergine? L''"innocenza" della ragazza era necessaria solo per il matrimonio borghese in una società basata sulla proprietà privata. Era importante essere in grado di determinare la legittimità del bambino per due motivi: in primo luogo, per garantire la trasmissione dell'eredità, poiché solo i figli legittimi potevano ereditare la proprietà della famiglia; in secondo luogo, per garantire che il mantenimento del bambino fosse curato dal padre. Nella nostra Repubblica operaia, d'altra parte, la proprietà privata non gioca più un ruolo. I genitori non hanno più una fortuna da lasciare in eredità ai loro figli. Ecco perché l'origine familiare del bambino non è molto importante, perché è il bambino stesso - il futuro lavoratore - che conta.
L'Unione Sovietica è impegnata a prendersi cura dei bambini, che provengano da un matrimonio legale o da un'unione libera. Questa evoluzione è responsabile di una nuova immagine della donna e della madre. La nostra Repubblica operaia protegge la madre e il bambino, senza prendersi cura delle circostanze in cui il bambino è venuto nel mondo. Nella pratica quotidiana, tuttavia, siamo ancora di fronte a sopravvivenze del passato. I moduli ufficiali hanno sempre la stessa domanda assurda :"sei sposato o non sposato?". Nella milizia, andiamo a chiedere perfino il certificato di matrimonio. Questi esempi mostrano quanto sia forte la morsa dei vecchi pregiudizi borghesi e quanto sia difficile per i lavoratori liberarsi delle sopravvivenze del passato. Tuttavia, sono stati compiuti notevoli progressi in questo settore. I suicidi delle future figlie-madri - molto comuni in passato - sono completamente scomparsi, così come gli omicidi dei bambini da parte di madri non sposate. La stigmatizzazione delle madri nubili è cessata; il figlio illegittimo non è più un "disonore". Nella nostra società, il matrimonio è diventato sempre più una questione privata che riguarda solo gli interessati, mentre la maternità, indipendentemente dal matrimonio, è di grande importanza sociale. La società interferisce negli affari privati di una coppia solo se uno o l'altro dei partner è malato. Ma questo problema apre un capitolo speciale ed è attualmente oggetto di un acceso dibattito al commissariato per la Salute.
I cambiamenti nel nostro atteggiamento nei confronti del matrimonio e della famiglia hanno portato a un nuovo atteggiamento nei confronti della prostituzione sessuale. La prostituzione, come praticata nella società borghese, è in forte declino nella nostra Repubblica operaia. Questa forma di prostituzione è stata una conseguenza della precaria posizione sociale delle donne e della loro dipendenza dagli uomini. Dall'introduzione del lavoro obbligatorio per tutti, la prostituzione professionale è stata ovviamente notevolmente ridotta. E dove la prostituzione continua a prevalere, è vigorosamente perseguita dalle autorità locali. Tuttavia, non combattiamo la prostituta per violazione della buona morale, ma per diserzione dal lavoro ; attraverso il suo "lavoro", la prostituta non aumenta la ricchezza sociale, ma in realtà vive sul lavoro e sulla ricchezza degli altri. Ecco perché perseguiamo la prostituzione come elemento inattivo e improduttivo della società e della prostituzione come forma di diserzione dal lavoro. A nostro avviso, la prostituta non è una creatura moralmente riprovevole, perché non c'è differenza tra il fatto che una donna venda il proprio corpo a più uomini o a uno solo, sia che sia curata dal marito legale o che sia una prostituta professionista. In entrambi i casi, queste donne vivono un lavoro non necessario nella comunità. Questo è anche il motivo per cui tutte le donne che non hanno un compito sociale o la cura per i bambini piccoli sono costrette, come lo sono le prostitute, al lavoro obbligatorio per tutti. Non distinguiamo tra una prostituta e una moglie legittima che è mantenuta da suo marito, indipendentemente dal suo grado e dal suo potere. Lo stato operaio non rimprovera una donna per aver dormito con diversi uomini, ma la rimprovera di comportarsi come una donna inattiva e di rifiutarsi di svolgere un lavoro produttivo. Questo è un atteggiamento completamente nuovo nei confronti della prostituzione ed è la prima volta che questo problema viene visto dal punto di vista della comunità dei lavoratori.
Nell'Unione Sovietica, la prostituzione è destinata a scomparire. Già, nelle grandi città come Mosca e Pietrogrado, ci sono solo poche centinaia di prostitute, mentre in passato erano 10.000. Si tratta di un grande passo avanti, ma non dobbiamo credere di aver finalmente risolto il problema della prostituzione. Gli attuali salari delle donne non garantiscono alle donne una sicurezza sufficiente. E finché, a causa della disorganizzazione economica, le donne continuano a dipendere dagli uomini, la prostituzione - aperta o mascherata- esisterà nel nostro paese. Non è una forma di prostituzione quando il segretario del soviet locale si arrende al suo superiore per ottenere una promozione o una razione speciale? Quando ancora una donna dorme con un uomo per ottenere un paio di stivali o anche, a volte, per ottenere un po' di zucchero o farina? O quando una donna sposa un uomo semplicemente perché ha una stanza in una casa comune? Non è anche una forma di prostituzione velata quando un lavoratore o una contadina si offre al controllore del treno per ottenere un posto libero? Quando una donna alla fine va a letto con il capo di una stazione di controllo per poter "passare" il suo sacco di farina ?
Questa è senza dubbio una forma di prostituzione, particolarmente dolorosa e umiliante per le donne e dannosa per l'acquisizione della coscienza sociale. Va anche aggiunto che questa forma di prostituzione è responsabile di un'ondata di malattie veneree e danneggia la salute fisica e morale della popolazione. Tuttavia, c'è una differenza significativa tra questo nuovo aspetto della prostituzione e quello vecchio. Le donne che una volta vendevano i loro corpi furono respinte e disprezzate dalla società. Gli uomini che hanno comprato prostitute professionali si consideravano autorizzati a farle fuori quando ritenevano opportuno. Le donne ovviamente non osavano lamentarsi, dal momento che la loro "carta gialla" lo rendeva un gioco molto scelto. E la donna che finora era riuscita a sfuggire ai controlli non osava protestare contro la maleducazione dell'uomo, perché non la consegnasse alla polizia e sarebbe stata costretta a essere "licenziata" come prostituta. Oggi, questa situazione è cambiata profondamente. Poiché le donne hanno il proprio libretto di lavoro, non dipendono più dalla legge di "domanda e offerta ". E se una donna accetta di avere una relazione con un uomo per motivi materiali, cerca comunque qualcuno che le piace. Il calcolo che era una parte significativa della conclusione dei matrimoni borghesi non è più una motivazione essenziale. E l'uomo non si comporta allo stesso modo con una donna a cui si è liberamente unito e con una prostituta professionista o una moglie legittima. Cerca di compiacere la sua compagna ed evita di abusare di lei, perché non se lo sarebbe lasciata fare e lo avrebbe lasciato immediatamente.
Ma finché le donne continueranno a lavorare nelle occupazioni più sottopagate, la prostituzione nella sua forma mascherata continuerà ad esistere, poiché queste donne hanno bisogno di risorse aggiuntive per poter vivere. Non importa se queste risorse derivano dalla prostituzione occasionale o se le ottengono attraverso un matrimonio "interessato".
Il nuovo corso della nostra politica economica minaccia di nuovo le donne con la disoccupazione. Questo sviluppo è già stato sentito e alla fine porterà ad una rinascita della prostituzione professionale. La nostra nuova politica economica ostacola anche lo sviluppo della nuova coscienza sociale e delle relazioni veramente comuniste tra uomini e donne. Ma non ci soffermeremo sull'analisi di questa linea politica, anche se rappresenta una battuta d'arresto e minaccia di far rivivere alcuni comportamenti passati. La classe operaia è lungimirante ed è più importante per la costruzione del comunismo che il proletariato internazionale impari ciò che abbiamo ottenuto nei primi anni della rivoluzione, nel periodo della dittatura del proletariato. E sta a voi intraprendere questa analisi.
È un fatto che il carattere del matrimonio sia cambiato, i legami familiari si sono allentati e la maternità è davvero diventata una funzione sociale. È ovvio che tutti i tentativi di cambiare i costumi, che hanno avuto luogo sotto la dittatura del proletariato, non potevano essere affrontati nella conferenza di oggi. Ritorneremo su questo argomento nella nostra prossima conferenza. Infine, vorrei ricordare che l'esperienza dei primi anni della rivoluzione ha confermato che la situazione delle donne nella società e nel matrimonio era interamente determinata dal loro ruolo nella produzione, che in realtà dipendeva dalla loro partecipazione al lavoro produttivo per l'intera società, perché il lavoro nel quadro familiare ristretto schiavizza le donne. Solo il lavoro per la collettività le libera.
* * *
ndt:
43) Per approfondire: "Critica del Programma di Gotha" Karl Marx - Conversione in html a cura del CCDP - su Resistenze.org materiali resistenti - disponibili in linea - iper-classici del marxismo
44) Per approfondire: "L'emancipazione della donna"Lenin - Editori Riuniti, 1971 Consulta il libro nella Biblioteca digitale Mels
Quattordicesima conferenza - Il lavoro delle donne oggi e domani
Concludiamo la nostra ultima conferenza con una panoramica dei cambiamenti rivoluzionari nella vita quotidiana delle donne e delle famiglie russe. Questa serie di conferenze si conclude quindi con una sorta di inventario, utile non solo al proletariato russo, ma anche al proletariato internazionale. Poiché la classe operaia, nel condurre la rivoluzione, può contare solo sulle proprie forze, in quali ambiti sociali ed economici il lavoro delle donne può essere particolarmente efficace ?
Poiché tutti i cittadini russi, indipendentemente dal sesso, devono svolgere un lavoro socialmente produttivo, la liberazione delle donne ha fatto rapidi progressi. Questo processo è stato finora limitato al proletariato industriale, mentre la popolazione rurale ne è stata difficilmente colpita. La situazione della contadina non è cambiata molto, perché l'economia familiare continua a regnare nelle campagne come in passato. La contadina è sempre l'aiuto e l'ausiliario del contadino. Inoltre, la forza muscolare umana gioca un ruolo più importante nella campagna che nella città in cui prevale la meccanizzazione. Nonostante questo, anche la vita in campagna è cambiata. Oggi ci sono otto milioni di contadine in più rispetto ai contadini. In campagna ci sono dunque otto milioni di donne che sono economicamente indipendenti dagli uomini. Queste donne hanno perso i loro mariti sia nella guerra mondiale imperialista, che nella guerra civile; oppure è rimasto a fare il soldato. La vita di queste contadine indipendenti è ovviamente cambiata, hanno necessariamente acquisito uno status diverso nel villaggio. Inoltre, i servizi di lavoro obbligatori locali sono obbligati a tenere conto dello status speciale delle vedove di guerra. La distribuzione di sementi e cibo può essere garantita solo attraverso la partecipazione delle donne. La Guerra Civile ha portato le nostre contadine fuori dalla loro passività ancestrale. Hanno preso parte attivamente alla guerra civile, specialmente in Ucraina, nelle regioni del Don e del Kuban. Come nella Rivoluzione francese, quando i contadini della Bretagna e della Normandia parteciparono alla rivolta dei girondini, i contadini ucraini sostenevano principalmente i "batjuchkas" (ndt 45). Ma dopo che i soviet locali assistettero socialmente e politicamente le donne, molte contadine simpatizzarono con il potere sovietico. Recentemente, il Partito Comunista ha organizzato conferenze e congressi per delegati operaie e contadine in tutte le province. Le sezioni femminili del partito hanno istituito corsi di formazione per facilitare la vita quotidiana delle contadine. E' così che le contadine iniziano non solo a riflettere sulla loro vita passata, ma anche a rendersi conto che la Rivoluzione d'ottobre ha portato loro le condizioni per la loro emancipazione. La forza attraente delle grandi città è sempre più sentita, in particolare in termini di opportunità di formazione che offrono. A proposito, solo all'Università di Sverdlov, ci sono già 58 contadine su 402 studenti che partecipano a questo ciclo di lezioni. Nelle scuole di partito, la partecipazione delle donne ai corsi organizzati dal soviet locale è ancora maggiore. Le varie facoltà operaie comprendono tra il 10 e il 15% degli studenti e studentesse di origine contadina. Ciò che colpisce è anche la crescente rappresentatività delle donne contadine nei consigli operai e contadini della provincia. Nei primi anni dopo la rivoluzione, non c'erano assolutamente donne contadine rappresentate nei consigli. Oggi, i consigli locali includono già più contadine che operaie, ma nessuna contadina partecipa ancora al Congresso dei soviet di tutta la Russia.
Ovunque il Partito Comunista non sia ancora riuscito a stabilirsi saldamente tra la popolazione, le contadine sono già le sostenitenitrici più fiduciose del comunismo rispetto ai contadini. Il che non è difficile da capire, perché il contadino è sia Signore che padrone a casa e unico proprietario della fattoria. Naturalmente, il contadino difende la tradizione che tutti i membri della fattoria, incluso il contadino, sono obbligati a sottomettersi alla volontà del padrone di casa. E poiché il contadino si rende conto che le nuove condizioni di vita sono lontane dal rafforzare la sua posizione nella famiglia, rimane piuttosto in attesa o si mostra decisamente ostile verso il comunismo. Per la contadina, al contrario, le cooperative, quelle lattiero-casearie, sono particolarmente benvenute. Inoltre, la loro vita quotidiana è facilitata da strutture collettive come asili, panetterie e lavanderie pubbliche. Questo spiega anche perché le contadine sono più in grado di capire lo scopo del comunismo rispetto ai contadini. Il miglioramento concreto della loro vita le rende entusiaste sostenitrici del comunismo in campagna.
Prima della Rivoluzione d'ottobre, non c'era per così dire nessun divorzio. A volte un uomo abbandonava sua moglie, ma il fatto che una donna abbandonasse suo marito era così raro ed eccezionale che feaceva scalpore nel villaggio. Ma, poiché i divorzi sono stati notevolmente facilitati dal decreto del 1917, non sono più rari come una volta, specialmente tra le giovani generazioni. Ciò dimostra che, anche in campagna, anche l'istituzione apparentemente incrollabile della famiglia ha iniziato a vacillare sulle sue fondamenta. Se una contadina lascia il marito oggi, non provoca più proteste generali nella comunità del villaggio. Le contadine che partecipano all'agricoltura di tipo comunista e diventano membri eletti di un consiglio locale hanno maggiori probabilità di superare i pregiudizi tradizionali sull'inferiorità delle donne e quindi di far avanzare l'emancipazione delle donne nelle campagne. Questo sviluppo sarà accelerato anche dalla meccanizzazione dell'agricoltura, dall'installazione dell'elettricità e dalla moltiplicazione delle cooperative agricole. Non appena sarà raggiunto un certo livello tecnico, verranno create le condizioni per cambiare stile di vita e pensiero e anche per l'emancipazione finale delle donne.
Il nuovo percorso intrapreso recentemente dalla politica economica, tuttavia, minaccia seriamente lo sviluppo iniziato, respingendo l'emancipazione delle donne e ostacolando lo sviluppo di nuove forme di vita, nuove relazioni tra i sessi, basate sulla stima reciproca e sull'attrazione e non sull'interesse e sul calcolo. Ecco perché è così importante elencare le modifiche apportate durante questi primi anni della Rivoluzione. La registrazione di queste esperienze e lo studio di queste nuove forme di vita saranno certamente estremamente utili per il futuro e forniranno al proletariato mondiale un'importante documentazione su questo periodo che certamente lo aiuterà a continuare il lavoro intrapreso dagli operai della Russia. Così, anche se iniziamo oggi un oscuro periodo di stagnazione, gli eventi che si sono verificati dalla Rivoluzione d'ottobre del 1917 lasceranno una traccia indelebile nella storia dell'umanità e in particolare, nella storia delle donne. Finché lo sviluppo di nuove forme di vita rimarrà bloccato nella pratica, le sezioni delle nostre donne dovranno registrare i cambiamenti nelle abitudini e nelle mentalità e comunicarle a grandi sezioni della popolazione al fine di elevare il loro livello di coscienza al livello dell'avanguardia del proletariato. Le sezioni femminili devono, inoltre, concentrare la loro propaganda ai lavoratori di tutti i paesi sulle esperienze pratiche che abbiamo appena vissuto e convincerli che la liberazione delle donne può essere raggiunta, nel periodo di transizione al comunismo. Perché è un dato di fatto, la Rivoluzione russa ha gettato le basi, sia teoriche che pratiche, per la liberazione delle donne. L'Unione Sovietica fu il primo governo a proteggere madre e figlio. Abbiamo creato le condizioni che ci permettono di eliminare la prostituzione - questa triste sopravvivenza della società borghese. La famiglia, come era esistita fino ad allora, fu sostituita nella Repubblica Sovietica da una famiglia diversa, più libera, più sana e più flessibile. La Rivoluzione russa ha liberato le nostre donne e non dobbiamo dimenticare che è stato tanto il lavoro delle operaie e delle contadine quanto quello degli operai e dei contadini. Mentre le operaie e le contadine svolgevano un ruolo importante all'inizio della Rivoluzione - ricordiamo il loro storico ingresso al Congresso Internazionale delle lavoratrici il 23 febbraio 1917 - continuarono a partecipare attivamente al processo rivoluzionario impegnandosi nella guerra civile.
Ma voi conoscete perfettamente tutti questi fatti, perché fanno già parte della storia del movimento proletario femminile e della storia del nostro partito. Tuttavia, vorrei sottolineare ancora una volta che non esiste un'area in cui le operaie e le contadine non abbiano partecipato attivamente fin dai primi momenti della Rivoluzione. L'elenco delle donne che hanno combattuto valorosamente per l'Unione Sovietica è lunga. Già nel periodo di Kerensky troviamo donne - operaie e contadine - tra i membri dei primi consigli. Fu anche il primo governo al mondo in cui furono elette le donne: ddal primo mese dopo la presa del potere da parte di operai e contadini, una donna fu nominata commissario popolare per l'assistenza sociale. In Ucraina e fino all'autunno del 1921, la compagna Majorova occupava una posizione simile e nelle province ci sono molte donne commissari, operaie e contadine, provenienti direttamente dalla produzione. Tra queste,e per citarne solo alcune, le compagne Klimova, Nikolajeva, Tjernysjeva, Kalygina e Lkrjanistova, una generazione di lavoratrici nate nel fuoco dell'azione rivoluzionaria. Senza la partecipazione attiva delle operaie e delle contadine, la Repubblica dei Soviet non sarebbe stata in grado di realizzare i progetti sviluppati dall'avanguardia del proletariato e sarebbe stata incapace di istituire e preservare le istituzioni attuali.
I futuri storici conserveranno questa caratteristica che permetterà loro di tracciare una chiara distinzione tra la rivoluzione d'Ottobre e la Rivoluzione francese del 1789. Il I° Congresso delle operaie e delle contadine di tutta la Russia nel novembre 1918 ha dato prova tangibile dell'enorme sostegno che le donne hanno portato alla Rivoluzione. Questo Congresso, convocato molto rapidamente per iniziativa delle sezioni femminili del partito e preparato da una quindicina di compagne, ha trovato un'eco molto importante tra le lavoratrici: 1.147 delegate sono venuti da tutte le province della Russia nonostante i preparativi estremamente affrettati (appena un mese prima della riunione del Congresso). Questa è la prova indiscutibile che la rivoluzione ha tirato fuori le donne dalla loro letargia secolare e che hanno definitivamente smesso di giocare alla "Bella Addormentata". Per descrivere il ruolo delle donne nel processo rivoluzionario, dobbiamo solo analizzare il seguente esempio: la partecipazione attiva delle operaie e delle contadine alla difesa militare della Rivoluzione. Questo impegno, secondo alcuni, non era in alcun modo parte dei doveri tradizionali delle donne. Tuttavia, la loro coscienza di classe, molto sviluppata, portò queste operaie e contadine a sostenere attivamente l'Armata Rossa e a combattere a fianco dei rivoluzionari durante la Rivoluzione d'ottobre. Hanno organizzato cucine a rotazione, distaccamenti sanitari e centri di cura. La Russia rivoluzionaria ha dimostrato il suo nuovo atteggiamento nei confronti delle donne accettando di arruolarle nell'esercito (ndt 46). D'altra parte, la borghesia ha sempre affermato che il ruolo delle donne è quello di mantenere la casa, mentre l'uomo, per sua natura, è stato chiamato a difenderla, cioè, meno poeticamente, a garantire la difesa dello Stato. Secondo le concezioni della borghesia, la professione d'armi è solo una questione di uomini. La soldatessa non è adatta alla borghesia, una tale concezione "innaturale" equivarrebbe a scuotere le fondamenta della famiglia borghese. Ma lo Stato operaio ha una visione completamente diversa sulla questione, poiché, durante il periodo della guerra civile, il lavoro socialmente utile era strettamente legato al dovere di difendere lo stato sovietico.
Per garantire lo sviluppo delle forze produttive, lo stato comunista aveva bisogno della partecipazione di tutti i cittadini. Ecco perché i comunisti non potevano rinunciare alla partecipazione delle donne. La lotta del proletariato contro la dittatura della borghesia richiedeva anche il coinvolgimento delle operaie e delle contadine nell'esercito e nella Marina. Questo impegno delle donne non è stato il risultato, come per i governi borghesi, di decisioni più o meno militari, ma piuttosto il risultato della lotta per l'esistenza e la sopravvivenza della classe operaia. Più lavoratori aveva impiegati in compiti militari, più possibilità l'Esercito Rivoluzionario aveva di vincere. E la vittoria dell'Armata Rossa dipendeva dalla partecipazione attiva delle operaie e delle contadine. Questa vittoria fu allo stesso tempo la condizione indispensabile per la liberazione della donna, garantendole i diritti vinti dalla Rivoluzione d'ottobre. Sarebbe quindi sbagliato considerare l'impegno delle operaie e delle contadine solo da un punto di vista produttivista, che dimenticherebbe le ripercussioni a lungo termine di questa mobilitazione sulla coscienza delle donne. Se la Rivoluzione d'ottobre si proponeva di respingere le tradizionali ingiustizie di genere, la partecipazione delle donne alla Guerra Rivoluzionaria finì per abbattere gli ultimi pregiudizi contro questi. Il coinvolgimento delle nostre donne nell'esercito ha certamente contribuito notevolmente a rafforzare la nostra comprensione delle donne come membro a pieno titolo della società umana. L'immagine della donna come complemento e appendice degli uomini, così come l'istituzione della proprietà privata e la dittatura della borghesia sono quindi destinate ad essere relegate nella pattumiera della storia.
Il lavoro delle donne comuniste consisteva principalmente nel condurre campagne di agitazione nell'ambito dei comitati rivoluzionari dell'esercito. Le operaie e le contadine occuparono quindi principalmente posizioni politiche nell'Armata Rossa. Negli anni 1919-1920, 6.000 operaie e contadine eseguirono questi compiti. Ma le donne si occupavano anche della posta e lavoravano come segretarie nei servizi amministrativi militari. In alcuni luoghi le donne combatterono direttamente al fronte a fianco dei soldati. Ma questi casi erano eccezionali e lontani dalla regola. Molte studentesse stanno attualmente frequentando i nostri corsi di formazione da ufficiale, una donna sta anche conseguendo studi superiori di stato-maggiore. Solo nel 1920, c'erano 5.000 operaie e contadine che seguivano questi corsi. Nessuna campagna di mobilitazione ha avuto luogo senza la partecipazione delle operaie e delle contadine. Le donne si prendevano cura anche di soldati malati o feriti negli ospedali militari, raccoglievano vestiti per la truppa e partecipavano alla lotta contro i disertori. Le donne hanno difeso con fervore la Rivoluzione, specialmente nei grandi agglomerati industriali. La loro coscienza di classe ha permesso loro di stabilire una relazione dialettica tra la liberazione della donna e la vittoria militare al fronte. Fu soprattutto nel periodo critico della Guerra Civile, quando le conquiste della rivoluzione furono davvero minacciate, che le donne operaie diedero un importante contributo alla difesa della Russia Sovietica attraverso il loro massiccio impegno. Questo periodo critico fu segnato, ad esempio, dagli attacchi dell'esercito nemico nella regione di Don e Lugansk nel 1919, così come dall'offensiva bianca contro Pietrogrado guidata dai generali Denikin e Youdenich nel 1920. Nelle vicinanze della città industriale Ucraina di Lugansk, la vittoria si è raggiunta solo grazie alla partecipazione alle lotte delle operaie e degli operai della città. Durante l'attacco del generale Denikin a Tula, lo slogan delle operaie era: "se Denikin vuole arrivare a Mosca, dovrà scavalcare i nostri cadaveri" hanno combattuto al fronte, scavato trincee ed erano responsabili del servizio di intelligence. Il ruolo delle operae durante la difesa militare di Pietrogrado contro le truppe del generale Yudenich è ora noto all'unanimità. Migliaia di lavoratrici hanno combattuto in sezioni di mitragliatrici, servizi di intelligence e spionaggio. Queste donne si sacrificarono per scavare trincee in un terribile clima autunnale e circondarono la città con una rete di filo spinato. Sorvegliavano i posti di blocco, impedendo la fuga dei disertori, che, alla vista di queste donne armate, pronte a combattere e persino a morire, si vergognavano e si sentivano moralmente obbligati a tornare al loro posto.
Se, durante la difesa militare della Repubblica Sovietica, le donne svolgevano un ruolo militare secondario, il loro ruolo morale, d'altra parte, era molto importante. Le donne hanno svolto un ruolo di primo piano in altre aree della nostra repubblica sovietica. Lasceremo agli storici decidere quale fosse il contributo esatto delle donne nella sfera sociale e in particolare, nell'organizzazione della protezione materna. Nonostante il caos economico e il fatto che la classe operaia non avesse ancora un proprio apparato amministrativo, il governo è stato in grado di lanciare questo enorme progetto. Il che non sarebbe stato possibile se le nostre donne fossero state mal disposte verso di lui e se avessero sabotato suoi sforzi. Al contrario, la nostra collaborazione con le operaie e le contadine è stata particolarmente fruttuosa, soprattutto nelle aree che hanno colpito direttamente la liberazione delle donne.
Ci sono anche molte donne che collaborano attivamente in altri settori della società : nell'istruzione, nei soviet, nei Commissariati del popolo, nei consigli superiori dell'economia nazionale, così come nelle innumerevoli amministrazioni statali. Ma nel periodo successivo alla Rivoluzione d'ottobre, la maggior parte delle operaie e delle contadine era più interessata a compiti più adatti alla loro esperienza e che potevano anche svolgere meglio, come quelli legati al problema della maternità.
Le donne hanno lavorato efficacemente nelle istituzioni sociali per l'assistenza materna, l'educazione degli adulti e le mense pubbliche. D'altra parte, c'erano pochissime donne che lavoravano nei servizi per la casa. Le nostre donne ovviamente non capivano che la soluzione del problema abitativo era altrettanto importante per la liberazione della donna quanto l'installazione di mense pubbliche. Le commissioni speciali per l'agitazione e la propaganda per le donne, che attualmente appartengono alle sezioni femminili del partito, si erano limitate a mobilitare operaie e contadine per specifici compiti sociali, poiché ritenevano che fosse necessario prima sviluppare il lavoro collettivo delle donne in aree a loro già note. Successivamente, abbiamo esteso il nostro impegno femminile ad altri settori della società.
Il giorno dopo la Rivoluzione d'ottobre, quindi, la maggior parte delle donne ha lavorato allo sviluppo di nuove forme di vita. Accolsero con entusiasmo la possibilità di liberarsi dalla loro esistenza di schiave e si impegnarono risolutamente nell'attuazione del programma della Repubblica Sovietica. Senza di loro, questo non sarebbe potuto nascere. C'era una sorta di divisione naturale dei compiti. Le donne lavoravano preferibilmente nei settori sociali a loro familiari, occupandosi del problema della maternità o dell'organizzazione della vita quotidiana, del lavoro. In queste aree, le donne hanno spesso avuto l'iniziativa. Ma in altri settori dell'apparato statale gli uomini hanno mantenuto la loro posizione dominante, con le donne che sono rimaste loro subordinate, con eccezioni, naturalmente. Questa divisione del lavoro, tuttavia, non divideva il proletariato in base al genere, ma al contrario portava al rafforzamento in modo del tutto normale e accettabile delle iniziative di ciascuno nei diversi campi sociali. Ciò non significa che le donne non siano in grado di lavorare al di fuori dei settori sociali ed educativi. Viceversa. Conosciamo il ruolo estremamente importante svolto dalle operaie e dalle contadine nel processo rivoluzionario e nella ricostruzione economica. Perché senza la collaborazione attiva delle lavoratrici, la nostra lotta contro i controrivoluzionari e gli speculatori non sarebbe andata così in modo soddisfacente. Non è forse vero che le epidemie potevano essere controllate solo dall'intervento di operaie e contadine? Allo stesso modo, le varie campagne in campo economico e sociale sono state efficaci solo grazie all'impegno volontario e a lungo termine della maggior parte delle operaie e delle contadine. Tuttavia resta il fatto che nella ricerca di nuovi modi di vita e di pensiero, le donne hanno svolto spontaneamente compiti che, pur fornendo una soluzione ai loro problemi, hanno anche rafforzato la comunità. Gli esperimenti condotti dopo la Rivoluzione d'ottobre tendono a dimostrare che questa divisione del lavoro tra i sessi basata sull'esperienza storica del proletariato e sulla ragione più elementare, era in definitiva quella giusta. Perché proprio perché le donne lavoravano nei campi a loro particolarmente familiari - mense pubbliche, case di protezione materna, asili nido - i loro interventi erano così efficaci e potevano così aiutare la repubblica sovietica nel suo pesante compito di ricostruzione. Nell'attuale fase della dittatura del proletariato e ancor meno di prima, le donne proletarie non possono impegnarsi in una lotta per i principi astratti del femminismo, cioè per l'uguaglianza astratta. Una pianificazione seria nell'Unione Sovietica deve, al contrario, tenere conto delle capacità morali e fisiche delle donne e distribuire i vari compiti tra i sessi in modo tale che il piano sia più adatto a servire gli interessi collettivi. Poiché, nel periodo della dittatura del proletariato, le nostre operaie e contadine non possono lottare per l'uguaglianza in se stessa, ma devono garantire che la forza lavoro femminile sia utilizzata in modo efficace e che sia assicurata la protezione materna.
Le compagne di altri paesi devono essere in grado di utilizzare le esperienze della Rivoluzione russa. Quando il proletariato dominante si impegna a sviluppare nuove forme di vita, ha bisogno non solo di specialisti con le conoscenze necessarie nei vari campi della produzione e della difesa militare, ma anche di donne che sappiano sviluppare queste nuove forme di vita, come creare e organizzare vivai, asili, mense, ecc., in breve donne che sanno come promuovere relazioni diverse tra uomini e che hanno sperimentato le migliori forme di vita collettiva. Senza le donne, il proletariato non è in grado di sviluppare nuove forme di vita. Il proletariato internazionale deve quindi, soprattutto, sottolineare l'educazione delle donne nello spirito Comunista. Ma il lavoro delle donne non può essere solo un affare delle donne. Nell'Unione Sovietica, attualmente stiamo vivendo un rafforzamento della lotta di classe. Non è sufficiente proporre alcune riforme, ma piuttosto un completo sconvolgimento dell'economia e delle mentalità nazionali. L'uso ragionevole e pianificato della forza lavoro femminile nella ricostruzione industriale e nel lavoro sociale è una delle questioni politiche chiave. I nemici del proletariato lo sanno molto bene, quando i vari governi borghesi sono improvvisamente molto ansiosi verso le donne distribuendo loro le loro elemosine - sotto forma di uguaglianza politica e riforma del diritto matrimoniale. Queste riforme hanno lo scopo di placare l'insoddisfazione delle donne e offuscare le loro menti critiche. Il nostro contrattacco sarà quello di rafforzare il lavoro internazionale delle donne; il Segretariato femminile dell'Internazionale Comunista ci sta già lavorando. Non dobbiamo perdere di vista il fatto che il proletariato di entrambi i sessi ha interessi comuni; sottolineeremo quindi la solidarietà e gli obiettivi comuni del movimento operaio, ma senza dimenticare la posizione speciale della donna, derivante dal suo ruolo sociale di madre. Lo Stato operaio deve avvalersi della forza lavoro femminile affinché le donne possano sviluppare le loro capacità nei settori che meglio corrispondono alla loro esperienza, senza dimenticare, tuttavia, che la donna non solo rappresenta una forza lavoro, ma ha anche una funzione da svolgere come madre. Perché le donne, se lavorano fianco a fianco con gli uomini, hanno un'ulteriore funzione sociale, quella di dare vita a nuovi cittadini, di generare nuova forza lavoro. Questo è anche il motivo per cui lo Stato della classe operaia è obbligato a prendersi cura in maniera speciale delle donne. Nella fase della dittatura del proletariato, non è necessario raggiungere la piena uguaglianza di genere, ma impiegare la forza lavoro femminile per compiti ragionevoli e organizzare un sistema coerente di protezione materna.
Nel sistema capitalista, basato sulla proprietà privata, strettamente connesso al consumo della piccola unità familiare, la donna è condannata al lavoro improduttivo dell'economia domestica. Anche se i governi borghesi dei paesi capitalisti si dichiarano ora pronti a concedere alle donne l'uguaglianza legale formale e altre elemosine dello stesso tipo, la loro liberazione in questo contesto non è tuttavia possibile. L'esempio dell'Unione Sovietica ci mostra che solo un cambiamento radicale nel ruolo delle donne nel processo di produzione e di conseguenza in tutte le altre sfere sociali, può creare le basi per la liberazione delle donne.
Concluderemo quindi questa serie di lezioni su questi argomenti. Spero che alla fine di queste quattordici sessioni vi sia chiaro che la situazione delle donne e dei loro diritti nella società dipendono dal loro ruolo nella produzione. È anche per questo motivo che la "questione femminile" non può essere risolta all'interno del capitalismo. Nella repubblica sovietica, d'altra parte, questo problema delle donne può trovare una soluzione, perché tutte le donne adulte e normodotate svolgono un lavoro utile alla società e partecipano alla costruzione di un'economia comunista e allo sviluppo di nuove forme di vita. Voi che lavorerete con le donne della Russia devete essere persuase di quanto segue: anche se ci sono ancora operaie e contadine russe che vivono una vita da schiave, ora possono sperare di uscire da questa triste situazione. Poiché mentre sviluppiamo nuove forme di produzione e nuove forme di vita, le donne saranno in grado di liberarsi dalle loro barriere secolari e rifiutare la loro schiavitù. La Rivoluzione d'Ottobre offre alle nostre lavoratrici una reale possibilità di liberazione. Ora spetta alle donne realizzare questa possibilità, ora dipende dalla propria volontà e abilità. Spetta a loro determinare cosa resta da fare. Ma le fondamenta per la loro liberazione sono state poste. La strada è stata aperta. Cosa resta esattamente da fare? Costruire! Costruire! Costruire! La dittatura della proprietà privata ha ridotto la donna in schiavitù per secoli. Grazie alla dittatura del proletariato, le donne possono ora conquistare la loro libertà.
* * *
ndt:
45) Significa "vecchi contadini" parola usata dai bolscevichi per riferirsi ai sostenitori di Makhno - Nota a margine dell'editore: pag.252 "Conférences sur la libération des femmes - 14e Conference - Le travail des femmes aujourd'hui et demain", Éditions "La Brèche", 1978
46) Il processo di assorbimento delle donne nell'esercito si evolse in modo esponenziale anche a livello qualititivo, portando, più avanti, nella lotta contro il fascismo, esempi notevoli. Si legga: Le "Streghe della notte" - Wladimir Abreu - Traduzione per Resistenze.org a cura del Centro di Cultura e Documentazione Popolare
